La fine della storia – Luis Sepúlveda
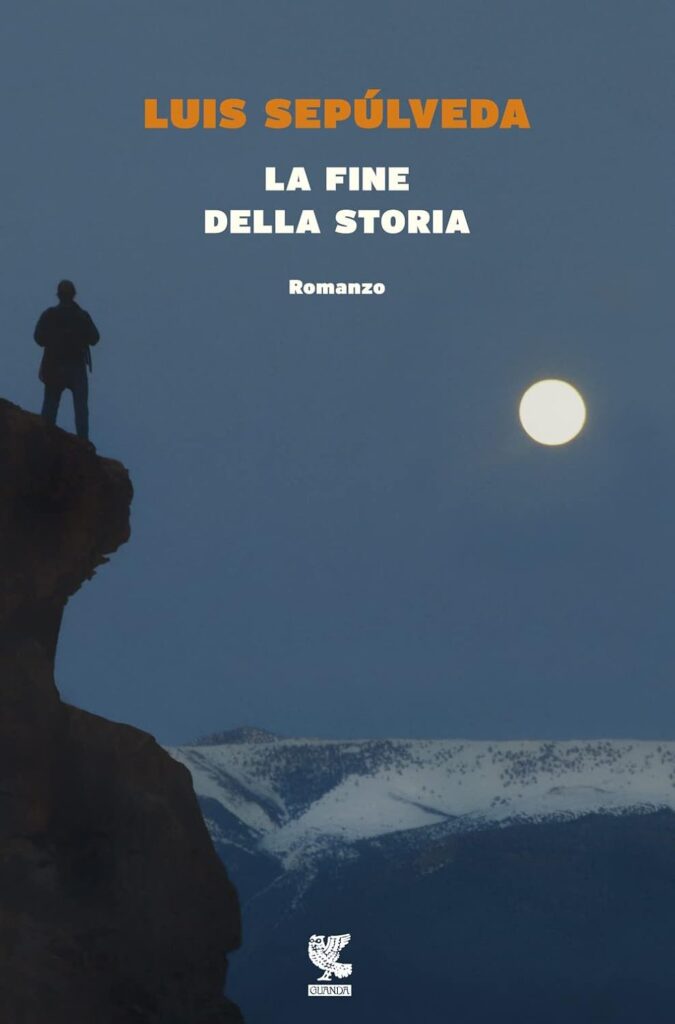
SINTESI DEL LIBRO:
Egregi compagni,
so che avete intenzione di illustrare la copertina del prossimo
numero di «The Liberator» con un ritratto di Lev Trockij e mi sembra
un giusto omaggio. Un mese fa vi inviai una cronaca degli ultimi
combattimenti di Pietrogrado, città assediata dalle truppe bianche
del generale Judenič e dai cosacchi dell’atamano Pëtr Nikolaevič
Krasnov. Trockij, al comando delle forze del nuovissimo esercito
rosso, è riuscito a instaurare il potere dei Soviet nella città che è
stata la culla della rivoluzione proprio alla vigilia del suo secondo
anniversario, consolidando definitivamente il governo del Soviet
degli operai, dei contadini, degli studenti e dei soldati, dal Baltico alla
Crimea.
Poco prima che Lenin ci raggiungesse per festeggiare insieme la
vittoria, mi trovai a fianco di Trockij in una situazione che sarà la
Storia a giudicare: davanti al Primo commissario del popolo fu
condotto l’atamano Krasnov, un cosacco sconfitto, con le membra
tremanti e l’aria supplichevole, che non osava guardare negli occhi il
vincitore e non faceva che gemere implorando pietà. Non restava
nulla dell’altezzoso atamano dei cosacchi del Don che aveva giurato
di ammazzare tutti i bolscevichi di Pietrogrado.
Dalla Prospettiva Nevskij arrivavano le grida che chiedevano la
morte dell’atamano e Trockij si limitò a osservarlo in silenzio, con
un’espressione seria ma non priva di compassione per lo sconfitto. A
un ordine del Primo commissario del popolo, un soldato rosso mise
sul tavolo una fotografia agghiacciante in cui si vedevano una
cinquantina di operai impiccati dalle truppe cosacche a
Ekaterinoslav, e costrinse l’atamano a guardarla.
Il cosacco esitò, stava per accasciarsi a terra e due soldati rossi
dovettero sorreggerlo. Aveva davanti una prova irrefutabile dei tanti
crimini commessi contro il popolo russo e in quell’istante capì che lo
aspettava il plotone di esecuzione, ma Trockij lo tranquillizzò con
queste testuali parole: «Pëtr Nikolaevič, vi impegnate a cessare ogni
attacco contro il potere sovietico? Date la vostra parola d’onore che
tornerete pacificamente nella vostra terra e non alzerete mai più le
armi cosacche contro il Soviet degli operai, dei contadini, degli
studenti e dei soldati?»
Pëtr Nikolaevič Krasnov, l’atamano dei cosacchi del Don, annuì
più volte e con parole soffocate dal pianto mormorò la sua
gratitudine per avere avuto salva la vita, poi fu condotto via sotto
scorta da due soldati rossi.
Nell’ampia sala dell’Istituto Smol’nyj restammo soltanto il Primo
commissario del popolo e io. Trockij, evidentemente, intuì le
domande che volevo fargli e mi anticipò dicendo: «Nulla avrebbe
rafforzato la controrivoluzione quanto un martire del calibro
dell’atamano dei cosacchi. Nulla la indebolirà più di questa sconfitta
senza onore».
Sarà la storia a giudicare se Lev Davidovič Bronštejn, Trockij, ha
fatto bene a graziare l’atamano.
John Reed
2
33º Latitudine Sud
Erano vent’anni che non mettevo piede in quella città dalle estati
infernali e non avevo nessuna intenzione di fermarmi più a lungo del
necessario. Stavo andando a un appuntamento che non avevo
cercato né voluto, e ci stavo andando perché non si sfugge alla
propria ombra. Non importa dove stiamo andando, l’ombra di ciò che
abbiamo fatto e siamo stati ci perseguita con la tenacia di una
maledizione.
Diedi al tassista l’indirizzo dell’albergo e mi sistemai sul sedile
posteriore deciso a godermi l’aria condizionata, pregando che non
mi toccasse un tassista loquace, ma non ebbi fortuna. Appena partì,
cominciò a inveire contro la presidente dandole la colpa perfino del
caldo di febbraio.
«Meno male che se ne va. Sa perché l’hanno eletta presidente?»
domandò girando a mezzo la testa.
«Suppongo che me lo dirà comunque.»
«Perché è una donna, una comunista, oltre che, ovviamente, la
figlia di Bachelet. Ma ora arriva un presidente come si deve, uno in
grado di guidare il paese, uno che è ricco e che sa fare affari, uno
come me, un imprenditore.»
Ci sono tipi che sembrano proprio supplicarti di infilargli in bocca la
canna di una pistola e di costringerli a scegliere tra una pallottola e il
silenzio, ma io ero appena arrivato e non avevo un’arma con me. La
macchina era di marca coreana, imitazione di un’auto di alta gamma,
con l’immancabile deodorante a forma di abete appeso allo
specchietto retrovisore.
«Lei sa chi era il padre della presidente?» attaccò il tassista.
«Suppongo che me lo dirà anche se non glielo chiedo.»
«Un altro comunista» sentenziò lui lanciando un’occhiata piena di
rabbia al giornale che stava sul sedile accanto al suo. Sulla prima
pagina c’era la presidente che a breve avrebbe lasciato la carica,
vestita di bianco e con la fascia tricolore di traverso sul petto.
Sorrideva con l’aria di scusarsi per questo paese di emeriti cretini.
Sì, l’unico approccio pedagogico efficace sarebbe stato infilare in
bocca al tizio la canna di una pistola e ricordargli che Alberto
Bachelet era stato un generale dell’Aeronautica leale ad Allende e
che aveva pagato a caro prezzo quella lealtà: era stato pestato,
insultato, torturato e assassinato dai suoi stessi commilitoni.
«È venuto a Santiago per affari?» domandò il tassista.
«No, sono un chirurgo. Esperto di lobotomia.»
«E che roba è? Scusi l’ignoranza.»
«Apro la zucca a tutti i dementi che mi capitano sotto mano e tiro
via tutta la merda che gli impedisce di pensare. Mi passi il giornale.»
Evidentemente il tassista afferrò l’allusione perché chiuse la
bocca. Il taxi viaggiava su un’autostrada a me sconosciuta, lungo il
fiume Mapocho sorgevano i vecchi quartieri poveri battuti dal sole
spietato di febbraio e sotto la cappa di smog grigiastro si
delineavano le sagome dei palazzi più alti della città.
Guardando la foto sul giornale ricordai un altro uomo nobile e
leale, Luis Lorca: un giorno del 1971 mi aveva indicato una ragazza
bionda, piccoletta, con indosso un’uniforme da liceale, che
capeggiava una marcia di protesta della Juventud Socialista.
«È la figlia del generale Bachelet, due compagni del servizio di
sicurezza devono diventare la sua ombra, bisogna proteggerla»
aveva detto Luis Lorca, e a ragione. All’epoca i paramilitari di
estrema destra erano parecchio aggressivi e noi, be’, restituivamo
colpo su colpo.
In albergo mi diedero la tessera magnetica della camera e una
volta dentro controllai i cassetti, aprii le porte, osservai la strada fuori
dalla
finestra
cercando
qualcosa
d’inspiegabile,
spinto
semplicemente dalla forza dell’abitudine. Sono un uomo della
seconda metà del Novecento, di quelli che dormono poco e che,
senza aver mai letto Lobsang Rampa, hanno un terzo occhio sulla
nuca. Studiai subito la piantina dell’albergo che avevo preso alla
reception, memorizzai le possibili vie di fuga e poi, avendo ancora un
paio d’ore prima di andare all’appuntamento, mi sdraiai sul letto.
Invece di sentirmi stanco per la levataccia e il caldo, avevo i
muscoli tesi, all’erta, come ai vecchi tempi, quando la città era una
trappola, e per scacciare quelle brutte bestie dei ricordi chiusi gli
occhi e ripensai a tutto ciò che era successo negli ultimi giorni.
La telefonata che mi aveva strappato alla tranquillità di Puerto
Carmen, nella parte più meridionale dell’isola di Chiloé, mi era
arrivata con l’eco inconfondibile delle minacce. Non ho cellulare né
computer collegati a Internet, nulla che possa essere tracciato, ma
ormai nessuno può sottrarsi all’occhio del Big Brother che ci
sorveglia dallo spazio. Basta sedersi davanti a uno schermo, digitare
Google Earth e il movimento del cursore su un continente, un paese,
una regione, una città, un quartiere, ci mostra fin nei minimi dettagli
l’intimità più recente del tizio che stiamo cercando. Suppongo che
Kramer mi avesse trovato così.
Mi credevo al sicuro a Puerto Carmen, a spaccare legna con
l’aiuto del Petiso, in modo da avere una bella provvista di caldo per
l’interminabile inverno australe. Non desideravo altro che guardare il
mare con Verónica stretta al braccio, sentendo il suo sguardo che
passava dalla riva alle prime onde, e di lì alle isole Cailín e Laitec,
fino a raggiungere la riva vaga della Patagonia continentale. A quel
punto le sue pupille cercano sempre la cima innevata del vulcano e
si fermano impassibili, immuni alle mie promesse di attraversare un
giorno il canale e navigare fino al golfo di Corcovado per vedere le
balene azzurre che si accoppiano in quelle acque.
Il Petiso e io stavamo approfittando del bel tempo di febbraio, di
quelle giornate lunghe, per spaccare la legna e riparare l’attrezzatura
da pesca mentre Verónica prendeva il sole, quando i miei due
pastori tedeschi, Zarco e Laika, sentirono il rumore di un veicolo che
si avvicinava. I due cani rizzarono il pelo sul dorso, attaccarono a
ringhiare e si sedettero vicino a Verónica per proteggerla. Dopo
pochi minuti vedemmo spuntare la Land Rover dalla strada costiera.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :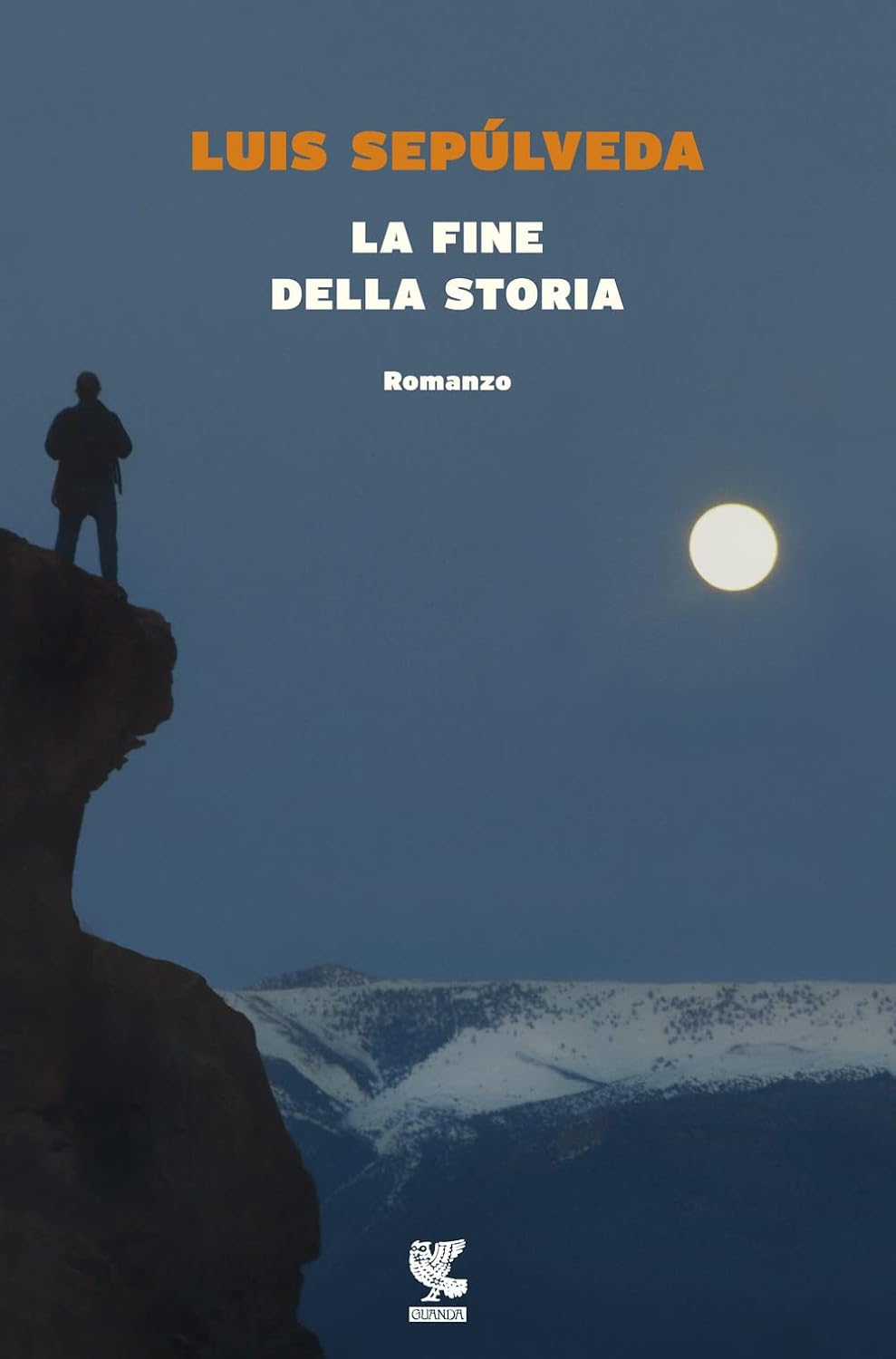






1 commento