La donna cardinale – Cristina Stillitano
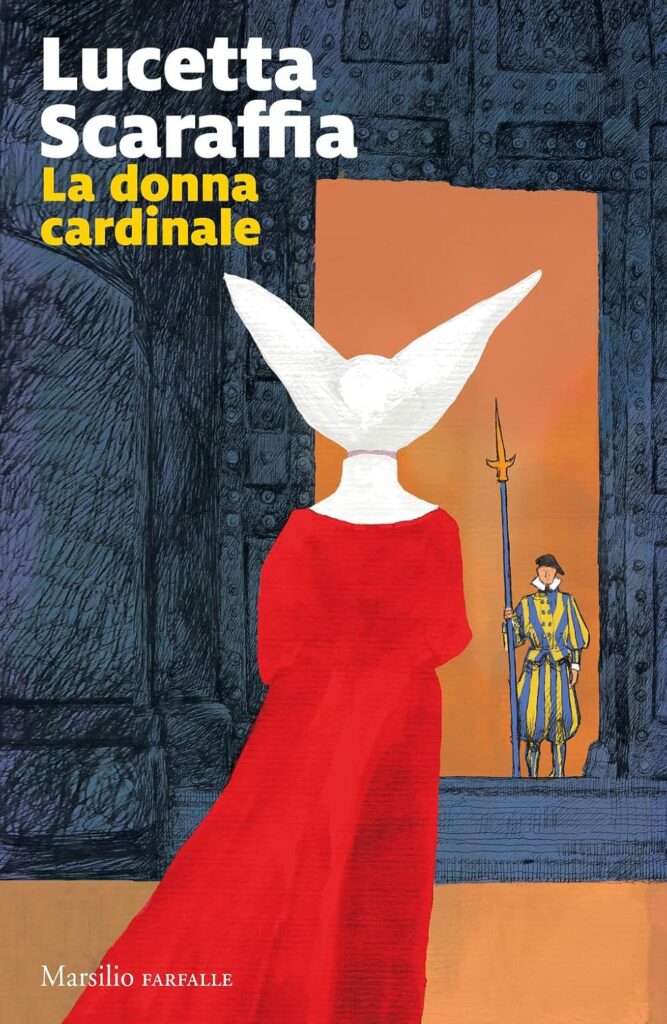
SINTESI DEL LIBRO:
Carmela Scognamiglio era proprio offesa, e brontolava a gran
voce anche se, uscito il dottore come al solito prima del suo
arrivo, a casa non c’era nessuno a darle soddisfazione.
Napoletana, gran brava donna, e di cuore, ma anche permalosa,
permalosissima, inveiva da più di un quarto d’ora.
«Ma come, io gli cucino tutte le cose che piacciono a lui, e
chisto mi pianta tutto lì. Senza una parola! E per sei sere di
seguito, mica una, senza degnarsi di aprire il forno dove sta
pronto tutto che basta scaldarlo. Ma dove siamo, al ristorante?
Per chi mi avete presa? Eh no, caro il mio riveritissimo dottor
Cesi, voi accussì a me non mi ci potete trattare!»
Uno squillo di telefono e la voce affannata della segretaria del
dottore s’intromise nelle proteste: «Carmela, per favore, il dottore
è ancora lì?»
«Ma no, è già uscito, io non l’ho proprio visto.»
«Oddio, come si fa? In studio ci sono già tre persone che
avevano appuntamento, ho provato a chiamarlo sul cellulare, ma
non risponde.»
«Magari sarà scarico.»
«Figuriamoci, lui ci sta attentissimo. E poco fa ha pure
chiamato un monsignore per un’urgenza; viene fra poco, certo
non posso farlo aspettare.»
«Signora Silvia, che vi devo dire… Non vi state ad angustiare…
Il monsignore, se mi posso permettere, siccome è un cristiano
come tutti noi, come tutti aspetterà.»
«Ma cosa dice, non è possibile.»
«Eh già, secondo lui, e magari anche secondo voi, poiché porta
la sottana ’o monsignore deve valere più degli altri? Ma faciteme
’o piacere! Anche io tengo la sottana e quando devo aspettare
aspetto, che sarà mai. Questi preti! Si sentono sempre più degli
altri.»
Liquidata la segretaria, esaurita la quotidiana frecciata da
quell’anticlericale che si vantava di essere – a messa però ci
andava, tutte le domeniche – Carmela riprese la filippica da dove
l’aveva lasciata, e intanto sbatteva i tappetini del bagno con
litigioso vigore. E pensare che avevano concordato per telefono i
pasti della settimana perché, non prevedendo impegni, il dottore
avrebbe cenato a casa, da solo. Solo come un cane, chiosava lei
mentalmente. E che lista, avevano fatto. Perché lei, Carmela
Scognamiglio, vedova Becchimanzi, in cucina modestamente ci
sapeva fare. Glielo riconosceva anche quello scorbutico di
Gennaro, buonanima, che come marito era stato una vera
penitenza, mai niente che gli andasse bene. Una croce. «Se
rinasco non mi risposo manco se mi viene a chiedere ’o principe
azzurro in persona con tanto di cavallo bianco» prometteva alle
amiche e ai parenti più stretti, non a quelli del defunto,
naturalmente. E adesso ricapitolava gli accordi presi con grande
precisione perché lui, il dottore, era una gran buona forchetta.
Lunedì parmigiana di melanzane; martedì un assaggio di zucchine
alla scapece e la sua pasta fredda preferita, i tubetti rigati con
pomodorini, olio, aglio e pangrattato; mercoledì la pizza di scarola
«come la sappiamo fare noi a Napoli»; giovedì il peperone
imbottito, al forno; venerdì, naturalmente di magro, i polipetti alla
Luciana, perché lei aveva il pescivendolo di fiducia al mercato
coperto di via Andrea Doria, ultimo banco a sinistra, che glieli
teneva da parte… e le diceva anche qualche galanteria; sabato il
tegame di verdure al forno e le mozzarelline di Aversa, una bontà.
Insomma, concludeva la vedova Becchimanzi, un vero ben di Dio,
come mangiare a Napoli da Ciro a Santa Brigida, ma non a quei
prezzi. E invece il dottore… niente. Digiuno. A casa non aveva mai
mangiato. Ma dormito sì. Sonni agitati, a giudicare dallo stato
delle lenzuola. Carmela era preoccupata, perché anche se
brontolava, al dottore era affezionata. Erano dodici anni che gli
teneva la casa e cucinava, dopo che la moglie se n’era andata. È
malato, si chiedeva, oppure gli è successo qualcosa con quelli là,
che gli ha fatto passare la fame? O magari, hai visto mai, si è
messo a fare un digiuno di penitenza, a mezzogiorno una cosetta
vicino allo studio e poi la sera salta. Può anche essere, pensava,
con tutti quei preti sempre intorno, magari l’hanno convinto. Però,
possibile non dirle neanche una parola, che so: «Carmela abbia
pazienza, mi dispiace»? E che diamine. Ma sì, doveva essere
capitato qualcosa.
In effetti, ma lei non poteva saperlo, una cosa era successa,
giusto all’inizio della settimana. Quando cioè la trappola per
Gregorio Cesi era scattata a ridosso del Vaticano, nel bar del
quartiere Borgo, dove ogni giorno alle sette e mezza andava a fare
colazione. Un locale pulitissimo, ma disadorno, tra i pochi a Roma
ad aver conservato tavolini e bancone di marmo, come usava
cent’anni fa. Lo conoscevano tutti quel sessantenne distinto in
abito grigio al quale nessuno osava rivolgere la parola, anche
perché se ne stava sempre ostentatamente barricato dietro Il
Messaggero a pagine spalancate.
Solo il proprietario azzardava la mossa di intrattenerlo, e lo
faceva con l’unico argomento in cui sapeva di non sfigurare, il
calcio. Quanto di più lontano dagli interessi di Cesi, che – cortese– solitamente annuiva con aria assente, strizzando appena gli
occhi verdi, unica evidenza nel volto piuttosto anonimo. Il signor
Renato però non si scoraggiava, avrebbe voluto almeno uno
scambio di battute con quel cliente che era davvero il suo fiore
all’occhiello. Il medico personale del papa. Nientemeno. Anzi,
l’archiatra, insomma, il primo dei medici, titolo solenne che nella
tarda antichità stava a indicare chi praticava l’arte medica a Roma
e a Costantinopoli. Più tardi, nel Medioevo, la denominazione era
stata progressivamente ristretta, fino a riservarla soltanto a colui
che aveva in cura il pontefice. Negli ultimi anni si era preferito
lasciar decadere quel termine così pomposo, che troppo sapeva di
corte rinascimentale. A dispiacersene, molto, era stato il
predecessore di Gregorio, un uomo che pur esibendo
atteggiamenti moderni e progressisti era in realtà vanitosissimo e
avido di omaggi. Fu così che, quando lasciò la carica dopo aver
servito per trent’anni sotto due papi, gli venne elargito il titolo di
archiatra emerito, confezionato apposta per lui con una soluzione
tipicamente curiale. Qualcuno usava ancora l’appellativo di
“archiatra” rivolgendosi a Gregorio, ma solo per una sorta di
benevola ironia che, in fondo, a lui non dispiaceva affatto.
Nulla, naturalmente, sapeva di tutto questo il signor Renato,
che solo avrebbe voluto ostentare un pizzico di familiarità con
l’illustre avventore.
Quella mattina Gregorio era anche meno disponibile del solito.
Si sentiva stordito, e ne conosceva la ragione. Infatti aveva
ordinato un caffè addirittura doppio, anziché l’immancabile
cappuccino con molto latte e poco caffè. La sera prima era stato a
cena da un cardinale ormai in pensione, sul colle di San Pietro dal
lato settentrionale della basilica. L’ospite aveva offerto come al
solito ottimo vino e, con il dolce, un Porto di pregiatissima annata,
di cui Gregorio si era servito in abbondanza, anche per ravvivare
la conversazione, che soltanto fino al risotto agli asparagi era
stata davvero interessante. Gli capitava spesso di cenare a casa di
alti prelati, che per lo più erano anche suoi pazienti. Non che ci
fossero grandi amicizie: consuetudini, piuttosto, quelle che
scandivano ormai da molti anni la sua vita, passivamente
accettate, com’era nel suo carattere. Buoni cibi, suore servizievoli,
conversazione incentrata sul microcosmo vaticano, sul tema
sempre quello – delle promozioni. Anzi, le “nomine”. Recarsi a
quelle cene non era neppure faticoso, perché abitava a pochi passi
dal Vaticano. Aveva rifiutato l’enorme appartamento di servizio nel
Palazzo San Carlo, proprio dietro la basilica. Troppo grande. E
poi, preda di una leggendaria pigrizia, mai si sarebbe sottoposto
alle fatiche del trasloco. Meglio rimanere nel piccolo attico
elegante, pieno di libri, quasi a ridosso delle mura vaticane,
all’interno di Borgo. Certo, non era la casa in cui era nato, nel
cuore della Roma quattrocentesca, di proprietà della famiglia, una
di quelle rimaste fedeli al papa dopo la breccia di Porta Pia. I Cesi
appartenevano infatti alla Roma cosiddetta “nera”, aristocratici
che avevano preso il lutto quando il papa era stato spogliato del
potere temporale e che avevano devoluto molti dei loro beni per
sostenere il “bianco prigioniero” del Vaticano. Storie lontane, che
Gregorio ricordava soltanto a grandi linee – la memoria di
famiglia era conservata, piuttosto, dai cugini Franchi de’
Cavalletti – ma con la convinzione che la scelta dell’antenato
Andrea di destinare al papa gran parte delle proprietà familiari
fosse stata più che giusta. Anzi, doverosa.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :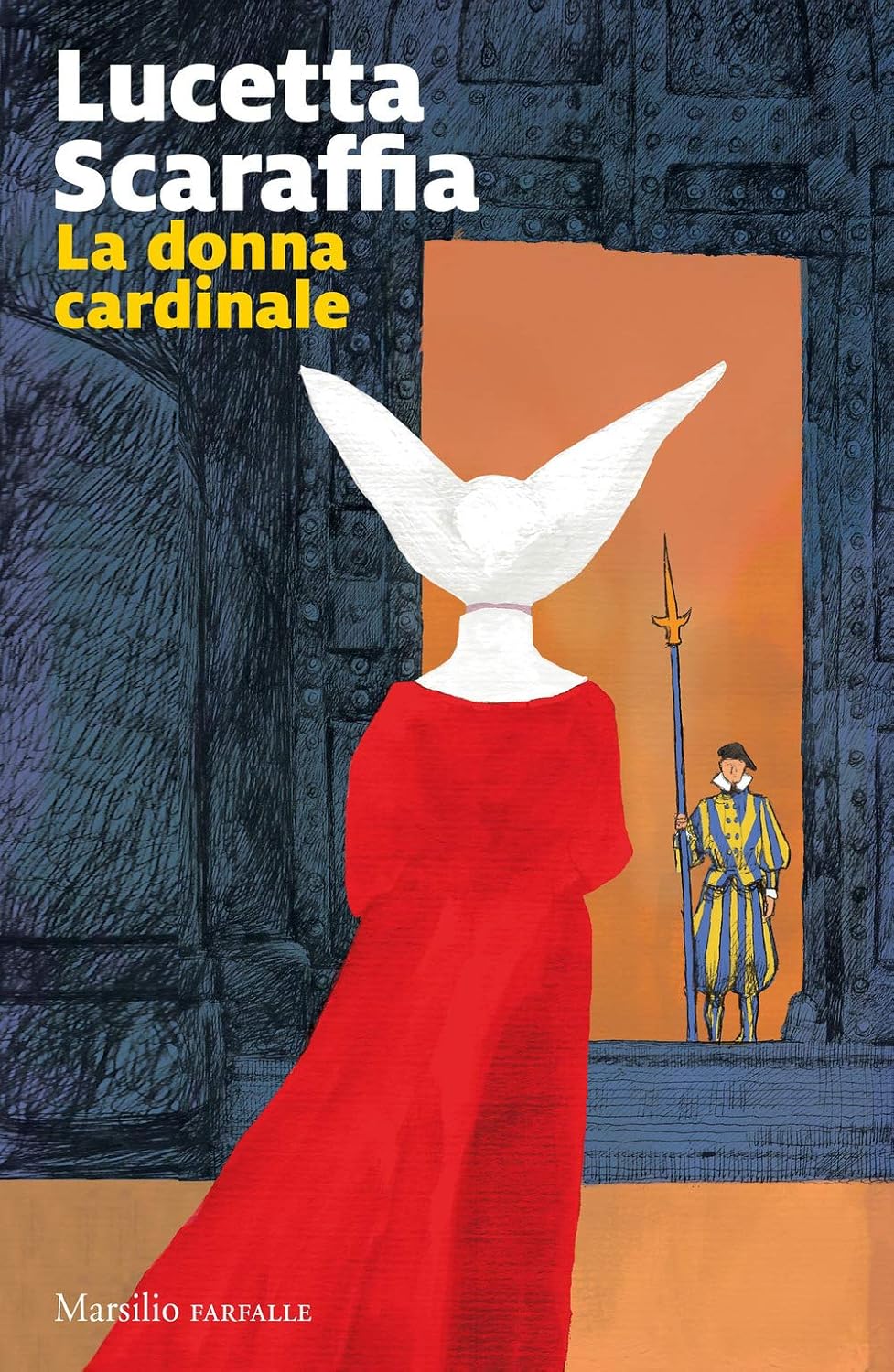






Commento all'articolo