La crudele pedagogia del virus – Boaventura de Sousa Santos
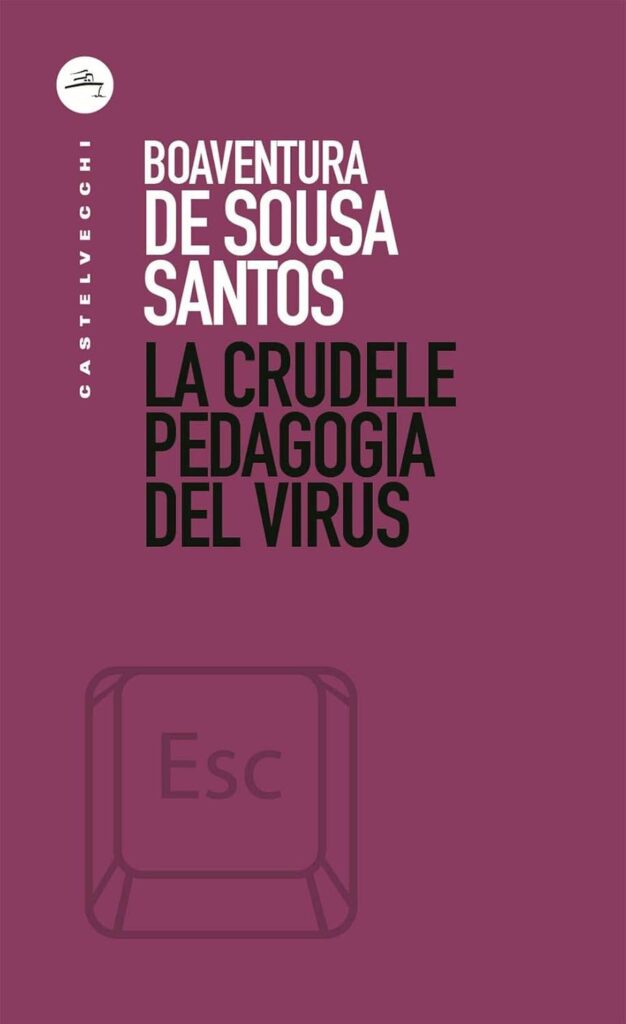
SINTESI DEL LIBRO:
Nelle scienze sociali c’è un dibattito che è sempre all’ordine del
giorno: la verità e la qualità delle istituzioni di una data società si
conoscono meglio in situazioni di normalità, di funzionamento
abituale, o in situazioni eccezionali, di crisi? Può darsi che entrambe
ci rivelino qualcosa in egual misura, ma di sicuro ciò che ci
permettono di comprendere o rilevare è diverso. Cosa potremmo
dunque dedurre in proposito grazie alla pandemia del Coronavirus?
La normalità dell’eccezione. L’attuale pandemia, ovviamente, non è
una situazione di crisi contrapposta a una situazione di normalità.
Dagli anni Ottanta – via via che il neoliberismo si è imposto come
versione dominante del capitalismo e quest’ultimo si è sempre più
assoggettato alla logica del settore finanziario –, il mondo ha vissuto
in un permanente stato di crisi. Situazione doppiamente anomala.
Da un lato, l’idea di crisi permanente è un ossimoro, visto che, in
senso etimologico, la crisi è, per sua natura, eccezionale e
passeggera, e fornisce l’opportunità di venire superata,
determinando un miglioramento. Dall’altro, quando la crisi è
passeggera, deve essere spiegata attraverso i fattori che la
provocano. Quando, però, diventa permanente, la crisi si trasforma
nella causa che spiega tutto il resto. Per esempio, la permanente
crisi finanziaria è utilizzata per spiegare i tagli alle politiche sociali
(salute, istruzione, previdenza sociale) o la diminuzione dei salari,
impedendo di porsi domande sulle vere cause della crisi. L’obiettivo
della crisi permanente è di non venire risolta. Ma qual è l’obiettivo di
questo obiettivo? Fondamentalmente, due: legittimare la scandalosa
concentrazione di ricchezza e boicottare misure efficaci per impedire
l’imminente catastrofe ecologica. È così che abbiamo vissuto negli
ultimi quarant’anni. Per questo, la pandemia non fa che peggiorare
la
situazione di crisi cui la popolazione mondiale è stata
assoggettata. E qui risiede la sua specifica pericolosità. In molti
Paesi, dieci o vent’anni fa, i servizi sanitari pubblici erano meglio
preparati ad affrontare la pandemia di quanto non lo siano oggi.
La flessibilità del sociale. In ogni epoca storica, i modi di vivere
predominanti (lavoro, consumo, tempo libero, convivenza) e di
anticipare o posticipare la morte sono relativamente rigidi e
sembrano derivare da regole incise nella pietra della natura umana.
È vero che essi si modificano in modo graduale, ma i cambiamenti
passano quasi sempre inosservati. L’irruzione di una pandemia non
si
concilia con tale lentezza. Esige cambiamenti drastici che,
all’improvviso, diventano possibili come se lo fossero sempre stati. È
fattibile rimanere a casa e avere più tempo per leggere un libro,
restare con i figli, consumare meno, disintossicarsi dai centri
commerciali, dove si guarda ciò che è in vendita dimenticando tutto
ciò che si vuole ma che si può ottenere solo tramite mezzi che non
siano l’acquisto. L’idea preconcetta per cui non ci sono alternative al
modo di vivere imposto dall’ipercapitalismo va in frantumi. Ci si
dimostra che non ci sono alternative solo perché il sistema politico
democratico è stato indotto ad abbandonare una discussione sulle
alternative. Rigettate dal sistema politico, le alternative entreranno
sempre più di frequente nella vita dei cittadini dalle porte di servizio
delle crisi pandemiche, dei disastri ambientali e dei collassi
finanziari. Ossia, le alternative faranno ritorno, ma nel peggiore dei
modi possibili.
La fragilità umana. L’apparente rigidità delle soluzioni sociali crea,
nelle classi che ne traggono più vantaggio, un curioso senso di
sicurezza. Pur rimanendo alcune incertezze, ci sono mezzi e risorse
per minimizzarle, che siano le cure mediche, le polizze assicurative, i
servizi degli istituti di vigilanza, la terapia psicologica, le palestre.
Questo senso di sicurezza si combina con l’arroganza e persino con
la condanna di tutti coloro che si sentono vittime delle medesime
soluzioni sociali. Il focolaio virale distrugge questo senso comune e
da un giorno all’altro fa svanire la sicurezza. Sappiamo che la
pandemia non è cieca e ha bersagli privilegiati, eppure crea una
coscienza di comunione planetaria, in un certo qual modo
democratica. L’etimologia del termine “pandemia” dice proprio
questo: tutto il popolo. La tragedia è che, nella fattispecie, il miglior
modo per essere solidali gli uni con gli altri è isolarci gli uni dagli altri,
senza neanche toccarci. Curiosa comunione di destini. Non ne
esisteranno altre?
I fini non giustificano i mezzi. Il rallentamento dell’attività economica,
soprattutto nel maggiore e più dinamico Paese del mondo, ha ovvie
conseguenze negative. Benché ne presenti anche di positive. Per
esempio, la diminuzione dell’inquinamento atmosferico. Uno
specialista della qualità dell’aria dell’agenzia spaziale degli USA
(NASA) ha affermato che non si era mai vista una diminuzione così
drastica dell’inquinamento in un’area tanto vasta. Questo sta a
significare che, all’inizio del XXI secolo, l’unico modo per evitare la
sempre più imminente catastrofe ecologica sia la distruzione di
massa della vita umana? Avremo perso l’immaginazione preventiva
e la capacità politica per metterla in pratica?
È anche risaputo che, per controllare efficacemente la pandemia, la
Cina ha adottato metodi di repressione e di vigilanza particolarmente
rigorosi. È sempre più evidente che le misure sono state efficaci. La
Cina, tuttavia, pur avendo tanti meriti, non ha quello di essere un
Paese democratico. È tutto da vedere se tali misure avrebbero
potuto essere assunte o applicate con uguale efficacia in un Paese
democratico. Questo vuol dire che la democrazia è carente di
capacità politica per rispondere alle emergenze? Al contrario, «The
Economist» all’inizio di quest’anno dimostrava che le epidemie
tendono a essere meno letali in Paesi democratici grazie alla libera
circolazione dell’informazione. Visto che, però, le democrazie sono
sempre più vulnerabili alle fake news, dovremo immaginare soluzioni
democratiche basate sulla democrazia partecipativa a livello di
quartieri e di comunità, e sull’educazione civica orientata alla
solidarietà e alla cooperazione, e non all’imprenditoria e alla
competitività a tutti i costi.
La guerra di cui è fatta la pace. Il modo in cui in un primo momento è
stata costruita la narrazione della pandemia dai media occidentali ha
reso evidente la volontà di demonizzare la Cina. Le cattive
condizioni igieniche nei mercati cinesi e le loro strane abitudini
alimentari (insinuanti arretratezza) sarebbero state all’origine del
male. In modo subliminale, l’opinione pubblica globale doveva
ritenersi avvertita di quanto fosse pericoloso che la Cina, oggi
seconda economia planetaria, giungesse a dominare il mondo. Se la
Cina non era in grado di prevenire tali danni alla salute mondiale e,
oltretutto, di superarli in modo efficace, come affidarsi alla tecnologia
del futuro da lei proposta? Ma il virus avrà avuto origine in Cina? La
verità è che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
l’origine del virus non è ancora stata determinata. Per questo motivo,
è irresponsabile che i canali ufficiali degli USA parlino di «virus
straniero» o addirittura di «Coronavirus cinese», tanto più che solo
nei Paesi con un buon sistema sanitario pubblico (e gli USA non
rientrano tra questi) è possibile fare test gratuiti e determinare con
precisione i tipi di influenza verificatisi negli ultimi mesi. Ciò che
sappiamo con certezza è che, ben al di là del Coronavirus, esiste
una guerra commerciale tra la Cina e gli USA, una guerra senza
esclusione di colpi che, come tutto suggerisce, dovrà finire con un
vincitore e un vinto. Dal punto di vista degli USA è urgente
neutralizzare la leadership cinese in quattro settori: la produzione di
telefoni cellulari, le telecomunicazioni di quinta generazione
(l’intelligenza artificiale), le automobili elettriche e le energie
rinnovabili.
La sociologia delle carenze. Una pandemia di queste dimensioni
provoca a giusta ragione un caos mondiale. Pur giustificando
l’esagerazione che le si crea intorno, è bene tenere sempre presenti
le ombre create da tale visibilità. Per esempio, Medici Senza
Frontiere avvisano dell’estrema vulnerabilità al virus da parte di
molte migliaia di rifugiati e immigrati, accolti nei campi profughi in
Grecia. In uno di questi (nel campo di Moria), c’è un rubinetto di
acqua per 1.300 persone e manca il sapone. I profughi devono
vivere attaccati gli uni agli altri. Famiglie di cinque o sei persone
dormono in meno di tre metri quadri. Anche questo è Europa:
l’Europa invisibile. Le stesse condizioni prevalgono anche alla
frontiera meridionale degli USA, anche quella un’America invisibile.
E le zone di invisibilità potranno moltiplicarsi in molte altre regioni del
mondo, e probabilmente anche qui, molto vicino a noi.
Probabilmente basta aprire la finestra.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :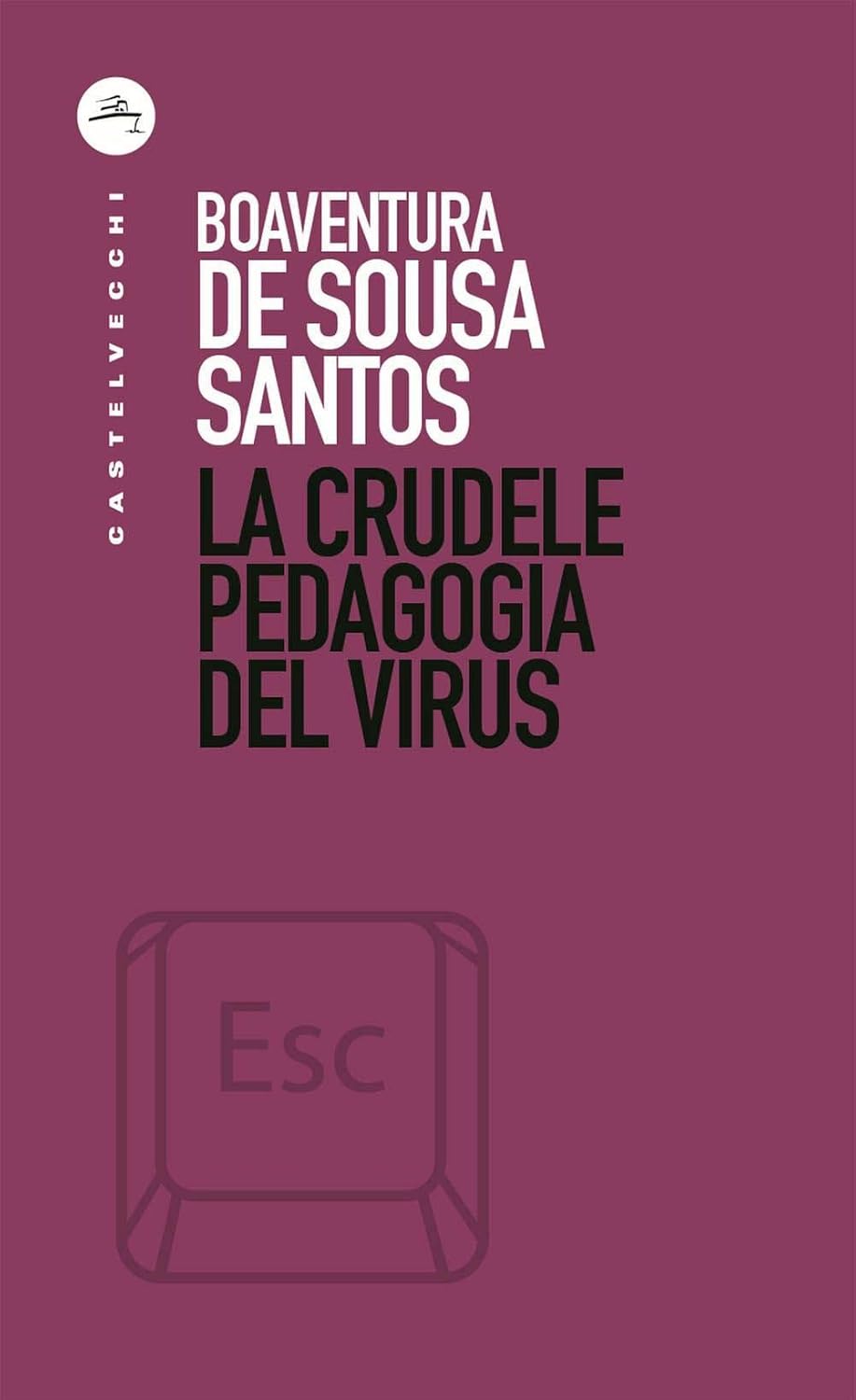






Commento all'articolo