La bellezza come metodo – Saggi e riflessioni su fisica e matematica – Paul A. Dirac
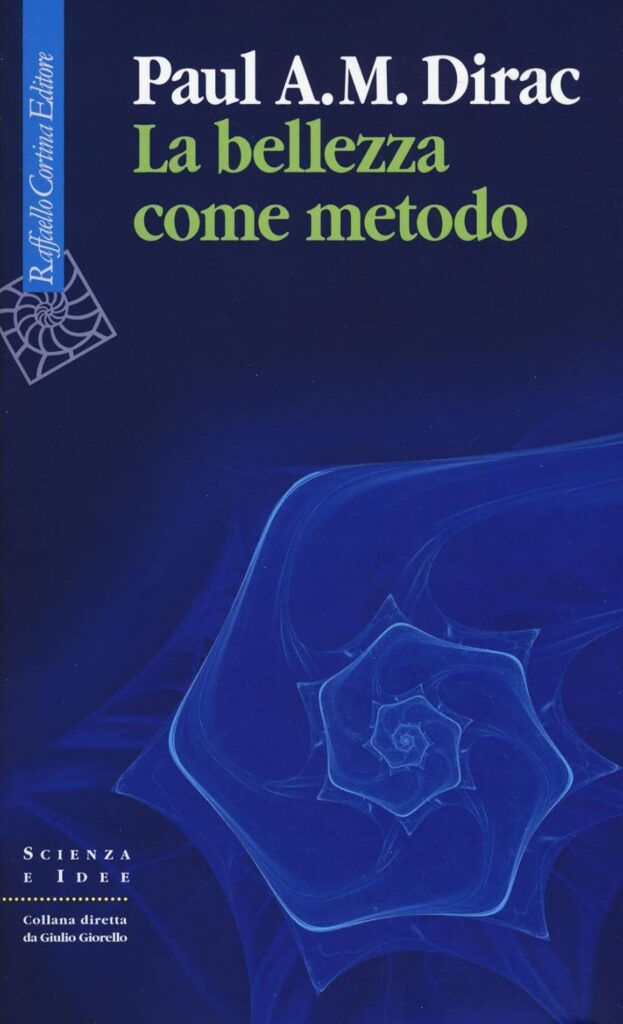
SINTESI DEL LIBRO:
Paure e coraggio
FREEMAN DYSON
È di cile immaginare una concentrazione di intelletti paragonabile a quella
che caratterizzò l’ambiente accademico di Cambridge nei primi due decenni
del secolo scorso. Alle Tavole Alte dei Collegi sedevano – per fare solo
qualche nome – personaggi del calibro di Bertrand Russell, Ludwig
Wittgenstein, G.E. Moore, J.J.
omson, Ernest Rutherford, G.H. Hardy,
John Maynard Keynes, protagonisti della cultura loso ca e scienti ca, ma
anche della vita sociale della cittadina inglese. Improvvisamente, nel 1925,
una nuova stella apparve in questo rmamento già straordinariamente ricco:
una stella solitaria e diversa da tutte le altre, destinata a raggiungere in
brevissimo tempo fama mondiale e a lasciare una traccia indelebile nella
storia della scienza.
Quando l’articolo intitolato “ e fundamental equations of quantum
mechanics”
1 giunse a Göttingen, una delle capitali della sica teorica
dell’epoca, Max Born si chiese chi fosse quel P.A.M. Dirac, “Senior Research
Student, St John’s College”, che aveva formulato con ammirevole lucidità e in
modo autonomo la teoria su cui egli stesso stava lavorando da mesi assieme
a due giovani assistenti, Werner Heisenberg e Pascual Jordan. Tutto era
cominciato alla ne del luglio del 1925, quando Heisenberg aveva inviato
alla rivista Zeitschri für Physik un lavoro fondamentale, ma incompleto e a
tratti
oscuro, dal titolo “Über quantentheoretische Umdeutung
kinematischer und mechanischer Beziehungen” (Reinterpretazione quanto
teorica di relazioni cinematiche e meccaniche), in cui venivano poste le basi
della meccanica quantistica. A settembre Dirac ebbe modo di leggere le
bozze dell’articolo, che il suo tutor Ralph Fowler aveva ricevuto da
Heisenberg. In un primo momento, non ne rimase particolarmente
impressionato. Poi, però, fu attratto da un breve capoverso in cui Heisenberg
segnalava una “di coltà signi cativa” della nuova teoria: il prodotto di due
grandezze quantistiche non godeva della proprietà commutativa della
moltiplicazione, cioè dipendeva dall’ordine dei fattori. Dirac intuì che la
di erenza tra i prodotti diversamente ordinati di due grandezze – che
chiamò “commutatore” – poteva essere messa in relazione con una quantità
della meccanica analitica nota come parentesi di Poisson. Ciò permetteva di
trasferire nel contesto quantistico l’intero formalismo canonico classico e di
scrivere le equazioni del moto quantistiche in perfetta analogia con quelle
classiche (le equazioni di Hamilton). La teoria che ne risultava era identica a
quella formulata da Born, Heisenberg e Jordan, ma il punto di vista di Dirac
era molto diverso: laddove i primi vedevano – sul piano del contenuto sico– una drastica rottura con la vecchia meccanica, Dirac percepiva – sul piano
formale – una confortante continuità, perché le variabili dinamiche delle
due teorie obbedivano alle stesse leggi matematiche.
2
Nel corso di un’intervista concessa allo storico e losofo della scienza
omas Kuhn nel 1963, Dirac ri etté sulla genesi del proprio approccio alla
teoria quantistica e in particolare sul fatto di avere assunto come punto di
partenza fondamentale quello che a Heisenberg era apparso, invece, come
un elemento problematico della nuova meccanica, vale a dire la non
commutatività delle grandezze siche.
3 L’atteggiamento di Heisenberg
esempli cava, a parere di Dirac, l’ansia tipica di colui che concepisce un’idea
radicalmente nuova e si chiede se essa sia giusta o sbagliata, temendo che
possa emergere qualcosa – un e etto inatteso, un dato empirico – che la
invalidi. Spetta a chi viene subito dopo l’innovatore – Dirac, nel caso in
questione –, e non ha le sue stesse paure (dal momento che non sta
mettendo in gioco una propria creazione), sviluppare compiutamente l’idea
e trarne tutte le conseguenze.
Dirac riprese queste considerazioni nel 1969, in un articolo su Eureka, la
rivista degli studenti di matematica di Cambridge, dove illustrò con vari
esempi quella che gli appariva come una costante nella storia della scienza:
Le speranze sono sempre accompagnate da paure, e nella ricerca scienti ca le paure tendono a
prendere il sopravvento. […] Per queste ragioni chi presenta una nuova idea non è sempre la
persona più adatta a svilupparla. Qualcun altro, senza i timori dell’innovatore, potrà applicare
metodi più audaci, e compiere progressi più rapidi.
4
Se nel 1925 Dirac si era trovato nella comoda posizione di chi viene
immediatamente dopo l’iniziatore di una nuova idea, due anni più tardi fu
lui a sperimentare le ansie della creazione, quando conseguì il suo più
importante risultato, l’equazione quantistica e relativistica degli elettroni che
porta il suo nome.
A metà del 1927 Dirac aveva cominciato a dedicarsi al progetto di
combinare le due teorie della nuova sica, la meccanica quantistica e la
relatività ristretta, per ottenere un’equazione del moto per le particelle valida
anche a velocità vicine a quella della luce. La prima equazione di questo tipo
comparsa nella letteratura, dovuta a Oskar Klein e Walter Gordon, aveva il
difetto di fornire delle probabilità negative e di essere incompatibile con la
formulazione della meccanica quantistica che lo stesso Dirac aveva
elaborato, la cosiddetta teoria delle trasformazioni.
5
Dirac si mise a cercare un’equazione che soddisfacesse due requisiti
generali: 1) fosse coerente con la teoria delle trasformazioni; 2) obbedisse al
principio di simmetria relativistica, cioè fosse invariante rispetto a
trasformazioni del sistema di riferimento. L’obiettivo fu raggiunto dopo
qualche mese di ricerche,
6
condotte secondo il tipico stile di lavoro di Dirac:
“giocare con le equazioni e vedere che cosa danno”.
7 Scaturita da
considerazioni puramente teoriche, l’equazione di Dirac spiegava
perfettamente il moto e le proprietà degli elettroni, compreso il loro
momento rotatorio intrinseco, lo spin, la cui descrizione aveva richiesto no
ad allora ipotesi piuttosto arti ciose.
Dirac si limitò ad applicare la nuova equazione al primo grado di
approssimazione, temendo che agli ordini successivi potesse risultare in
disaccordo con i dati: toccò così al suo collega Charles Galton Darwin
(nipote del grande naturalista) dimostrare che l’equazione forniva predizioni
esatte, valide a tutti gli ordini. Ma non fu la sua sola esitazione. Quella più
clamorosa riguardò un’altra importante proprietà dell’equazione: l’esistenza
di soluzioni corrispondenti a energie negative. In un primo momento Dirac
pensò di poter semplicemente trascurare queste soluzioni in quanto
sicamente prive di senso; ma capì presto che la teoria quantistica
ammetteva la possibilità di transizioni discontinue dai livelli di energia
positiva a quelli di energia negativa: questi ultimi, di conseguenza, non
potevano essere ignorati. Per quasi due anni il problema delle energie
negative rappresentò, come disse enfaticamente Heisenberg, il “capitolo più
triste della sica moderna”. La via di uscita fu trovata da Dirac alla ne del
1929. Basandosi su un’analogia con la teoria chimica della valenza, egli
ipotizzò che i livelli di energia negativa, il cui insieme è noto come “mare di
Dirac”, fossero tutti occupati da elettroni inosservabili. Ciò comportava una
radicale ride nizione del vuoto: da stato privo di materia a stato popolato da
inniti elettroni di energia negativa. Il salto quantico di uno di questi
elettroni a un livello di energia positiva renderebbe osservabile
quell’elettrone e, nello stesso tempo, produrrebbe una “buca” – anche questa
osservabile – nel mare. Gli oggetti sici reali sarebbero, quindi, gli elettroni
di energia positiva e le buche del mare.
Ma a quali particelle corrispondono le buche? Dal momento che gli
elettroni sono carichi negativamente, le buche – che sono lacune
elettroniche – devono essere cariche positivamente. Non volendo postulare
l’esistenza di nuove particelle – sia perché l’opinione corrente era contraria a
questo tipo di idee, sia perché non c’erano evidenze sperimentali in merito –,
Dirac identi cò le buche con gli unici corpuscoli di carica positiva allora
conosciuti, i protoni. Ma il matematico Hermann Weyl, che non aveva le sue
stesse remore, fece notare che, in virtù della simmetria dell’equazione di
Dirac, le buche dovevano avere esattamente la stessa massa degli elettroni e
non potevano, dunque, corrispondere ai protoni, molto più pesanti.
Finalmente, nel 1931, dopo tre anni di tentennamenti, Dirac trasse la
conclusione de nitiva. In uno straordinario articolo, intitolato “Quantised
singularities in the electromagnetic eld”, predisse l’esistenza e le proprietà
dell’antielettrone (poi chiamato positrone), una particella di massa identica a
quella dell’elettrone e carica elettrica opposta. Era il primo esempio di
antimateria. Il secondo esempio, l’antiprotone – l’antiparticella del protone
compariva nello stesso articolo, poche righe dopo. Il resto del lavoro, che
rompeva de nitivamente il tabù dell’invenzione di nuove particelle, era
dedicato a un terzo oggetto ipotetico, il monopolo magnetico, introdotto per
spiegare la quantizzazione della carica elettrica elementare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :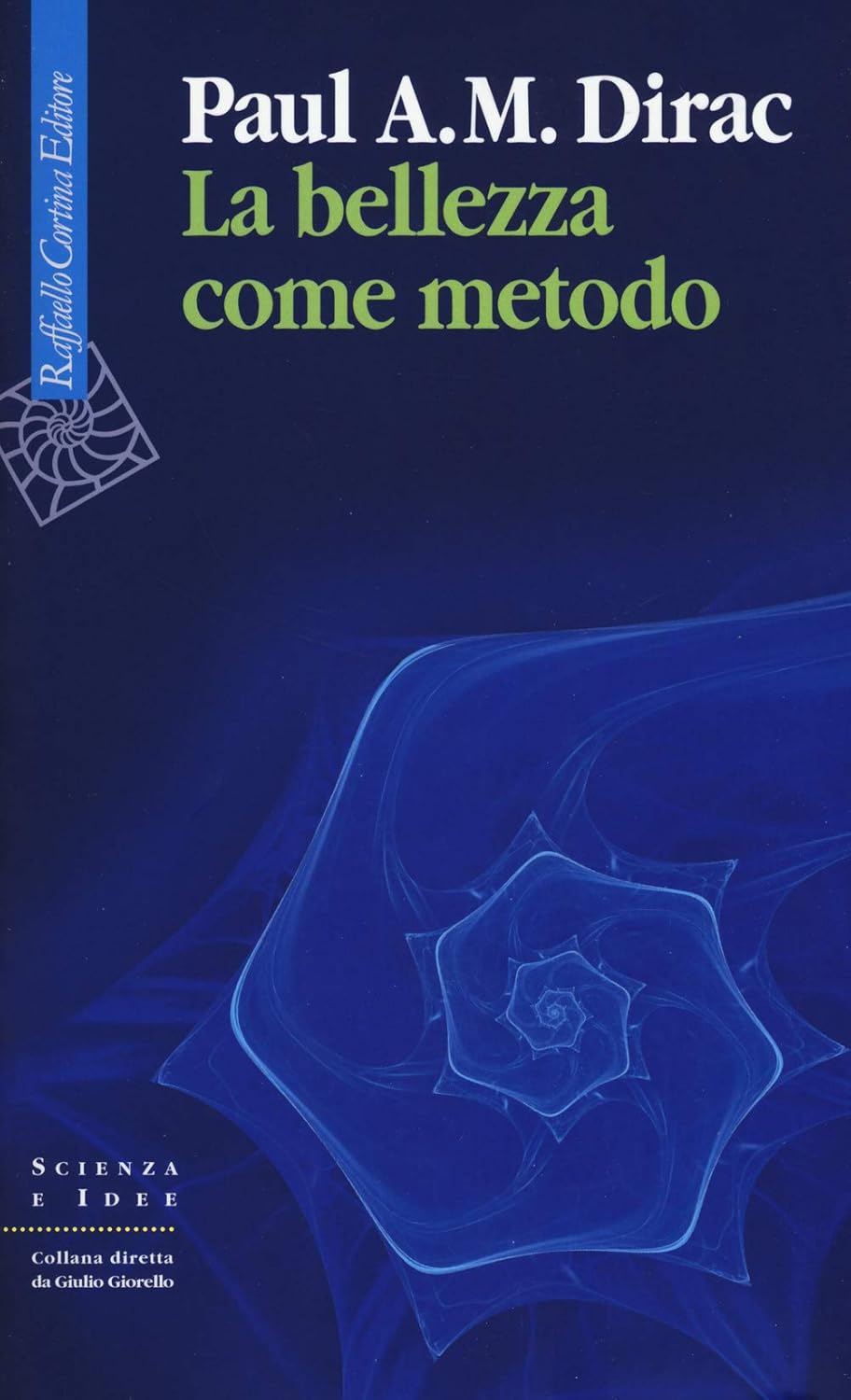






Commento all'articolo