Karl Marx – Uno e bino – Tra arcaismi del passato e illuminazioni del futuro – Roberto Finelli
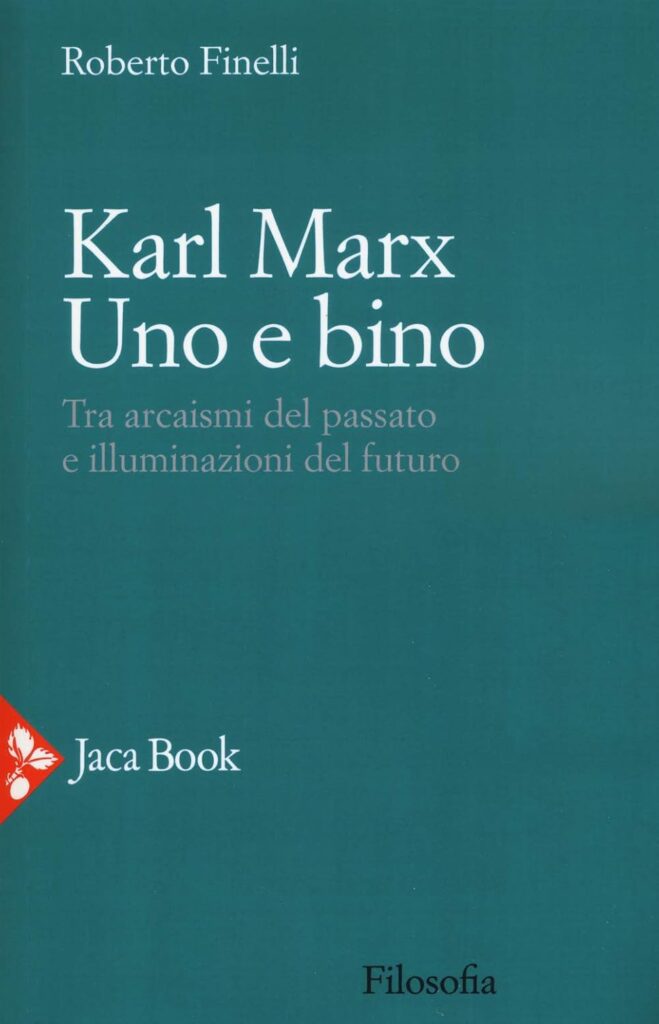
SINTESI DEL LIBRO:
La valorizzazione etica e antropogenetica che Marx
soprattutto il Marx dei cosiddetti Manoscritti economico
f
ilosofici del 1844 – ha compiuto del lavoro è stata, com’è
ben noto, centrale nella storia culturale e politica dei
movimenti ottocenteschi e novecenteschi di trasformazione
e di fuoriuscita dalla società capitalistica. Nel solco della
lezione hegeliana sulla nobiltà del lavoro del servo nella
Fenomenologia dello Spirito rispetto all’etica del solo
consumo personificata dal padrone, Marx vede nel lavoro la
prassi che per eccellenza realizza l’essere umano e che
nello stesso tempo umanizza e dà senso alla natura. Tanto
da descriverne il rovesciamento e la sua riduzione a mera
attività strumentale nella modernità capitalistica come
alienazione e perdita dell’umanità a sé medesima: di contro
al crescere e all’ingigantirsi della proprietà privata. Come
riduzione cioè dell’essere umano al soddisfacimento dei soli
bisogni fisici ed egoistici di un’esistenza solo naturale e
materiale.
Per altro sembra ormai ben consolidato nella sterminata
letteratura critica su Marx il riconoscimento del carattere
essenzialistico e organicistico – da metafisica antropologica
potremmo dire – del presupposto che sta alla base del
discorso marxiano. L’essere umano partecipa della vita del
genere umano (menschliche Gattung) e per questo è un
individuo libero e diverso da tutti gli altri esseri naturali:
perché gode di una intrinseca universalità: «L’uomo è un
ente generico non solo in quanto egli praticamente e
teoricamente fa suo oggetto il genere, sia il proprio che
quello degli altri enti, ma anche […] in quanto egli si
comporta con se stesso come col genere presente e vivente;
in quanto si comporta con se stesso come un ente
universale e però libero»1. Ma questa «universalità» non
può che esprimersi, appunto, altrimenti che attraverso
l’attività vitale del lavoro, perché, col trasformare la natura
per soddisfare i suoi bisogni, la specie umana conduce ad
espressione esterna, in un mondo oggettivo, le proprie
capacità, le proprie forze essenziali, e nello stesso tempo fa
della natura il suo proprio «corpo inorganico».
In termini filosofici, potremmo dire – diversamente dalla
riduzione althusseriana del giovane Marx al solo
antropocentrismo feuerbachiano – Feuerbach + Hegel.
Giacché quel Marx assume la natura comunitaria, non
egoistica, universale, dell’essere umano (secondo la lezione
sulla Gattung/Genere di Feuerbach), ma, nello stesso
tempo, ritiene che quella forza di soggettività non possa
che realizzarsi e riconoscersi nella lavorazione di un mondo
oggettivo, fuori di sé (secondo la lezione sul lavoro di
Hegel).
In tale prima prospettiva marxiana il soggetto è per
definizione, per la sua intrinseca e originaria universalità
assai più potente dell’oggetto, il genere umano assai più
potente della natura e il lavoro è assai più realizzazione
esteriore e conferma di queste virtù essenziali dell’umano
che non adeguamento, conoscenza, e trasformazione delle
leggi oggettive della natura. Più ancora che «scambio
organico» tra uomo e natura, come Marx lo definirà più
tardi nel capitolo quinto del primo libro del Capitale, qui il
lavoro è ancora visto essenzialmente come proiezione
dell’essere umano su una natura che stenta assai a
mostrare di possedere uno spessore di realtà propria e una
autonoma legalità. Tale potenza universalizzante del lavoro
del resto non si limita solo a caratterizzare il rapporto
soggetto-oggetto, il nesso cioè tra genere umano e contesto
naturale, ma caratterizza anche il rapporto uomo-uomo, o
per
dir
meglio
uomo-società,
perché,
nell’essere
espressione dell’uomo, non come essere animale e volto
alla mera riproduzione della sua esistenza corporea e
f
isico-individuale ma appunto come essere tendenzialmente
universale e libero dalla propria animalità, è attività che
socializza e accomuna, al di là di ogni egoismo e di ogni
proprietà privata.
Vale a dire che per tale prospettiva marxiana, facendo
uso dell’antico lessico greco, poiesis e praxis coincidono:
poiesis, in quanto agire che produce oggetti, e praxis, in
quanto agire che produce il soggetto. E il lavoro marxiano è
appunto carico di un valore insieme produttivo-materiale
ed etico-morale, quanto a realizzazione del sé e della
società comune. Tanto che da questa compresenza di piani
deriva la necessità storicamente immanente e concreta, e
non utopica, del comunismo. Giacché, com’è evidente, una
soggettività sociale e comunitaria come quella dell’homo
faber, e dunque del proletariato moderno, non potrà alla
f
ine non porre termine al regime dell’appropriazione e
accumulazione privata di una ricchezza la cui produzione è
intrinsecamente «comune». Vale a dire che gli espropriatori
saranno alla fine espropriati, per il passaggio della storia
alla società comunista, secondo l’obbligatorietà di una
legge di natura che, dalla socializzazione delle forze
produttive fino alla dilatazione del mercato mondiale
prodotta dal capitale medesimo, agisce secondo lo schema
dialettico della negazione della negazione.
2. La complicazione psicoanalitica dei concetti di società e
libertà
Dopo le tante vicende della modernità che sono trascorse
da quell’anno lontano della composizione dei Manoscritti,
credo che sia ben evidente quanto sia oggi improponibile
una tale antropologia essenzialistica e universalistica che
dà per presupposto scontato e acritico il facile comporsi,
senza differenze e lacerazioni interiori, degli individui
proletari in un corpo comune. Quasi che il loro essere privi
di proprietà privata li garantisse da ogni dimensione
personale e privata al loro interno e li eleggesse, per forza
di cose, a classe universale, come scriveva il giovane Marx
nei Deutsch-französische Jahrbücher. Eppure di quella
antropologia marxiana rimane, preziosa, una dimensione da
rivendicare e riproporre per un’etica e una società del
futuro. La dimensione appunto di un’etica del lavoro per la
quale il lavoro possa essere, insieme, produzione
dell’oggetto e produzione del soggetto: produzione di beni
adeguati e non contraddittori con le leggi della natura e,
insieme,
produzione di soggetti adeguati e non
contraddittori con le leggi della specifica individualità dei
produttori. Salvo che ora a tale endiadi di poiesis e praxis è
necessario dare per contenuto una rinnovata antropologia,
che, lontana dalle facili presupposizioni comunitarie e
feuerbachiane di Marx, sappia coniugare, con assai
maggiore accortezza, il nesso di socializzazione e
individuazione, di collettivo e di personale: con la
consapevolezza che il raggiungimento, sia pure aurorale o
quanto meno parziale, di un simile obiettivo, anziché essere
presupposto tacito all’intero divenire storico, può essere
solo il risultato di un lunghissimo e complicato processo.
Rimanere all’interno della prospettiva valoriale del lavoro
significa perciò aver ben chiaro i limiti dell’antropologia di
Marx – in particolare quanto a un ritardo strutturale
presente nel suo pensiero riguardo al tema e al valore della
differenziazione individuale – e volgersi necessariamente,
per integrare quel deficit, verso quelle scienze umane,
come in primo luogo, a mio avviso, la psicoanalisi, che
hanno fatto compiere progressi irrinunciabili a una teoria
più complessa e ricca dell’essere umano.
Infatti la psicoanalisi di scuola freudiana, forse meno
quella junghiana – escludendo del tutto da tale contesto
virtuoso l’opera sulfurea e fumogena di Jacques Lacan – ha
messo a tema un arricchimento, una complicazione, dei
concetti di «società» e di «libertà» che non può non
coinvolgere la natura di una nuova etica politica,
sollecitandola a una profonda rielaborazione rispetto al
passato.
Quanto al primo concetto, la tradizione psicoanalitica ha
infatti significato l’apertura e la fondazione di uno spazio di
societas interioris che si aggiunge e si connette a quella
tradizionale di societas exterioris. La configurazione della
mente umana in base a una compresenza di stanze o
istanze psichiche, capaci tra loro di dialogo e sintesi o, al
contrario di scissione e repulsione, è principio costitutivo
infatti di un nuovo tipo di socievolezza o insocievolezza, di
natura interna o «verticale». La psicoanalisi, seguendo in
ciò la grande riflessione sul corpo inaugurata nel ’600 da
Baruch Spinoza quale societas di molti individui («il corpo
umano è composto di moltissimi individui (di diversa
natura), ognuno dei quali è assai composito»2), ha messo a
tema una individualità umana, composta dall’eterogeneo di
facoltà psichiche, il cui esito di concordia e compresenza è
costantemente
esposto
contrapposizione e scissione.
a
una
possibilità
di
Da tale connotazione bina del concetto di società deriva
di necessità una rielaborazione del concetto di «libertà»,
anch’esso da coniugare nel verso dell’interiorità verticale
dell’essere umano. Giacché – accesa nel verso della
complicanza e dell’estensione della mente tale dimensione
di interiorità – libertà non può più avere unicamente il
significato della libertà liberale come libertà negativa da
ogni ingerenza o autoritarismo esterno o il significato della
libertà comunista come libertà positiva di godimento, per
ciascuno eguale, di beni e servizi. Perché acquista il
significato ulteriore, accanto ai due precedenti, di libertà
come affrancamento, il più ampio possibile, da ogni
autoritarismo interno, da ogni violenza e censura interiore
che una facoltà o una istanza della mente pretenda di
esercitare sulle altre.
Tutto ciò significa che la scoperta freudiana del territorio
psichico dell’inconscio come sesto continente ridisegna
profondamente una geografia umana dislocata solo sui
cinque continenti, e apre una nuova antropologia fondata
sulla compresenza di due assi costituzionali: quello
orizzontale, della relazione tra individuo umano e altre
individualità, e quello verticale della relazione, all’interno
del singolo individuo, tra la propria mente e il proprio
corpo. Il deficit antropologico del marxismo nasce dalla
rimozione di questa struttura fondamentale dell’essere
umano. Ma non solo del marxismo. Si potrebbe dire infatti
che buona parte delle scienze umane e sociali del
Novecento siano rimaste a convivere nello spazio
rassicurante della vecchia geografia pentacontinentale,
senza voler vedere e confrontarsi con l’espansione e la
complicazione dello spazio vitale aperto dalla psicoanalisi.
Confluendo, va detto, in un comune conformismo e in una
comune subalternità a una scienza sociale della sola
intersoggettività, la cui retorica con i temi dell’alterità e del
riconoscimento dell’altro ha sommerso soprattutto
nell’ultimo trentennio la filosofia, la sociologia, l’etica e la
politica, finendo spesso a braccetto con l’esaltazione
cattolico-cristiana della relazione sociale quale dedizione
sacrificale e amorosa verso l’alterità.
Mentre io credo che la questione centrale di una
rinnovata
antropologia
dell’emancipazione
e
della
trasformazione sociale non sia quella del riconoscimento
dell’altro, bensì quella del riconoscimento del sé, da cui
solo può conseguire una corretta impostazione del
riconoscimento dell’altro. Giacché oggi ciò che è in
questione –
e
che
costituisce
la
patologia
sociale/esistenziale più di massa – è proprio la capacità e la
possibilità dell’essere umano di riconoscere se stesso, nella
più propria e irripetibile individualità: cioè di giungere a
quella compenetrazione di mente e corpo emozionale, di
conoscere e sentire, che consenta di trovare, al di là o
attraverso ogni comunicazione sul piano orizzontale, la
fonte ultima del senso del vivere, e della distinzione tra il
bene e il male, nell’indicazione d’affetto che nasce sul piano
verticale del nostro esistere, ossia, per dirla di nuovo con
Spinoza, nel trasecolare della nostra emotività da tristitia a
laetitia e viceversa. Vale a dire che ciò che oggi è in
questione è la capacità dell’essere umano di affidare le
scelte del proprio vivere non ai dettami dell’asse
orizzontale e della comunicazione sociale ma al vaglio e al
confronto di quest’ultimi con la propria comunicazione
verticale, in un coraggio e in una personalizzazione di vita
che dice che il logos non è il pathos, che il conoscere non è
il sentire, ma che il vivere il proprio progetto di vita è il
frutto di una mediazione in cui nessuna istanza diviene
asimmetricamente dominante sulle altre.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :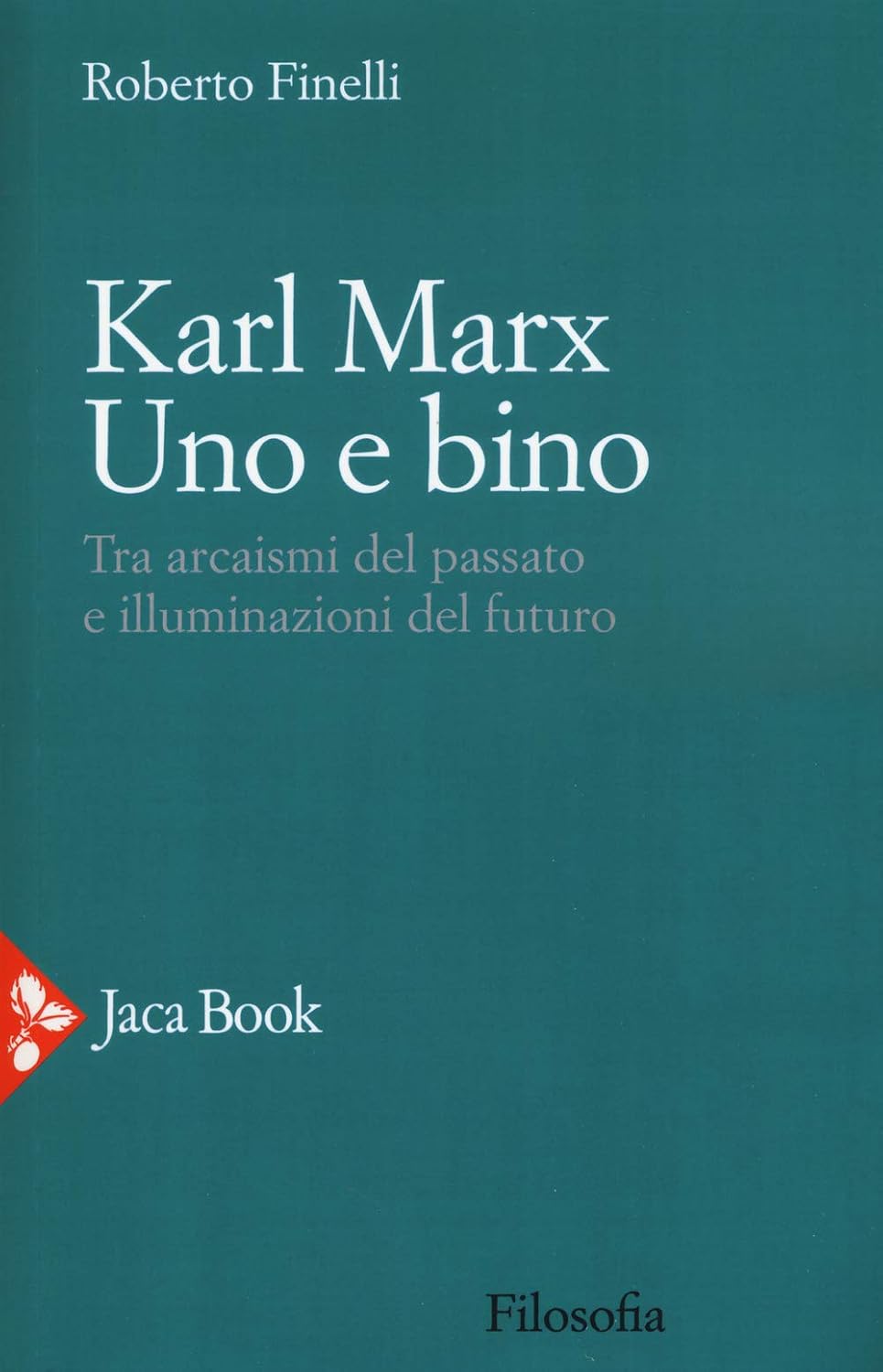






Commento all'articolo