Il virus è mutato – Massimo Ciccozzi
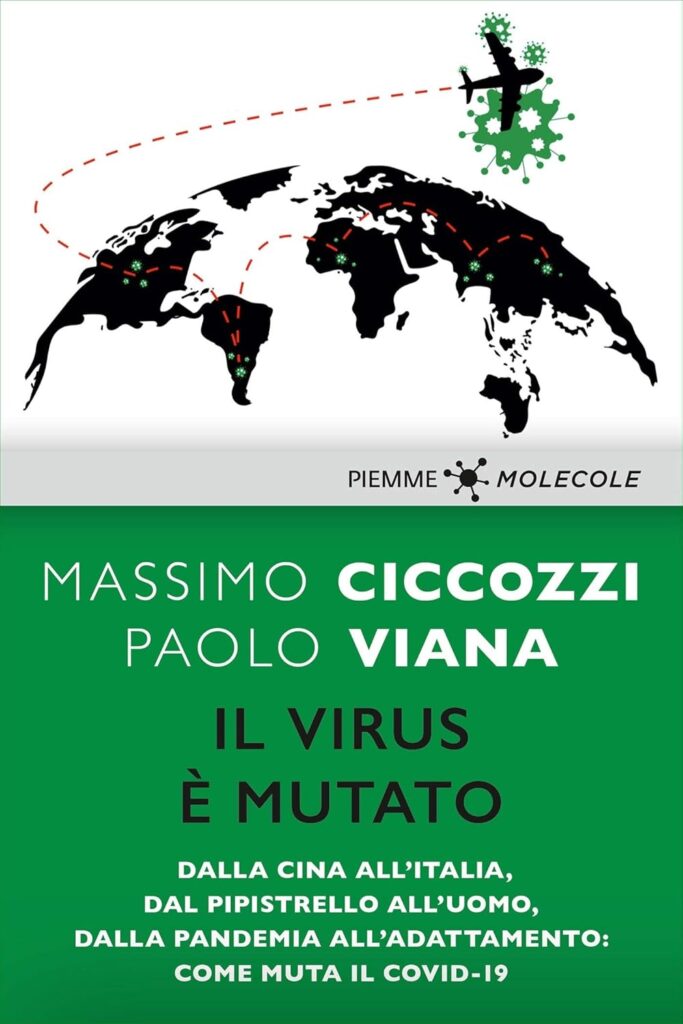
SINTESI DEL LIBRO:
Ci fa paura ciò che non conosciamo, come i virus. E ci fa ancora più
paura un virus che cambia. La scienza dice che i virus mutano: noi
non la ascoltiamo. Colpa della scuola? Colpa dei giornali? Fatto sta
che, se parliamo di mutazioni, molti pensano agli X-men e agli OGM.
Peccato che i primi appartengano al regno dei fumetti e i secondi a
quello del business. Se durante il lockdown ne avessimo approfittato
per leggere qualche libro in più, forse la situazione sarebbe diversa.
Forse, noi non avremmo scritto questo e-book per spiegare il ruolo
delle mutazioni genetiche nei sei mesi che hanno cambiato il mondo.
Stando ai dati Agcom, a metà aprile in Italia è stato registrato un
record assoluto di telefonate; i messaggini sono aumentati addirittura
del 200%. Ammettiamolo, siamo un popolo di chiacchieroni. Tra i tanti
commenti che circolavano tra gli italiani ce n’è uno particolarmente
vero: nell’inseguire il coronavirus anche la scienza procede a tentoni.
L’emergenza ha confermato, dopo Aids, Ebola e Sars, che sappiamo
troppo poco del “nemico”. Lo dimostrano le tante (troppe)
dichiarazioni affrettate di numerosi uomini di scienza. C’è chi, ancora
nel mese di febbraio, paragonava il Covid-19 a «un’influenza
stagionale». Oppure chi, dinnanzi all’incipiente tragedia, si attardava
a
scommettere
sul
«rischio
zero».
Per
non
parlare
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: prima di dichiarare la
pandemia ha atteso l’11 marzo, oltre due mesi dopo i primi casi di
Wuhan.
Quando c’è di mezzo la salute, gli scienziati dovrebbero esprimersi
solo attraverso studi pubblicati su riviste scientifiche e comunque
misurare bene le parole, anche a costo di irritare l’anchorman di
turno. Non tanto perché, seguendo questa strada, i dati divengano
inconfutabili – il caso di «Lancet» e della clorochina 1
dimostra
semmai il contrario – ma in quanto la procedura della revisione,
affidata a studiosi di rango pari a quello degli autori, rende le
informazioni pubblicate più affidabili di una frase pronunciata in uno
studio televisivo. Eppure, così va il mondo. E in tempi di coronavirus,
i
virologi assurgono al ruolo di star. Salvo tornare nell’oblio non
appena le loro scoperte imporrebbero comportamenti virtuosi ai
cittadini e investimenti più oculati ai governi.
Diciamolo, le pandemie sono cicliche. È storia. Ed è scienza. I
coronavirus sono numerosi e agiscono in modo differente quando
colpiscono l’uomo, ma la loro pericolosità è nota 2
.
Numerosi studi
attestano due caratteristiche che li accomunano tutti. Entrambe sono
state prima snobbate e poi rincorse dai media e dalla politica.
Parliamo della contagiosità e dell’adattamento. La prima non è
possibile senza la seconda. Non conosciamo ancora tutti i dettagli,
ma tutti i virus cercano di replicarsi e di diventare endemici. Proprio
come una banale influenza.
Nel nostro corpo hanno messo su casa due coronavirus. Hanno
nomi meno televisivi del Covid-19: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1. Ma
ogni anno si contendono il detestabile primato di farci starnutire. Vale
per loro quello che vale per tutti i virus: il senso della loro esistenza
non è uccidere l’ospite, ma usarlo come un hotel. O come un taxi, per
saltare da un ospite all’altro. Certo, sui meccanismi che regolano la
replicazione e il decorso della malattia c’è ancora molto da indagare,
ma non siamo di fronte a degli UFO.
Sappiamo che i virus non sono dei veri e propri organismi viventi,
perché non si possono definire “vivi” fintanto che non penetrano in
una cellula. Sappiamo che, per farlo, usano le proteine di cui sono
composti e che sanno come “aprire” l’apparato cellulare. Sappiamo
anche che sono antichi. Anzi, diciamo pure che sono pezzi di vita
ancestrale che, per l’appunto, si sono modificati per attraversare i
millenni, condizionando e venendo a loro volta condizionati dagli
animali e dalle piante che riuscivano a parassitare. L’uomo fa parte di
questa catena in perpetuo movimento.
Com’è stato appurato nel 2013, «la storia evolutiva dei coronavirus
si estende probabilmente molto più indietro nel tempo» rispetto alle
nostre conoscenze attuali. Si parla di «migliaia o milioni di anni di
evoluzione 3
». Il discorso si fa intrigante. Come molte altre entità fatte
di acido ribonucleico – una molecola che interviene nell’espressione
dei geni e che nell’RNA appare spesso come un singolo filamento,
mentre nel DNA si presenta come un doppio filamento accoppiato – «i
coronavirus sembrano essere un’antica stirpe virale», arrivata fino a
noi proprio grazie alle mutazioni e ai salti di specie che hanno reso
possibile anche la pandemia di questo 2020.
Le mutazioni sono errori di replicazione che avvengono
maggiormente per caso o per azione di agenti esterni: gli organismi
cellulari utilizzano l’RNA messaggero (mRNA) per trasmettere le
informazioni genetiche codificate attraverso le diverse combinazioni
che possono essere assunte dalle basi azotate (guanina, timina o
uracile, adenina e citosina) e queste combinazioni permettono la
sintesi proteica. Se qualcosa va storto, e se l’errore si stabilizza nella
specie, tutti i nuovi individui si porteranno dietro quell’errore e a loro
volta lo trasmetteranno. Andate e moltiplicatevi: poiché però i virus si
moltiplicano dentro un organismo ospite, gli effetti non si limitano al
genoma virale, e si può realizzare quella che gli esperti chiamano
«coevoluzione». Ritroveremo questo concetto più avanti e capiremo
quanto sia centrale il tema dell’adattamento.
Come ha stabilito una ricerca olandese nel 2018, «alcune proteine
innescano un’interazione con la cellula ospite per creare un ambiente
ottimale per la replicazione del coronavirus, alterando il gene
dell’ospite o contrastando le difese antivirali dell’ospite. Queste
interazioni coronavirus-ospite sono fondamentali per la patogenesi
virale e determineranno in ultima analisi l’esito dell’infezione». In altre
parole, c’è qualcosa di noi nel Covid-19 e c’è molto di lui dentro di
noi. Al punto che la filogenesi, la disciplina che ricostruisce la nostra
storia evolutiva, nei suoi studi sui virus umani e animali ha rintracciato
addirittura una «convergenza tra la specie aviaria e l’avifauna e il
genere umano». Che Icaro avesse ragione?
Il Covid-19, al terribile prezzo di dieci milioni di casi positivi e quasi
mezzo milione di vittime nel momento in cui scriviamo, è stato anche
l’occasione di un corso accelerato di biologia, di genetica e di
medicina. Non tutti ne hanno fatto tesoro, ma l’emergenza ha portato
nelle nostre case la consapevolezza di processi decisivi per il nostro
futuro. L’adozione delle mascherine chirurgiche, il rispetto del
distanziamento, il lavaggio frequente delle mani sono diventati pane
quotidiano e abbiamo intuito che dalla conoscenza dei fenomeni
naturali dipende la nostra sopravvivenza.
In un contesto di paura e di lotta contro il morbo, seguendo il
racconto della pandemia dalla tv o sugli smartphone, abbiamo fatto la
conoscenza della Spike. Una protagonista assoluta della cronaca. Ma
non solo della cronaca. Perché è scientificamente inconfutabile che
all’inizio di tutto c’è lei: la Spike, la mutazione della glicoproteina del
picco, è l’evento che consente il salto di specie pipistrello-uomo. È
per via di questa mutazione che il coronavirus non si limita a infettare
l’uomo e si trasmette all’interno della nostra specie con tanta facilità.
Dipendono da questa proteina tante altre cose, tipo gli organi colpiti
dal Covid-19, e anche le chance di trovare un vaccino. Ma cos’è
questa maledetta Spike?
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :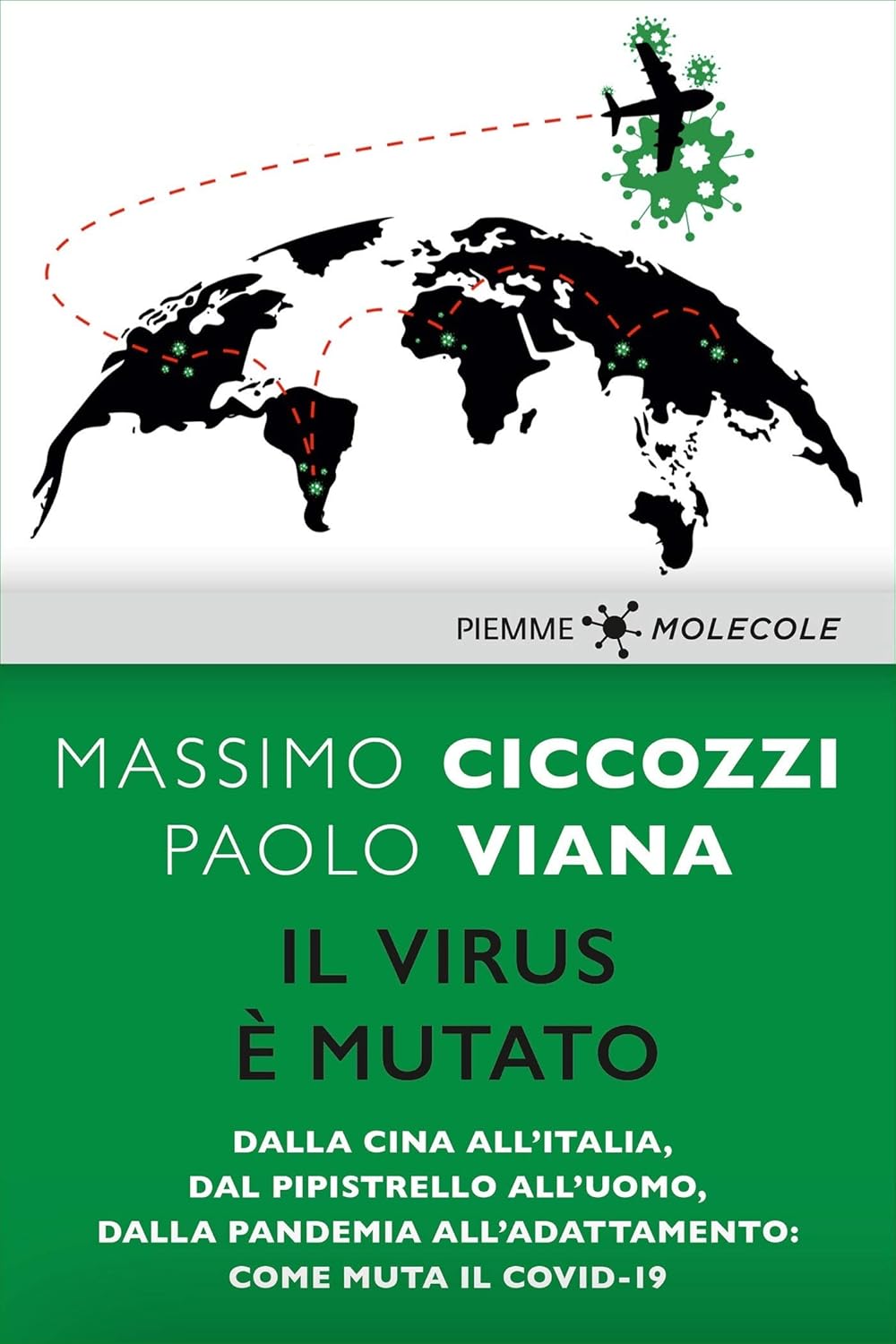






Commento all'articolo