Il guardiano della collina dei ciliegi – Franco Faggiani
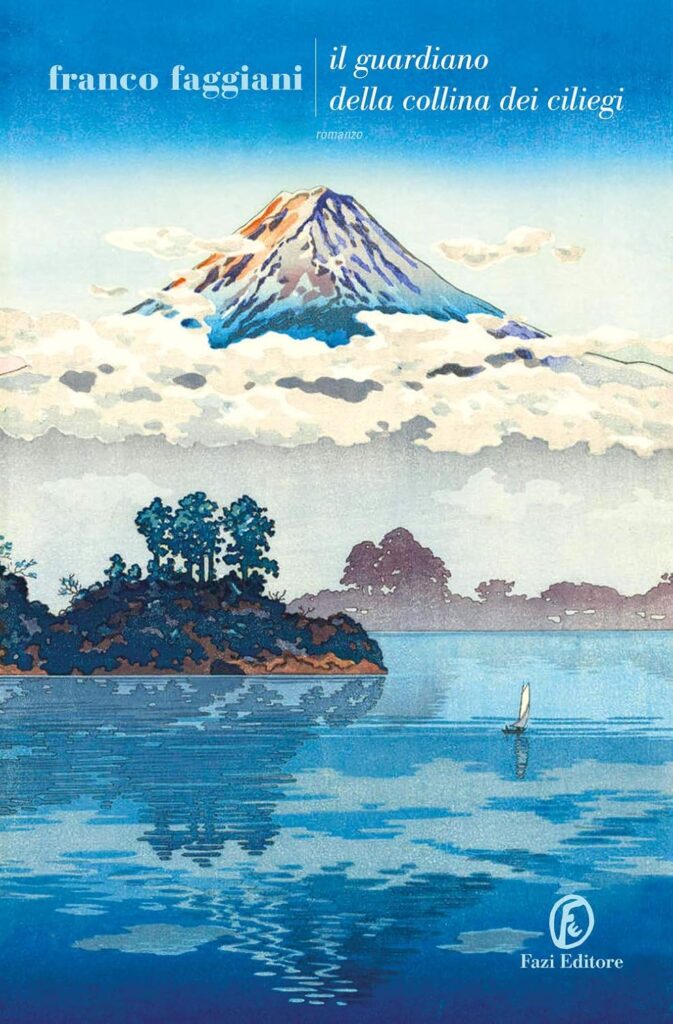
SINTESI DEL LIBRO:
Irasshai, benvenuti a casa mia. Anche se, me ne rendo conto, per voi è
molto presto. Io mi sveglio sempre prima dell’alba, per contemplare le
variazioni della luce, che si susseguono veloci e durano pochi istanti, come il
volo di un’allodola. Per questo è bene farsi trovare sempre pronti, con gli
occhi attenti e l’anima priva di zavorre. Il grande artista del mattino è il sole:
quando è ancora nascosto oltre l’orizzonte spande sulle cime delle montagne
e sulle nuvole il colore tenue della lavanda che, come d’incanto, si riflette
sulla baia; poi, affacciandosi nel cielo, regala al mondo le tonalità dorate dei
fuyugaki, i nostri cachi dolcissimi. Infine, quando emerge per intero,
prorompente, riconduce tutto all’ordine quotidiano; annulla i colori sfumati,
colpisce e disegna le ombre con mano ferma ed esperta.
Nelle limpide mattine d’autunno molti colori restano vividi a lungo. Il
verde-oro dei cipressi hinoki si fa evidente quanto le foglie incandescenti
delle piccole foreste di aceri, e i tronchi di betulla, simili a candelabri
d’argento, lasciano filtrare l’azzurro del mare in lontananza. Gli alberi che
però amo osservare di più sono i sugi, i cedri, alcuni dei quali molto alti e
vetusti. Mi commuovono e mi auguro che abbiano lunga vita e che qualcuno
si prenda cura di loro. Sono i sugi che hanno dato il legname con cui sono
stati costruiti, oltre duecento anni fa, i pavimenti e le stanze in cui sono
tornato ad abitare da poco. Tavole che i miei avi, secondo la tradizione,
bruciarono in superficie e subito raffreddarono nell’acqua del torrente qui
vicino, le cui gorgoglianti venature argentee confluiscono nel fiume Kikuchi,
poco prima che questo si smarrisca nell’estuario. In seguito le tavole vennero
strofinate energicamente con spazzole dai denti di ferro, che tolsero le tracce
delle bruciature lasciando un bel fondo nero opalescente. Tavole resistenti
alle nebbie salmastre che dal mare risalgono verso le montagne, alla grandine
dell’estate, alle prolungate spinte della neve, alle scosse dei terremoti.
La mia casa ha un colore scuro, simile a quello della ribollente conca
vulcanica del monte Aso, ma nessuno può scorgerla, dalla città. Nemmeno io
vedo la città, Tamana, perché tra me e lei si frappongono file di cipressi lungo
gli argini del torrente, i pregiati aceri e i vecchi cedri schierati come fedeli
soldati a difesa dai rumori e dalla vista degli edifici moderni, dei campi da
golf, dei centri sportivi, delle piscine, delle ville imponenti che sembrano
assemblaggi di cattivo gusto dovuti ad architetture approssimative. Da quassù
scruto magicamente solo i boschi e, oltre le chiome e i pennacchi degli alberi,
l’azzurro del mare che si insinua tra le colline lontane. Sul lato opposto della
baia si delineano le alture della prefettura di Nagasaki. Ai loro piedi, dopo il
crepuscolo serale, brillano le luci delle città costiere. Tamana fa parte della
prefettura di Kumamoto che, insieme a quella di Nagasaki e ad altre cinque,
forma l’isola di Kyushu, una delle più importanti del vasto arcipelago
nipponico, non solo per la sua estensione geografica, ma perché proprio su
questa isola del Sud è nata la civiltà giapponese.
In questa casa io, Shizo Kanakuri, sono nato il 20 agosto del 1891, e
allora qui la vita e il paesaggio urbano erano molto diversi. Tamana era poco
più di un villaggio, un agglomerato di piccole e fragili casupole fiancheggiate
da grovigli di rovi ed erba secca, da campi spesso trascurati perché la gente,
non mostrando attitudine per la terra, si dedicava perlopiù alla pesca. Era un
villaggio mobile, poiché abitazioni e depositi spesso andavano in pezzi a
causa dei terremoti o venivano scardinati dal suolo dai ruggenti venti di
burrasca che risalivano dall’oceano. Seppure con rassegnazione, le case
venivano rapidamente ricostruite un po’ più in là e un po’ più addossate, nel
tentativo di opporre maggiore resistenza al lato violento della natura.
I boschi erano meno fitti di adesso, ma più ricchi di varietà, e crescevano
liberamente, senza la cura dei boscaioli, i quali si occupavano solo di
raccogliere ogni tanto i tronchi spezzati dai fulmini e i grossi rami fatti cadere
dal vento. Lungo gli argini del fiume Kikuchi, per esempio, spiccavano gli
ontani e gli ombrosi alberi della canfora, capaci di sbeffeggiare il tempo.
Nessun albero può vivere più a lungo di loro e rinascere baldanzoso persino
nei luoghi più desolati. Anche per questo sono considerati sacri nelle nostre
tradizioni; eppure, con la scusa di proteggerli, vengono piantati ormai solo
nei parchi cittadini, vicino ai templi.
In primavera l’aria era attraversata dal fluttuare infinito dei pollini e al
tramonto gli alberi risuonavano del chiacchiericcio di migliaia di storni
arrivati a posarsi per la notte dopo le scorribande diurne nelle campagne
lontane. L’alba invece era allietata dal canto delle allodole. Al primo chiarore
saltellavano intorno ai loro nidi modellati sul terreno, tra zolle morbide e
ciuffi d’erba. Poi volavano in alto, senza incertezze, quasi a volersi scontrare
con il sole, e da lassù, per qualche istante sospese nell’aria, cercavano campi
di papaveri selvatici in cui tuffarsi, chiudendo le ali come fossero falchi
temerari, per fare scorpacciate dei semi contenuti nelle minuscole capsule
verdi nascoste tra i petali.
Dietro la casa i boschi salivano a perdita d’occhio verso le montagne, e io
li ho attraversati in ogni direzione e sotto qualsiasi tempo fin quasi al
compimento dei miei diciannove anni.
Cosa sia successo in seguito non l’ho mai saputo, perché, dopo un lungo
periodo di nomadismo in cui l’alba raramente mi scovava dove il tramonto
mi aveva lasciato, dalla primavera del 1915 fino al 1967 ho vissuto nell’isola
di Hokkaido, che dell’arcipelago giapponese è la più settentrionale, la meno
abitata e la più selvaggia. A Rausu, per la precisione, sulla costa nord
flagellata d’inverno dai venti artici, lontano tremila chilometri dal mio
villaggio natio. Un altro mondo, con l’oceano gelato per molti mesi e i
vulcani intenti a rendere precario ogni giorno che gli dèi mi hanno concesso
di vivere in quel posto remoto. Per tutti quegli anni sono stato il guardiano di
una collina di ciliegi.
Nascere alla fine del 1800 a Tamana, o in qualunque altro villaggio del
Sud del Giappone, obbligava ad affidare il proprio futuro solamente a due
mestieri: quello del pescatore o quello del soldato. Il pesce abbondava, tra le
isole e le correnti calde, ma a quell’epoca si aspirava a percorrere più miglia
marine per poter predare di più e ottenere sempre maggiori guadagni. Andare
per mare era pericoloso ma era comunque preferibile al duro e poco redditizio
lavoro nei campi.
Nel 1899 Juro Oka, nato nella prefettura di Yamaguchi, a soli ventinove
anni e dopo aver fatto apprendistato nella lontana Norvegia, aveva fondato la
Nihon En’yo Gyogyo K.K, la prima grande compagnia giapponese per la
cattura e la lavorazione delle balene. Le sue panciute navi a motore, che
erano la grande conquista di quel periodo, quando non erano a caccia lontano
dalle coste, venivano ormeggiate a Nagasaki. Per due motivi: perché la rada
era ampia e profonda e perché da lì i commercianti erano partiti già molti
secoli prima per il Portogallo e il Nord Europa; in quel porto si respirava
l’antico senso per gli affari. Le loro navi di legno e tela portavano mercanzie
di ogni genere: tessuti, spezie, carta, polvere pirica, sacchi ricolmi di bulbi di
tulipani che crescevano spontanei nelle montagne del Nord e di bacche di
ginepro usate per fare un distillato medicinale per i marinai colpiti dai mali
equatoriali.
Inoltre, in anni recenti, poco lontano dalle banchine erano stati costruiti i
primi impianti siderurgici del Giappone, che consentivano a Juro Oka di
ottenere rapidamente il ferro per riparare le sue navi e costruirne di nuove.
È innegabile dunque che il brillante armatore fosse per molti giovani
sognatori un affascinante esempio da seguire anche se, nella pratica, tutti
miravano non a costruire flotte ma, più semplicemente, a essere imbarcati per
attraversare i mari, nella speranza di ritornare, dopo mesi passati nel cuore
tumultuoso degli oceani, tra solitudine e burrasche, sani e salvi e con un buon
compenso per costruire una casa e una famiglia.
Naturalmente c’erano poi i pescatori costieri, che prendevano il mare su
imbarcazioni essenziali, poco più che assemblaggi incerti di assi e lamiere,
cime e catrame, per servire i mercati dei villaggi. Alcuni dei quali, per
volontà imperiale, iniziavano lentamente ad aggregarsi in piccole città, ad
accogliere persone provenienti da altre isole più povere, seguendo flussi
migratori spontanei o imposti dai potenti clan in cui si erano uniti i vecchi
shogun. Lo sviluppo portava nuova gente da sfamare, e di conseguenza un
numero sempre maggiore di ragazzi affrontava il mare in cerca di prede,
avventure e guadagni.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :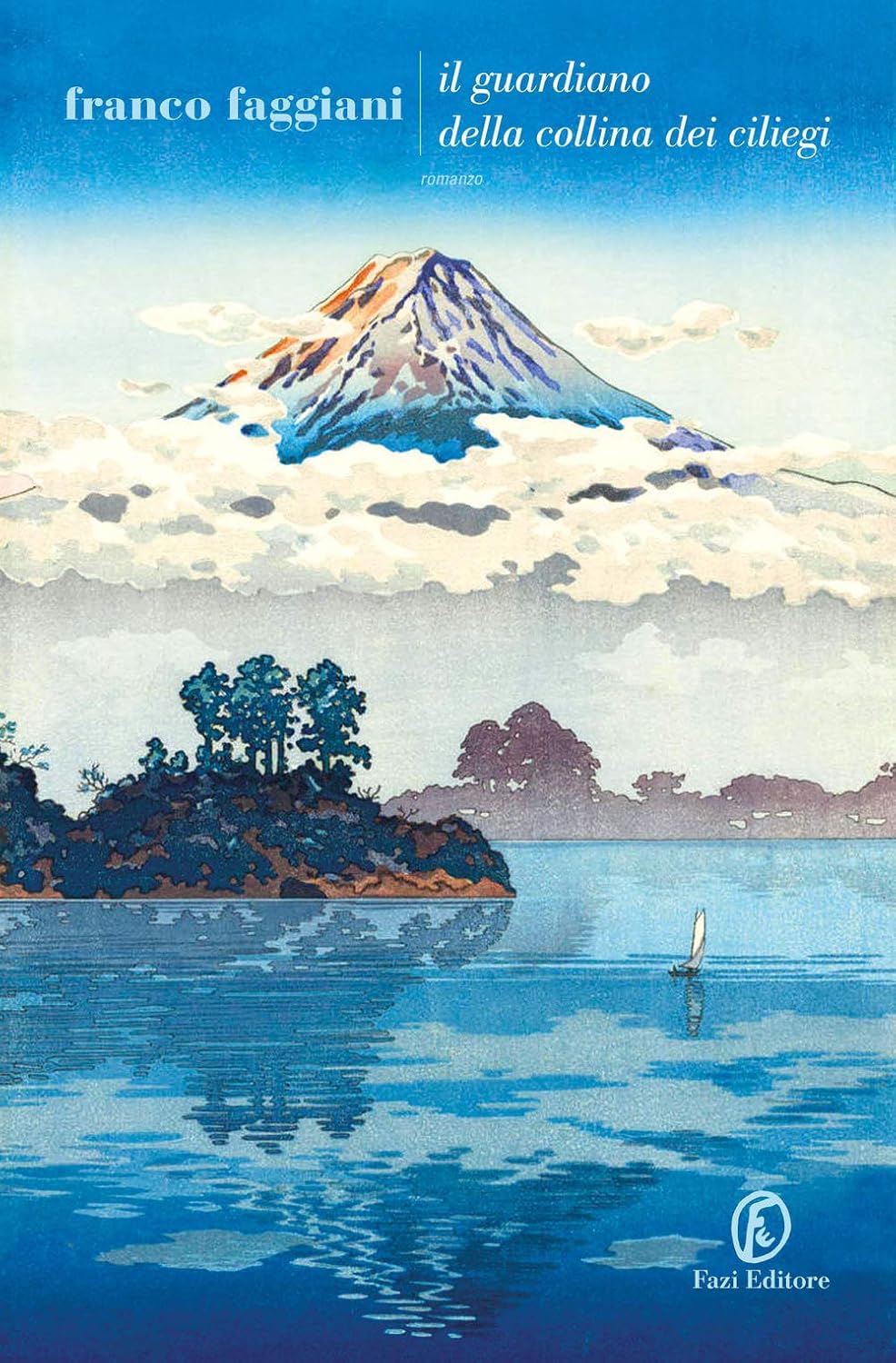






Commento all'articolo