Il capo dei capi- Vita e carriera criminale di Totò Riina- Attilio Bolzoni & Giuseppe D’avanzo
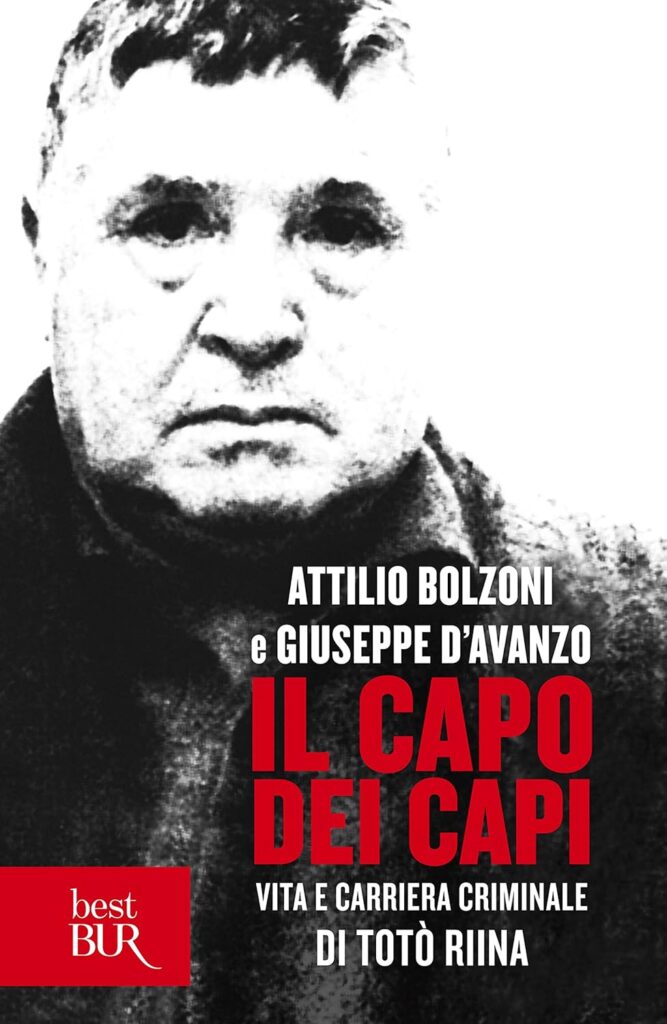
SINTESI DEL LIBRO:
Il contadino di Corleone IL MASCULIDDU DI
PIAZZA SOPRANA Erano tutti in fila indiana II torrente del
Batticano era asciutto da sei mesi. L'aria era appiccicosa e le
mosche ronzavano intorno alle bestie, vacche scarne, cani
spelacchiati. Il vento di scirocco spargeva gli odori della
campagna arida. L'estate del 1943 era stata caldissima. Era
settembre. Il sole era ancora alto, i campi bruciati. Venivano
dalla vigna di Frattina e stavano passando per le colline della
Venere del Poggio. Erano tutti in fila indiana. Il padre
Giovanni Riina, il primo figlio maschio Totò, il secondo figlio
maschio Gaetano. L'ultimo era Francesco, il più piccolo dei
fratelli. Francesco aveva sette anni e si dondolava in groppa
al mulo. Era la fine di una giornata di lavoro come tante per
una famiglia di contadini. Giovanni Riina aveva ereditato un
po' di terra dal padre, che l'aveva ereditata dal padre di suo
padre: due tumuli a Marabino, quattro tumuli a Frattina, tre
tumuli a San Cri-stoforo, altri quattro tumuli a Mazzadiana.
Erano quasi tre ettari di campagna. La terra per mangiare
almeno una volta al giorno. Per fare il pane, raccogliere fave,
barattare un sacco di grano con qualche balla di lana grezza da
cardare, o del cuoio per rattoppare scarpe, o del ferro e del
rame per riparare attrezzi da lavoro. Erano tempi duri, tempi
di guerra. Prima del grande bivio c'era un ponte che passava
sopra un fiume in secca. Poi il sentiero si arrampicava sulla
montagna che aveva preso il nome dal paese: Corleone. Nei primi
sette mesi dell'anno la paura arrivava sempre dall'alto, con
gli aerei "a due code". Li chiamavano così i Lightning,
cacciabombardieri a doppia fusoliera, bimotori armati con
quattro mitragliere e un cannoncino. Apparivano all'improvviso
da nord nord-est. Si diceva: dalla parte di Monreale. Erano
tanti che oscuravano il cielo come sciami di cavallette. Poi
sganciavano il loro carico e sparivano a sud, dietro le colline
di Lercara Friddi. Il bombardamento più spaventoso fu quello
del 9 maggio. Le incursioni aeree degli alleati sulle città
siciliane cessarono l'ultimo giorno di giugno. Un ordigno
inesploso fu trovato da Giovanni Riina nelle campagne della
Venere del Poggio il pomeriggio dell'11 settembre 1943. Gli
americani erano già sbarcati da nove settimane, la bomba era
ormai "un residuato bèllico". Luccicava al sole. Era di colore
del bronzo. Se la doveva per forza portare a casa quella bomba,
Giovanni Riina. Era preziosa. Polvere da sparo per le cartucce
della sculetta e ferro per sostituire il vomere dell'aratro.
Fra le zolle c'era anche un cilindro grigio. Era un proiettile
di cannone, lungo una quarantina di centimetri. Nella parte
superiore era spezzato. L'avevano lasciato i tedeschi,
accampati da quelle parti fino al 10 luglio. Il contadino disse
al figlio Francesco di saltare giù dal mulo, dovevano caricarci
sopra la bomba e anche il proiettile. Si fece aiutare da Totò,
il più robusto dei ragazzi. Sollevarono con delicatezza gli
ordigni, poi l'infilarono in un sacco di juta. E presero la
strada del ritorno in direzione del paese. Un'ora dopo
arrivarono alle porte di Corleone. C'era ancora un caldo grave,
un'opprimente afa. Erano le sei del pomeriggio e nel rione di
piazza Soprana giocavano i bambini. Si rincorrevano per i
vicoli a piedi nudi. Si nascondevano dietro gli alberi. Si
infilavano sotto i carretti. In via Rua del Piano c'era la casa
dei Riina. Era una povera casa di contadini, muri di pietra
grigia e tegole sgangherate. C'era una grande stanza che, da
una parte, diventava anche stalla. Dall'altro lato c'erano i
letti, il tavolaccio di legno, le sedie. E ben allineate a
terra le quartare, brocche di terracotta per conservare l'acqua
fresca. Servivano pure per l'olio quando il raccolto andava
bene. Il padre e i tre figli si fermarono in via Rua del Piano,
all'angolo con via Ravenna, verso le sette. C'era ancora molta
luce. Giovanni Riina decise di disinnescare la bomba americana
nel vicolo, proprio davanti a casa sua. Totò era silenzioso in
un angolo e Francesco lo stava a guardare. Gaetano era seduto
su un muretto, vicino al mulo. Poi portarono il proiettile di
cannone dentro casa. Sembrava vuoto, senza più un grammo di
polvere da sparo. Cominciò a batterlo con una pietra. Il
proiettile sfuggì dalle mani di Giovanni Riina, classe 1897,
contadino di Corleone schedato dai Reali carabinieri come
"soggetto capace di procurare danno alle persone e al
patrimonio altrui". Ci fu un boato. Divampò il fuoco. Ci furono
grida e urla dopo L'esplosione. Giovanni Riina morì sventrato.
Morì anche il piccolo Francesco. Le schegge del proiettile
penetrarono nella gamba destra di Gaetano, gli ferirono il
collo, gli sfregiarono le guance. Anche il mulo era disteso a
terra e non si muoveva più. Era morto anche il mulo. Totò non
aveva un graffio. I funerali si svolsero nella chiesa di Santa
Rosalia due giorni dopo. Era il 13 di settembre. C'era una gran
folla per le strade di Corleone. Una donna vestita di nero si
trascinava verso il cimitero con gli occhi asciutti, non aveva
più lacrime per piangere il marito e il figlio. Era disperata.
Era incinta, Maria Concetta Rizzo vedova Riina. Ventisei giorni
dopo avrebbe partorito Giovanna Francesca. La figlia più grande
le stava vicino. Aveva quindici anni, allora, Caterina. E
teneva per mano Arcangela, l'altra sorella, l'ultima nata. Il
figlio Gaetano era ancora in un letto d'ospedale. Era vivo, un
miracolo l'aveva salvato. L'unico maschio della famiglia che
accompagnava le bare del padre e del fratello Francesco era
Salvatore. Totò. Era lui adesso il nuovo capofamiglia. Era
Salvatore Riina l'uomo che doveva mandare avanti la casa e la
terra. Aveva tredici anni. Portava ancora i pantaloni corti di
pezza come tutti i suoi coetanei, scarpe ricucite di sopra e di
sotto, calzette nere fatte a mano con il cotone che si riusciva
a rimediare. Aveva capelli castani, il viso asciutto degli
adolescenti di quegli anni amari, le mani forti e callose di
chi lavorava per i campi. Le sue braccia erano lunghe, troppo
lunghe. O forse erano solo normali, era lui basso, anche per la
sua età. Già lo chiamavano il Corto, e mai che glielo dicessero
in faccia. Mai quando era così vicino da poter sentire, quando
per caso passava dalla piazza al ritorno dalla campagna. Era un
ragazzo che parlava poco, il piccolo Totò Riina. E quando
parlava ti puntava sempre con quei suoi occhi neri. Che ti
scrutavano, ti svuotavano, ti intimorivano. Come se lui quasi
potesse leggere i pensieri degli altri. Facevano paura, i suoi
occhi. Ma non quel giorno, il pomeriggio dei funerali . Li
teneva bassi. Ogni tanto guardava sua madre, poi chinava ancora
il capo e fissava le sue scarpe rotte. Dalla casa di via Rua
del Piano fino al cimitero disse solo quattro parole: "Murìu me
frati Cicciu". È morto mio fratello Ciccio. A Corleone oggi
giurano che si asciugò più di una lacrima, abbracciato alla
madre e alle piccole donne della sua famiglia. Fu l'ultima
volta che qualcuno lo vide piangere. Il corteo funebre uscì
dalla chiesa di Santa Rosalia che era quasi il tramonto e
lentamente attraversò le strade del paese. La discesa ripida di
via Roma era avvolta nel silenzio. Le bare portate a spalla si
fermarono davanti alla parrocchia di piazza Garibaldi, poi
sparirono in fondo a corso Bentivegna. Si alzò il vento. Il
pianto delle donne diventò straziante sulla stradina polverosa
che scendeva al camposanto. Giovanni Riina e suo figlio
Francesco furono sepolti sottoterra. Due croci di legno in
mezzo a cento croci di legno. Solo diciotto anni dopo - il 26
febbraio del 1961 - le loro spoglie trovarono posto in un
piccolo loculo di via dei Cipressi. La tomba aveva un numero,
il 20, era la quarta da sinistra dall' inizio del viale .
Giovanni Riina e Francesco, M il 12/9/1943. Qualcuno trascrisse
male sul marmo il giorno della loro morte. Il 12 settembre
invece dell' 11. Un anonimo loculo fra le cappelle gentilizie
del cimitero di Corleone. Una lastra bianca e tre fotografie.
Il viso di Giovanni Riina e quello di due donne senza nome.La
mattina del 18 gennaio 1993 nel camposanto di Corleone
entrarono due ragazzini. Era un lunedì. Il sabato prima
Giovanni Francesco e Giuseppe Salvatore erano tornati in paese
con la madre Ninetta e le due sorelle. Il padre era stato
arrestato a Palermo dopo ventiquattro anni di latitanza. I due
figli maschi di Totò Riina - mezzo secolo dopo l'esplosione
della bomba - stringevano nelle mani un mazzo di fiori. Si
inginocchiarono, pregarono sulla tomba del nonno. Quando il
barbiere era anche dentista Il barbiere sapeva sempre tutto.
Sapeva perché poteva sapere. A Corleone il barbiere contava una
spanna più del sindaco e un palmo meno del parroco della
Matrice. Il barbiere era barbiere e anche dentista. Ma
soprattutto era confessore. Aveva il privilegio di custodire i
segreti, le pene e i peccati degli altri. Uno che faceva quel
mestiere doveva per forza ispirare fiducia: dopotutto non era
cosa da niente affidare la propria gola a un estraneo. Il
barbiere di Corleone si chiamava Giovannino. Il suo salone da
barba si affacciava sulla piazza Garibaldi, fra il caffè Alaimo
e l'ospedale dei Bianchi. Nella piccola bottega trascorreva le
sue giornate un ragazzino che stava ad ascoltare per ore e ore
i discorsi dei grandi. "Vituzzu, facci na bedda sapunata o
cavaleri." Vituzzu, fai una bella saponata al cavaliere. Vito
era un bambinetto sveglio che vent'anni dopo sarebbe diventato
sindaco di Palermo. Il potente Vito Ciancimino. Allora era solo
un garzone. Il figlio del barbiere di Corleone. Salvatore Riina
non frequentava il salone da barba di Giovannino. Era una
bottega dove potevano entrare solo i notabili del paese: i
proprietari terrieri, il farmacista, i sensali, l' avvocato, il
decano, i tre medici dell'ospedale. E i mafiosi. La gente come
Salvatore Riina andava in un altro salone da barba. Era sempre
su piazza Garibaldi, ma a quindici metri da quello di
Giovannino; era il barbiere dei contadini. Si pagava una volta
l'anno. Cinquantadue barbe e dodici tagli di capelli in cambio
del frumento - dai quattordici ai sedici chili - che faceva un
tumulo di terra. Il mondo di Totò Riina era la campagna.
All'alba usciva dalla casa di via Rua del Piano e scendeva a
piedi fino a Ma-rabino. Partiva col buio, tornava a casa col
buio. Non c'era Natale e non c'era Pasqua, i giorni erano tutti
uguali. L'odore del brodo di gallina si sentiva nei vicoli solo
in due occasioni, una nascita o una malattia, quando bisognava
nutrire un bimbo o curare un vecchio. La vita dei primi anni
del dopoguerra siciliano era grama e la miseria non aveva
risparmiato Corleone. I campi però erano di terra buona. Terra
profumata. Anche la malaria se n'era andata con il ddt portato
dagli americani. Si sognava la riforma agraria. Ma intanto i
contadini stavano fino al tramonto a guardare sterminate
distese deserte. Colline gialle, che diventavano di un marrone
scuro quando si dava fuoco alla gramigna. L'acqua scendeva
abbondante dal Belice ma non arrivava mai a valle. Il bestiame
vagava alla ricerca di pascolo. C'era lo spettro della fame e
della carestia. Erano i giorni che preparavano l'occupazione
dei feudi. La conquista della terra. I padroni portavano nomi
antichi. Cammarata, Valenti, De Cordova. Baroni, conti,
marchesi. E figli di baroni, di conti e di marchesi passavano
di tanto in tanto nelle tenute. C'erano i campieri che curavano
gli interessi delle loro campagne. Campieri a cavallo con ai
piedi stivaloni di cuoio. Nelle mani stringevano un frustino e
a tracolla portavano il fucile da caccia. Le terre se le erano
prese piano piano i campieri. Nei feudi di Corleone ce n'erano
due che si facevano "rispettare". Uno lo conoscevano come
"Borbone" perché stava alla Ficuzza, fra il bosco e il casino
di caccia che Ferdi- nando IV aveva fatto costruire un secolo e
mezzo prima. Borbone si chiamava Vincenzo Catanzaro. Era un
maffioso figlio di maffioso. L'altro era Salvatore Cascone. Per
la sua fama di uomo saggio era detto "Salomone". Evidentemente
era solo una chiacchiera. Morì dissanguato. Gli spararono in
faccia. Salomone corteggiava con insistenza la moglie di un
pastore gelosissimo. L'agricoltore Salvatore Riina vedeva
passare per le terre i campieri attorniati dai loro uomini.
Brutti ceffi Vigliacchi pronti a scaricare la lupara su qualche
poveraccio. Li vedeva sui cavalli e li salutava con un cenno
del capo, ma solo quando loro gli avevano lanciato uno sguardo.
Soltanto dopo che gli avevano permesso di salutare. Salvatore
Riina sapeva come ci si doveva comportare, sapeva qual era la
legge del feudo. In quei mesi aveva sentito parlare anche di
cosa stava accadendo dietro le montagne di Monreale. A
Borgetto, a Giardinello, a Montelepre. Il bandito Giuliano era
diventato "colonnello". Colonnello dell'Evis, l'Esercito
volontario per l'indipendenza della Sicilia. Tutti dicevano che
Turiddu voleva dare la terra ai contadini. Ma intanto i
contadini li ammazzava. Come a Portella della Ginestra.
Salvatore Giuliano ammazzava anche i carabinieri; ne aveva
fatti fuori centocin-que da quando il suo quartier generale era
sulle rocce di Sàgana. Ammazzava nell'utopia di una "Sicilia ai
siciliani". E intanto scriveva pure a Harry Truman, il
presidente degli Stati Uniti d'America. Ma queste erano cose
che non interessavano più di tanto a un ragazzo di Corleone che
non aveva ancora compiuto diciotto anni. Uno che era condannato
a vivere fra Marabino e Frattina con il suo pezzo di terra. In
campagna con il freddo dell' inverno e con il caldo dell'
estate. Con una famiglia senza padre, tre sorelle e un fratello
più piccolo da campare. Turiddu Giuliano per Totò era un pupo.
Qualcuno muoveva i fili e il bandito di Montelepre sparava. Fu
in quegli anni difficili che Salvatore Riina conobbe un altro
ragazzo come lui. Era uno di quei giovani del paese che
incrociava almeno una volta al giorno per le contrade.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :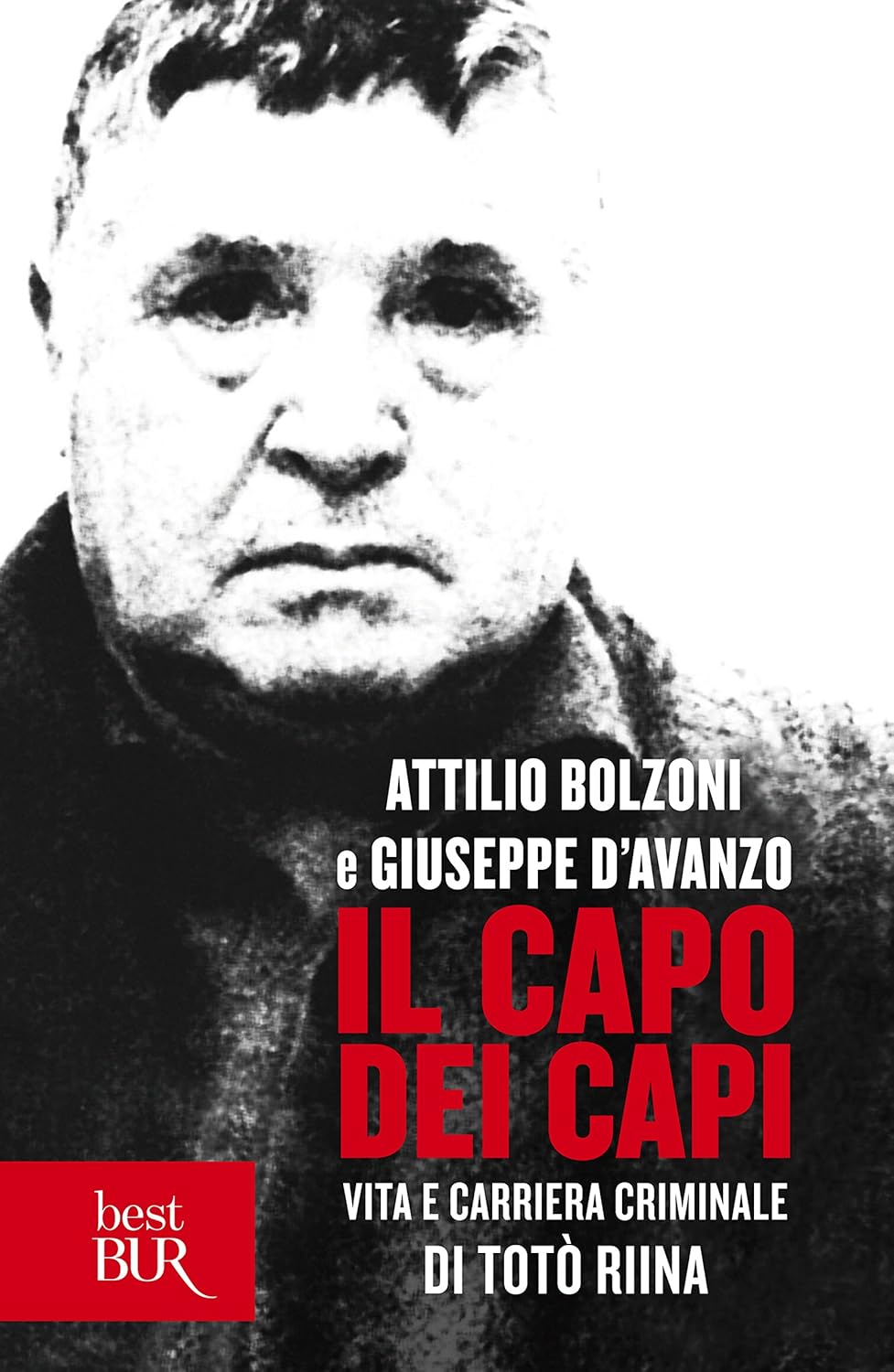





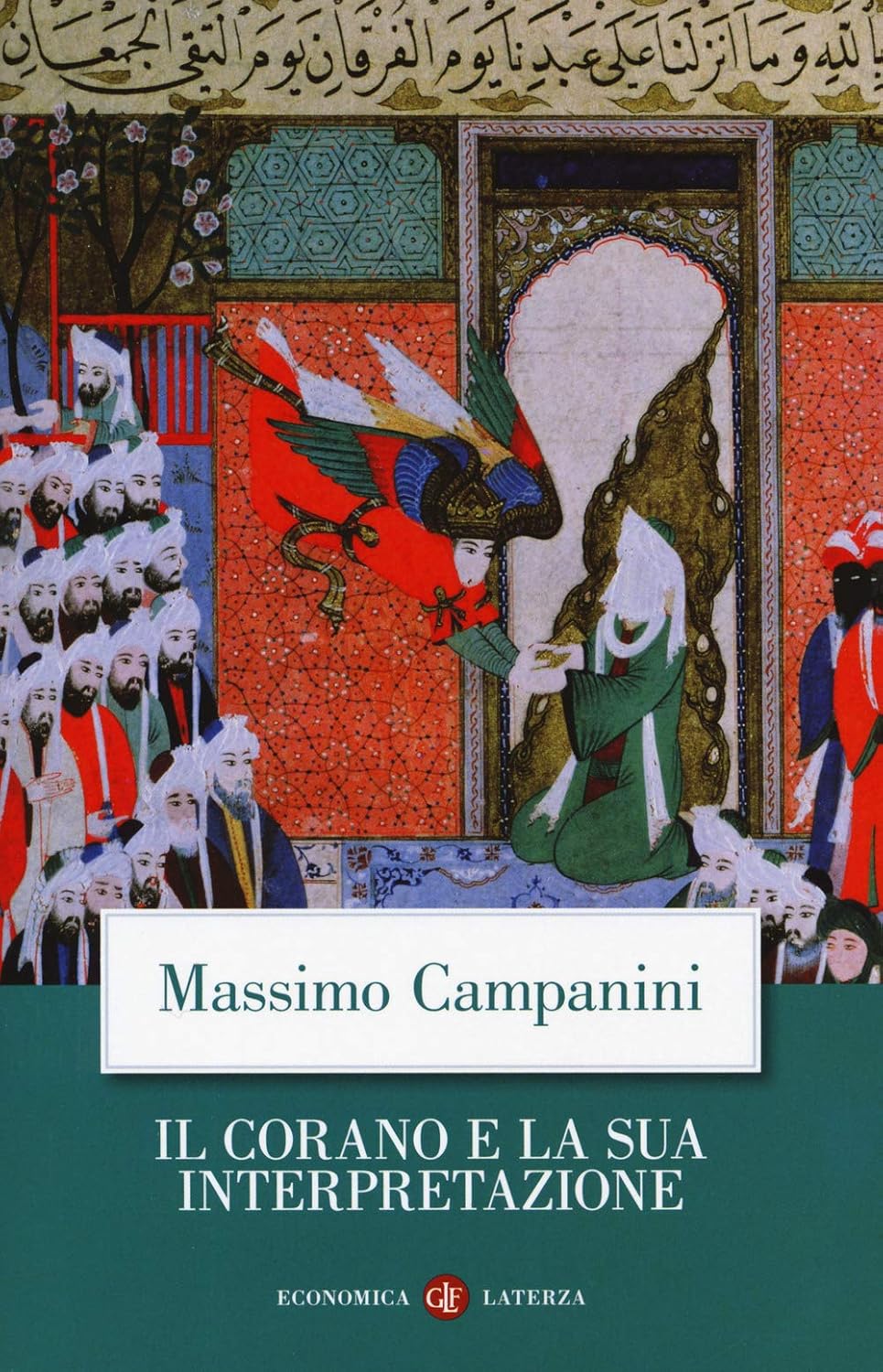
Commento all'articolo