I segreti della cronobiologia – Marie Borrel
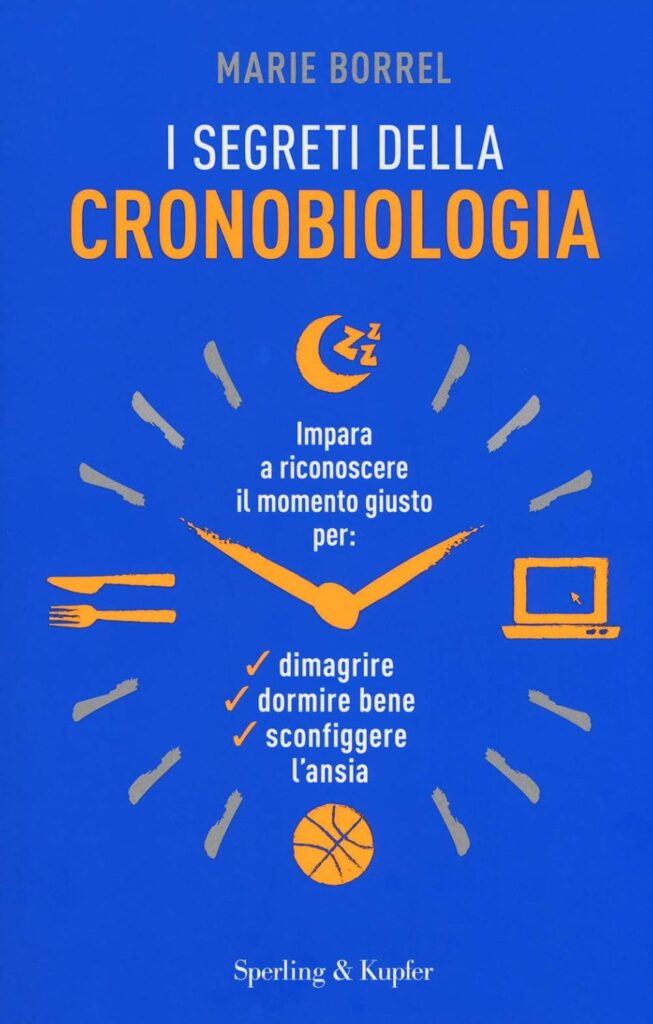
SINTESI DEL LIBRO:
QUANDO si parla di ritmi biologici, il primo cui si pensa è il ciclo
sonno-veglia. Poiché lo sperimentiamo con piena consapevolezza
ogni giorno della nostra esistenza, è il più evidente. Questo ciclo è
strettamente legato a quanto accade nei recessi del corpo e del
cervello. Ma ne esistono molti altri: l’alternanza appetito-sazietà, i
momenti di affaticamento che seguono picchi di attività, la gioia che,
senza apparente motivo, cede il posto alla tristezza.
Come abbiamo visto, seguiamo diversi ritmi interni. Alcuni di essi,
detti circadiani, si strutturano intorno a cicli di circa ventiquattr’ore;
altri possono essere più brevi (ultradiani) o più lunghi (infradiani). Tra
questi ultimi se ne contano alcuni settenari (la cui durata corrisponde
a una settimana circa), altri mensili (di ventotto-trenta giorni), come
quello mestruale, e altri ancora stagionali o annuali. In base a
questo, il professor Alain Reinberg, uno dei pionieri della
cronobiologia in Francia, sostiene: «La ritmicità è una proprietà
fondamentale della materia vivente».1 Di conseguenza, alle
domande normalmente poste dal medico (dove, perché e come),
bisognerebbe aggiungerne una nuova: quando? Reinberg prosegue:
«Qualsiasi materia vivente rappresenta uno stato di non-equilibrio.
Per ogni specie animale o vegetale esiste anche una scansione
temporale coerente, una vera e propria anatomia temporale che
completa la tradizionale anatomia spaziale». La vita, pertanto, non si
troverebbe mai in una condizione di equilibrio, ma dipenderebbe da
molteplici stati di squilibrio in correlazione tra loro.
Prendiamo in esame questi ritmi biologici, visibili e non.
L’ORIGINE DEL TERMINE
Il termine «cronobiologia» deriva dal greco chronos, che significa «tempo», al quale
sono state aggiunte le due radici da cui è formata la parola «biologia»: bios, che
rimanda all’insieme dei fenomeni che interessano gli esseri viventi (la vita), e logos,
che significa «discorso» o «parola». La cronobiologia è pertanto lo studio delle
manifestazioni temporali della vita. In altri termini, l’esplorazione dei ritmi.
All’origine dei ritmi biologici: la genetica
I ritmi biologici non hanno nulla a che vedere con l’educazione,
l’ambiente famigliare, le abitudini dell’infanzia. Dipendono dai geni.
Vi sentite particolarmente in forma la mattina appena alzati, ma la
sera fate fatica a restare svegli? Siete stati «programmati» in questo
modo. Non avete alcuna difficoltà ad andare a dormire tardi, ma il
suono della sveglia è una tortura? La colpa è dei vostri ritmi biologici.
Gli specialisti parlano di «cronotipi» per indicare profili cronobiologici
che variano da individuo a individuo (vedi più avanti).
Lo stesso vale per tutti gli altri ritmi, anche i più impercettibili,
sebbene con qualche distinguo. Alcuni cicli variano ben poco da una
persona all’altra e nel corso dell’esistenza. È il caso, per esempio,
del cortisolo. Questo ormone, indispensabile per la sopravvivenza,
possiede un ciclo di produzione molto stabile e poco sensibile ai
fattori esterni. Altri cicli, invece, assai meno costanti, variano per
l’intervento di sincronizzatori esterni. Parlando sempre di ormoni, la
melatonina, la sostanza che ci fa addormentare, è prodotta di sera,
al calare della luminosità; essa è dunque condizionata dalla stagione
(variazioni nella durata delle giornate, nelle ore di luce solare
eccetera) e dallo stile di vita.
RITMI DI VITA E… DI MORTE
Da migliaia di anni, i criteri che consentono di stabilire il decesso di un individuo
sono molto cambiati. È lontana l’epoca in cui si passava uno specchietto davanti alla
bocca del moribondo per controllare se respirasse ancora, o l’epoca in cui se ne
mordeva l’alluce (da cui il termine «beccamorti»). Nei decenni appena trascorsi si è
passati prima alla misurazione del battito cardiaco e in seguito al tracciato
dell’encefalogramma. Oggi, in caso di morte, i migliori protocolli scientifici si
affidano allo studio dei ritmi biologici dei defunti. Analizzando tipi diversi di tessuto,
è possibile rintracciare le sostanze specifiche (soprattutto proteine) secrete in
funzione degli orologi endogeni e misurarle in modo sempre più preciso per
determinare con esattezza l’ora del decesso. È il punto di incontro tra i cicli
individuali e il calendario universale.
Ciononostante, dire che i ritmi biologici dipendono dalla genetica
non equivale ad affermare che siano immutabili. Pur non potendo
cambiarli completamente, possiamo influenzarli. I ritmi meno stabili,
quelli che subiscono maggiormente gli effetti delle condizioni
ambientali, sono quelli più facili da «ritarare», ma sono anche quelli
che più di frequente possono alterarsi. In tutto questo, in fin dei conti,
non c’è nulla di strano.
I ricercatori hanno scoperto l’origine genetica dei ritmi studiando
coppie di gemelli monozigoti (derivanti cioè da una singola cellula
uovo) e dizigoti (derivanti da due cellule uovo distinte). I primi
condividono lo stesso patrimonio genetico, mentre i secondi, pur
essendo fratelli, possiedono ciascuno il proprio corredo di geni.
Diversamente da quanto accade con i gemelli dizigoti, il cronotipo
dei gemelli monozigoti si è rivelato estremamente simile.
LA GENETICA DEGLI INSETTI
Gli scienziati hanno identificato i geni che controllano i ritmi biologici in molte specie
animali. La mosca drosofila femmina, per esempio, è spesso oggetto di studio
perché i risultati delle ricerche sono facilmente applicabili agli esseri umani. Il
responsabile di alcuni dei suoi ritmi è un gene detto Per, localizzato sul cromosoma
X. La sua presenza è bilanciata da un altro gene, Tim, che, mutando, è in grado di
neutralizzarlo. Nella femmina della drosofila, il gene Per regola i cicli di deposizione
delle uova. In entrambi i sessi, governa anche l’alternanza sonno-veglia e attività
riposo. Inoltre, è il gene che spinge i maschi a «cantare» per attirare le femmine. La
scienza non ha ancora identificato chiaramente i geni portatori dei ritmi biologici
negli umani, ma potrebbe farlo a breve.
Dove si nascondono gli orologi interni?
I ritmi biologici non nascono dal nulla. Sono per la maggior parte
coordinati da un gruppo di cellule cerebrali: il nucleo
soprachiasmatico. Questa piccola struttura, localizzata nella parte
anteriore dell’ipotalamo, si occupa della sincronizzazione dei cicli
endogeni. Più propriamente, bisognerebbe parlare di nuclei, al
plurale, dato che ne possediamo due: uno per emisfero. Sono
strettamente correlati, e ciascuno è costituito da circa 10.000 cellule
cerebrali. Questi 20.000 neuroni hanno una particolarità: «pulsano»
a un ritmo regolare, seguendo la loro programmazione genetica. E
non è tutto: questa pulsazione è governata anche dalle informazioni
provenienti dall’esterno, in particolare dalla luce (vedi Capitolo 2).
Tali nuclei controllano in primis i ritmi circadiani, che si ripetono
ogni ventiquattr’ore, essendo «regolati» anche dalla luce. Senza
punti di riferimento luminosi, come abbiamo visto, la durata di questi
ritmi varia leggermente. È dunque dai nuclei soprachiasmatici che
partono quegli «ordini» che governano numerose funzioni che
seguono cicli giornalieri. I messaggi vengono poi trasmessi al corpo,
in direzione delle ghiandole o degli organi interessati. In tal modo gli
ormoni sono secreti ogni giorno a orari precisi, seguendo un ciclo
oscillatorio caratterizzato da picchi massimi e minimi.
QUATTRO PARAMETRI PER UNO STUDIO
La scienza dei cicli biologici si basa sullo studio di quattro parametri.
In primis, il periodo, ossia la durata media di un ciclo: un giorno, una
settimana, un mese…
Poi, la posizione dei picchi. I cicli si compongono di movimenti ritmici scanditi
in crescita, raggiungimento di un culmine, diminuzione, discesa verso il punto
più basso. Lo studio di questi picchi (zenit o acrofase in alto e nadir o barofase
in basso) fornisce ai ricercatori informazioni preziose.
Gli scienziati sono interessati anche all’ampiezza dei cicli, ossia alla distanza
che separa l’acrofase dalla barofase.
Infine, il livello medio. Si tratta della media tra i valori più alti e quelli più bassi.
Combinando tutti questi paramenti, chi si occupa di cronobiologia studia i ritmi e ne
scopre i segreti.
I
nuclei soprachiasmatici non funzionano da soli, ma ricevono
informazioni in tempo reale su quanto accade nell’ambiente
circostante da messaggi trasmessi da altre zone del corpo, in
particolare dai tessuti periferici, come la pelle.
Non conosciamo ancora tutto su questi meccanismi. Per esempio,
ignoriamo le ragioni per cui la loro durata si assesta intorno alle
ventiquattr’ore. Forse è semplicemente una regolazione naturale in
armonia con la rotazione terrestre? Avrebbero una durata diversa se
il
nostro pianeta ruotasse intorno al proprio asse in ventisette,
ventotto o trenta ore? Impossibile rispondere, ma una cosa è certa:
questi meccanismi esistono, e i ricercatori ne hanno calcolato
l’impatto sulla nostra vita.2 Un altro elemento più volte verificato
dagli scienziati è che, negli animali, la distruzione di tutto il nucleo
soprachiasmatico o di una sua parte provoca un’alterazione o la
scomparsa di alcuni ritmi biologici. Nei ratti, per esempio, quando
questo gruppo neuronale viene danneggiato, i cicli del sonno
vengono sovvertiti. Nei topi e nei criceti sono state osservate
alterazioni nella secrezione di diversi ormoni (acetilcolina, prolattina
eccetera), nello stimolo della fame e della sete e nella temperatura
corporea. Reinnestando cellule cerebrali specializzate nei nuclei
danneggiati diventa invece possibile ripristinare le funzioni biologiche
compromesse.
NELLO SPAZIO
Gli astronauti l’hanno sperimentato: nello spazio i ritmi biologici vengono alterati. Gli
«oscillatori temporali» si sfasano e le radiazioni ambientali desincronizzano i loro
cicli. Le prime conseguenze si ripercuotono sull’alimentazione. L’assenza di gravità
rallenta la digestione e l’assimilazione dei nutrienti, lo stimolo della fame scompare e
a poco a poco passa la voglia di mangiare. L’importante perdita di massa muscolare
riscontrata nei piloti che rientrano da lunghi soggiorni nello spazio è dovuta sia a
una diminuzione dei movimenti dovuta agli spazi angusti delle cabine sia all’assenza
di gravità, che limita gli sforzi muscolari, ma soprattutto alle profonde alterazioni del
metabolismo delle proteine, il cui ritmo viene gravemente deteriorato. Tutto questo
ostacola il rinnovamento delle cellule muscolari.
Nonostante possa sembrare estremamente semplice – un unico
orologio centrale che regolerebbe tutta la nostra vita biologica –, la
realtà, come spesso accade per ciò che riguarda il corpo umano, è
un po’ più complessa. Possediamo infatti anche «orologi secondari»
localizzati nel fegato, nei reni, nelle arterie, nel cuore. Quello del
fegato regola soprattutto le variazioni del tasso di glucosio nel
sangue, che deve restare stabile anche se l’apporto alimentare viene
frazionato nel corso della giornata. Nel tubo digerente, un altro
orologio secondario si occupa di preparare l’apparato alla digestione.
Nel sistema cardiovascolare, diversi tipi di recettori controllano le
variazioni della pressione arteriosa, della coagulazione del sangue o
dell’apporto di ossigeno al muscolo cardiaco, ritarandone
incessantemente i cicli, dato che nessuno di questi parametri è
costante.
Riuscite a immaginare la quantità di lavoro? Un complesso di ritmi
diversi, di durata e ampiezza differenti, costretti a convivere e a
sincronizzarsi in un sistema coerente, quest’ultimo coordinato con
l’ambiente esterno e con le sue variabili. Un rompicapo che
l’organismo, altamente performante, riesce a risolvere giorno dopo
giorno.
Gli ingranaggi degli orologi: gli ormoni
La maggior parte dei ritmi biologici è regolata dagli ormoni: il
cortisolo, che stimola l’energia in alcuni momenti della giornata; la
melatonina, che ci accompagna nel sonno quando viene sera; la
vasopressina, che blocca lo stimolo a urinare durante la notte; gli
ormoni sessuali, che controllano il ciclo mestruale e la sessualità; la
grelina, che ci fa sentire appetito quando l’organismo è a corto di
carburante. Tutti questi ormoni sono come lettere che l’organismo
combina per formare prima delle singole parole, poi delle frasi,
quindi dei libri interi. Se a scandire il ritmo è il nucleo
soprachiasmatico (assistito dagli orologi secondari), sono gli ormoni
che avvertono gli organi e gli apparati interessati che è il momento di
dedicarsi a questa o all’altra attività.
Un ormone è una sostanza secreta in piccolissime quantità da
una ghiandola allo scopo di trasmettere un messaggio a un luogo
preciso del corpo. Avete mai aperto un vecchio orologio? Al suo
interno, tanti ingranaggi dentellati (alcuni minuscoli, altri molto più
grandi) si incastrano gli uni con gli altri per consentire alle lancette di
muoversi a tempo, ciascuna secondo il proprio ritmo. Nell’organismo
succede qualcosa di molto simile, solo che a dover essere
sincronizzato non è soltanto il movimento di due lancette, ma un
numero infinito di processi. E questo è possibile grazie all’intervento
degli ormoni, che sono come ingranaggi di un orologio sui generis.
Sarebbe impossibile descrivere il viavai degli ormoni, che si
incrociano, si scambiano informazioni, modulano i loro messaggi… E
tutto questo notte e giorno, senza sosta. Sarebbe troppo complicato
e,
ammettiamolo, anche un po’ noioso. Tuttavia, a scopo
esemplificativo, trovate di seguito qualche scena di quello spettacolo
che si svolge nei più segreti recessi del vostro corpo nel corso di una
normale giornata.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :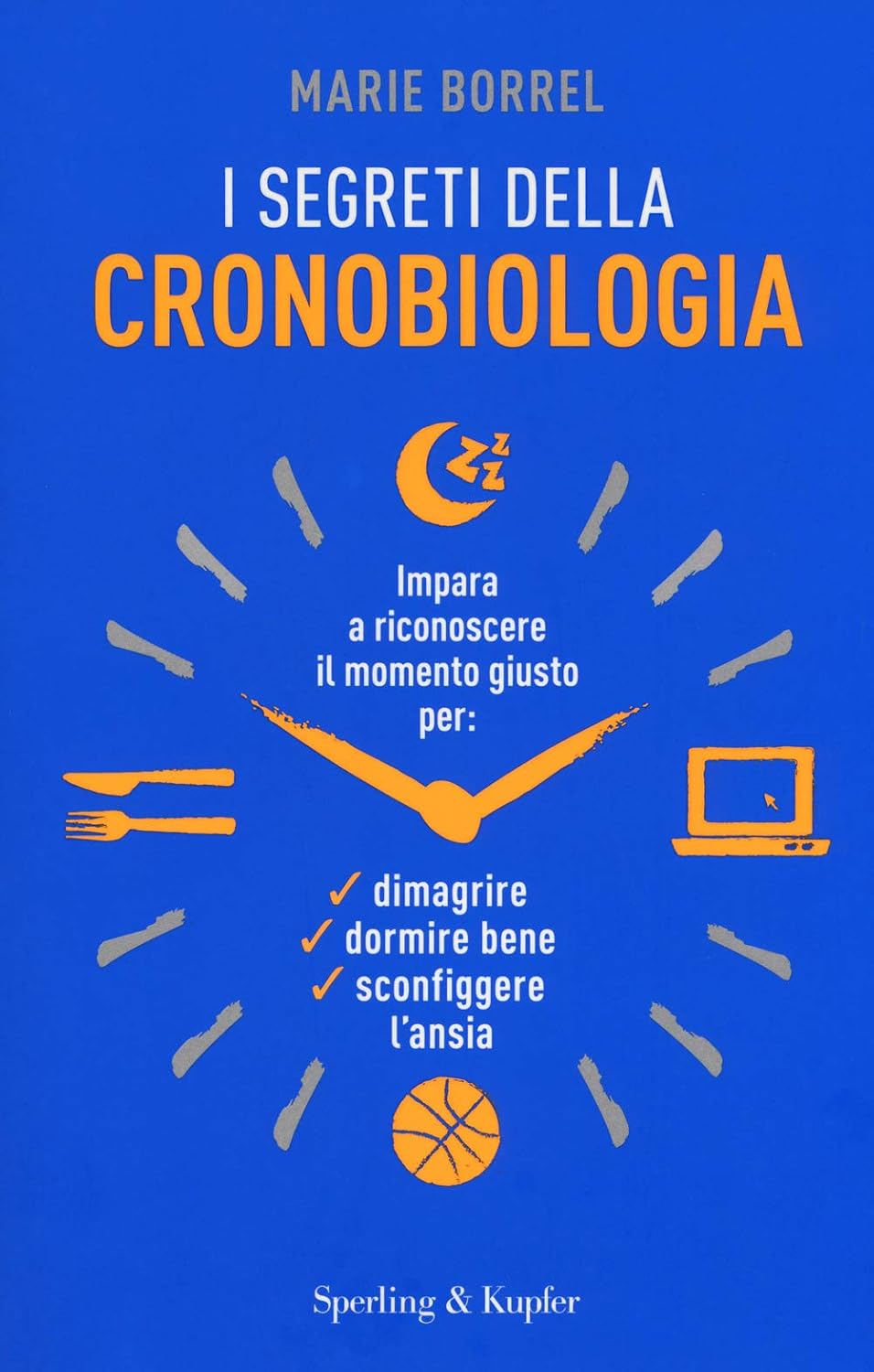






Commento all'articolo