Il caos italiano – Paolo Mieli

SINTESI DEL LIBRO:
La formazione del ceto permanente di governo
Quando si parla della storia d’Italia va sempre tenuto a mente che alle prime
elezioni, nel 1861, ebbero diritto di voto 420.000 elettori maschi, meno del
2% della popolazione, e andò a votare solo il 56% di loro, talché il primo
Parlamento del nostro Stato unitario venne eletto da circa l’1% degli
abitanti. In molti collegi furono sufficienti meno di 200 voti per mandare a
Torino un deputato; in uno, solo 89.
Il Regno d’Italia e l’Unità del Paese nascono dunque, come afferma
Michele Salvati nel suo libro Tre pezzi facili sull’Italia. Democrazia, crisi
economica, Berlusconi, «dall’alto», sono costruiti «da un’élite molto
ristretta, da un ceto di politici liberali grosso modo divisi in una destra
monarchica, moderata o conservatrice, e in una sinistra in cui confluiscono
gli eredi delle forze repubblicane e mazziniane». «Non ho niente contro
questa costruzione dall’alto» continua Salvati, «molte unità statali nascono
come costruzioni di élite e poi riescono a coinvolgere con successo il
popolo nel processo di ampliamento della democrazia.» Ma a questa
seconda fase da noi ci si arrivò tardi, molto tardi. Anche restando
nell’ambito di una «costruzione di élite», la nostra nasce con un vizio
d’origine: l’esclusione delle élite cattoliche, la conquista in armi dello Stato
pontificio e il non expedit di Pio IX – la proibizione ai cattolici di
partecipare alla vita politica di uno Stato che la Chiesa non riconosce –
renderanno debole il fronte borghese, con conseguenze molto gravi sulla
«qualità democratica» dei governi liberali e sulla stessa «tenuta della
democrazia» nelle prove che essa sarà costretta ad affrontare dopo la
Grande guerra.
Per cinquant’anni, nella fase iniziale della storia d’Italia, «i cattolici e le
loro organizzazioni sono una forza estranea che non riconosce la legittimità
dello Stato, una forza extrasistema, se non antisistema». Sono i «neri»,
come li definivano i liberali. Ai quali andavano ad aggiungersi – sul
versante politico opposto – i «rossi», cioè i repubblicani intransigenti e i
rappresentanti di quei ceti popolari vessati da condizioni di miseria estrema,
i quali andranno a costituire la nervatura e l’ossatura del Partito socialista
che nascerà a Genova nel 1892 (in Germania la Spd era stata creata nel
1869). I rossi, ancor più dei neri, sono forze antisistema e, per trovare un
inizio di dialogo tra socialisti e liberali, tra Filippo Turati e Giovanni
Giolitti, si dovrà attendere la vigilia della Prima guerra mondiale.
Sulla scia di due studi molto importanti – Il trasformismo come sistema
di Giovanni Sabbatucci e Storia d’Italia e crisi di regime di Massimo
Salvadori – Salvati individua in quel che si è appena detto l’origine dei
problemi successivi: Destra e Sinistra storica non potevano opporsi l’una
all’altra come in Inghilterra, patria della democrazia rappresentativa,
facevano già allora i Whigs, liberali, e i Tories, conservatori. Nell’assillo
che, in caso di sconfitta, la Destra scegliesse di allearsi con i «neri
antisistema», e la Sinistra con i «rossi antisistema», così da poter giungere a
uno strappo della tela unitaria, in quell’assillo, dicevamo, la lotta politica fu
soprattutto una lotta interna a un’unica grande maggioranza. Una gara la cui
posta era la leadership della maggioranza stessa, mai la formazione di una
maggioranza alternativa. In un bel libro, Ottocento. Lezioni di storia
contemporanea, Raffaele Romanelli spiega come anche il passaggio del
1876 dalla Destra di Marco Minghetti alla Sinistra di Agostino Depretis non
si configurò in un quadro di alternanza. Depretis portò al governo
un’«amalgama», come allora fu detto, di un centro aperto alla sinistra
moderata (in particolare quella meridionale) «che teneva a distinguersi a
sinistra dai gruppi più radicali e a destra dai più retrivi». Agli uni e agli altri
«mancavano peraltro programmi e punti di riferimento forti, tali da
connotarli in positivo e da fondare una dialettica parlamentare». E così,
prosegue Romanelli, «il modello centrista, essendo privo di effettivi
antagonisti, risultò dall’occasionale accorparsi attorno al governo di singoli
deputati o gruppi; agiva in questa direzione anche la debolezza della
presidenza del Consiglio, giacché il regime parlamentare si era instaurato
per via di prassi e formalmente il capo dell’esecutivo era tuttora il re».
Qualche tempo dopo Depretis si compiacque della capacità dei parlamentari
di «trasformarsi» scegliendo la via del «progresso». Ma questo verbo
«divenne presto uno stigma negativo e “trasformismo” divenne sinonimo di
accomodamento interessato, privo di idealità e di forza, di quell’attitudine
alla transazione – alimentata dal connubio di parlamentarismo all’inglese e
di accentramento amministrativo alla francese – per la quale i singoli
deputati patteggiavano il loro sostegno alla maggioranza in cambio di favori
al proprio collegio, o agli interessi di riferimento, in genere agrari,
industriali, finanziari».SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
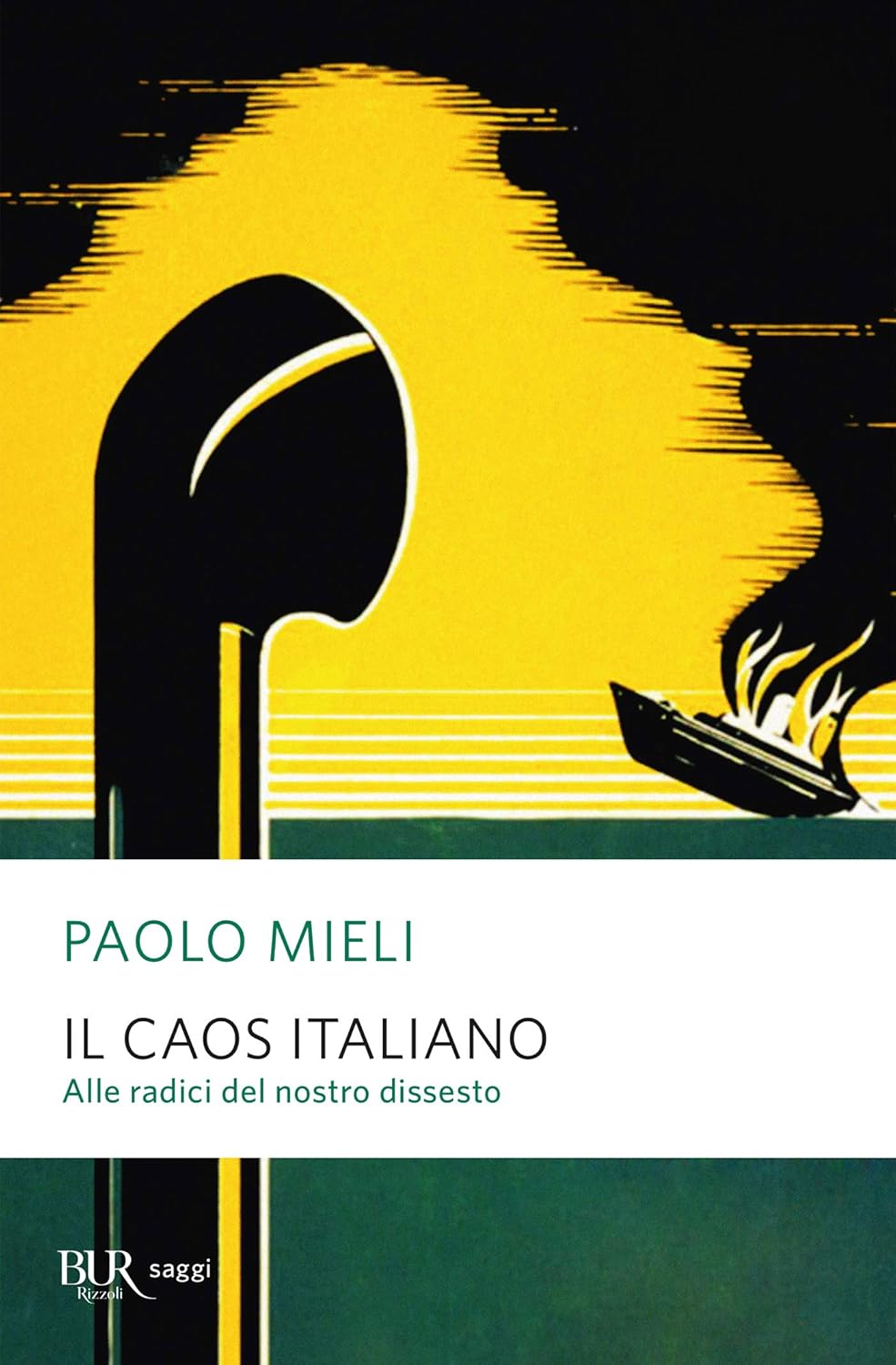






Commento all'articolo