Guida sentimentale di Venezia – Diego Valeri
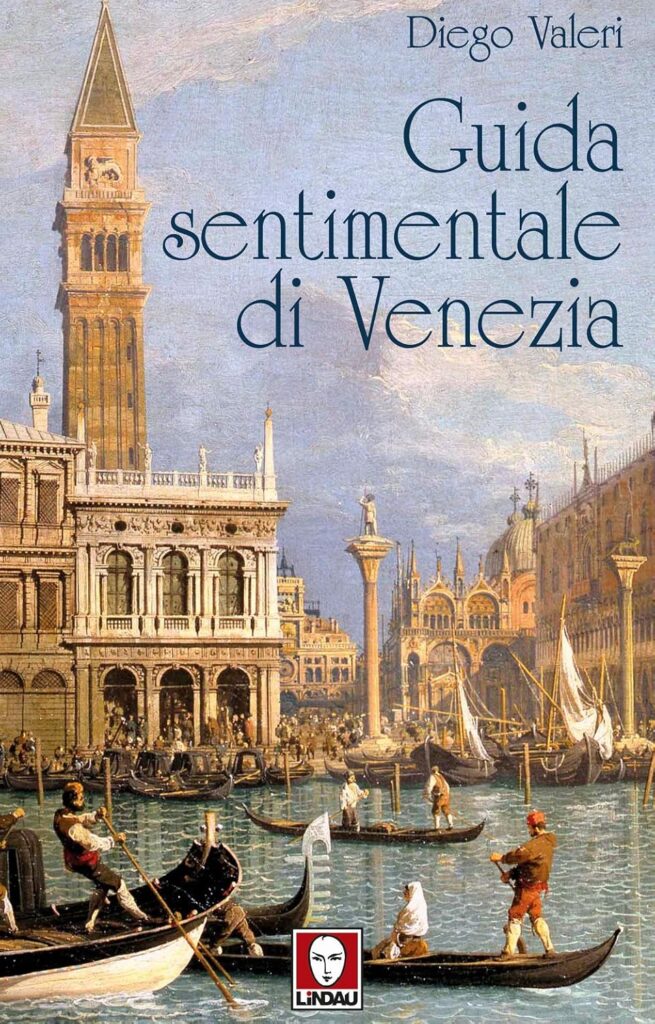
SINTESI DEL LIBRO:
Quei nostri santi padri che, mille e più anni fa, posero mano alla
costruzione di questa macchina straordinaria dovevano pur avere,
insieme con una enorme provvista di testarda volontà, un grano di
generosa pazzia.
Pensate: non si trattava soltanto di trasformare in abitabile
contrada un pantano vago, tagliuzzato e slabbrato per ogni verso da
errabondi canali, ma di piantarvi sopra tante case e tante chiese,
quante bastassero ai bisogni materiali e spirituali di tutto un popolo
chiamato a raccolta dalle rive del mare e dalle sparse isole della
laguna: di fare insomma, di una desolata palude una vera e propria
città.
Quei vecchi s’erano affezionati alle velme, alle barene, alle acque
lutolente tra cui i loro vecchi, profughi dalla terraferma, avevano
cercato scampo dal furore dei barbari. Alle antiche città abbandonate
non ci pensavano più: erano ormai veneziani, già prima che Venezia
nascesse.
Ed eccoli all’opera, palafitticoli in grande e novissimo stile. Prima
si costruiscono il terreno, conficcando nel molle limo intere foreste
tirate giù a forza dalle valli del Cadore; poi, squadrando la pietra
trasportata per mare dalle cave dell’Istria, innalzano gli edifici. La
città si delinea, si forma, cresce, con le sue calli, i suoi campi, le sue
fondamente, i suoi ponti, il suo palazzo dogale, il suo San Marco, la
sua piazza. Appare Venezia «in acqua, sanza mura», come dirà
Franco Sacchetti; comincia la sua storia grande…
Ora, a vederla tal quale s’è fatta in dieci secoli di storia e civiltà
sue, non v’è chi non resti «di stupor compiuto». Forse, più che la
vaghezza delle sue fantasiose architetture, ciò che colpisce la mente
e l’anima è la stranezza del suo organismo di città, unica sulla faccia
della terra.
Quell’antico umor bizzarro, ch’è il lievito della prima concezione,
diventa, sollecitato di continuo dalla necessità, la legge che governa,
attraverso tanto evo e tante vicende, il lavoro dei costruttori,
sottomettendolo e imponendolo alle forze della natura: è il fiat e il
metodo della lunga creazione, tutta arbitraria e tutta felice.
Non è questa la città dove, come in una fantasia di Leonardo, si
cammina sulle acque? I canali entrano e girano dappertutto, mobili
strade che montano e calano secondo che il mare solleva e abbassa
il suo petto; davanti a ogni porta di casa, notava fin dai suoi tempi
l’arguto Cassiodoro, è legata la barca «come un animale
domestico», cavalluccio inquieto o paziente somaro; sulle peate
accostate alle rive si fa mercato di verdure, di frutta, di pesce; dentro
le chiuse stanze si riflette la gibigianna del sole nell’acqua, giocando
senza posa sulle pareti e sui soffitti. Dovunque vai, se abbassi gli
occhi, vedi una città rovesciata dentro un cielo più lucido del vero; se
li alzi, vedi bagliori e scintillii trascorrere sulle facce dei palazzi, che
non son più marmo e mattone, ma una materia magica simile a
quella onde si formano i sogni e le pitture. Tutto è pittura, pittorico
sogno, in questo fisico e metafisico paese; anche la più solida e
massiccia architettura, anche la tua propria persona di carne e
d’ossa.
Vedi la gente che sale e scende dai ponti con lievi moti di danza:
son macchiette del Guardi. Le cupole di San Marco, della Salute, del
Redentore: nuvoloni sciroccali di Giambattista Tiepolo. Vedi, sul
declinar dell’autunno e del giorno, i favolosi sfondi del Tintoretto
disegnarsi, dietro turchini velari di malinconia, a ogni fuga e svolta di
canale. E nella gran luce d’estate brillare dovunque i verdi e i rossi di
gemma del Veronese; e la sovrana maestà di Tiziano splendere
come un altro sole su tutte le cose; e dai pallidi visi delle fanciulle
trasparire il lume perlaceo delle vergini di Giambellino, o il cupo
sangue amoroso delle donne di Giorgione…
Venezia: orbis pingens et pictus.
Qui si fa avanti qualche tetro e gelido oltremontano a maledire la
città pittoresca e pittorica, antirazionale, illusoria, ti-vedo-e-non-ti
vedo, e (orror degli orrori) sensuale: l’anti-città insomma. C’è
addirittura chi disserta della «bassesse de Venise»; come quel
Lucien Fabre, accreditato poeta della «Connaissance» (accreditato
da Paul Valéry in persona), il quale poi candidamente dimostra di
non conoscere nulla di nulla della nostra storia. La verità vera, di
tutta evidenza, è che non si dà, forse, sotto il cielo una città più città
di questa: si vuol dire più improntata di energia costruttiva, più
coerente in sé stessa, più rigorosamente condizionata al viver civile.
Altri, e non son pochi, confondendo la vita col moto materiale e
col frastuono confuso delle moderne attività meccaniche, parlano,
sgomenti e inorriditi, di una oziosa e morbosa e contagiosa tristezza
di Venezia.
Altri, infine, riprendendo un frusto motivo romantico, si attaccano
a Venezia appunto per codesta tristezza: non ne sentono e non ne
amano che la bellezza guasta, la stanchezza febbrile, ossia quel
senso e gusto della morte ch’essi portano e covano voluttuosamente
dentro di sé. La città diventa ai loro occhi una grande tomba sospesa
sulle acque, custodita da neri cherubini e da lunatiche larve.
È il caso di un Maurice Barrès e di un Thomas Mann; ai quali
nessuno vorrà, certo, disconoscere un forte potere fantastico e
suggestivo, ma nei quali è poi facile diagnosticare il male tipico dei
decadenti di principio di secolo, marci di delicatissimi amori.
Anche a codesti errori di malati c’è da opporre una verità
chiarissima, di comune dominio e di non minore virtù poetica:
Venezia è città che sveglia nei ben vivi tutte le potenze vitali,
impedendoli di acquietarsi nell’automatismo dei consueti sentimenti
e pensieri, donando loro sempre nuovi motivi di stupore e di
esaltazione.
(Contro Barrès, occorresse, potremmo citare André Suarès: «La
séduction la plus puissante de Venise se révèle: loin d’être le calme,
c’est l’indifférence à tout ce qui n’est pas un grand sentiment». E
contro Mann, August von Platen:
Und sieh! da kam ein mut’ges Volk gezogen,
Paläste sich und Tempel sich zu bauen
Auf Eichenpfähle mitten in die Wogen…)
Emergente ogni attimo dal travaglio di una nuova cosmogonia, e
nell’attimo stesso disciplinata al numero di un ordine supremamente
umano, formata sul più vivo e indocile degli elementi di natura dalla
più viva e strenua delle facoltà morali ‒ la volontà di possesso ‒,
Venezia si può ben dire una città di vita.
Non per nulla è nata qui la più affermativa e libera e gaudiosa
pittura che il mondo conosca.
«La pittura veneziana ‒ dice Bernard Berenson, e dice tutto ‒ è
l’espressione artistica più completa del Rinascimento italiano; di
quell’età di giovinezza pura che s’impadronisce della vita intera
come d’una materia plastica.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :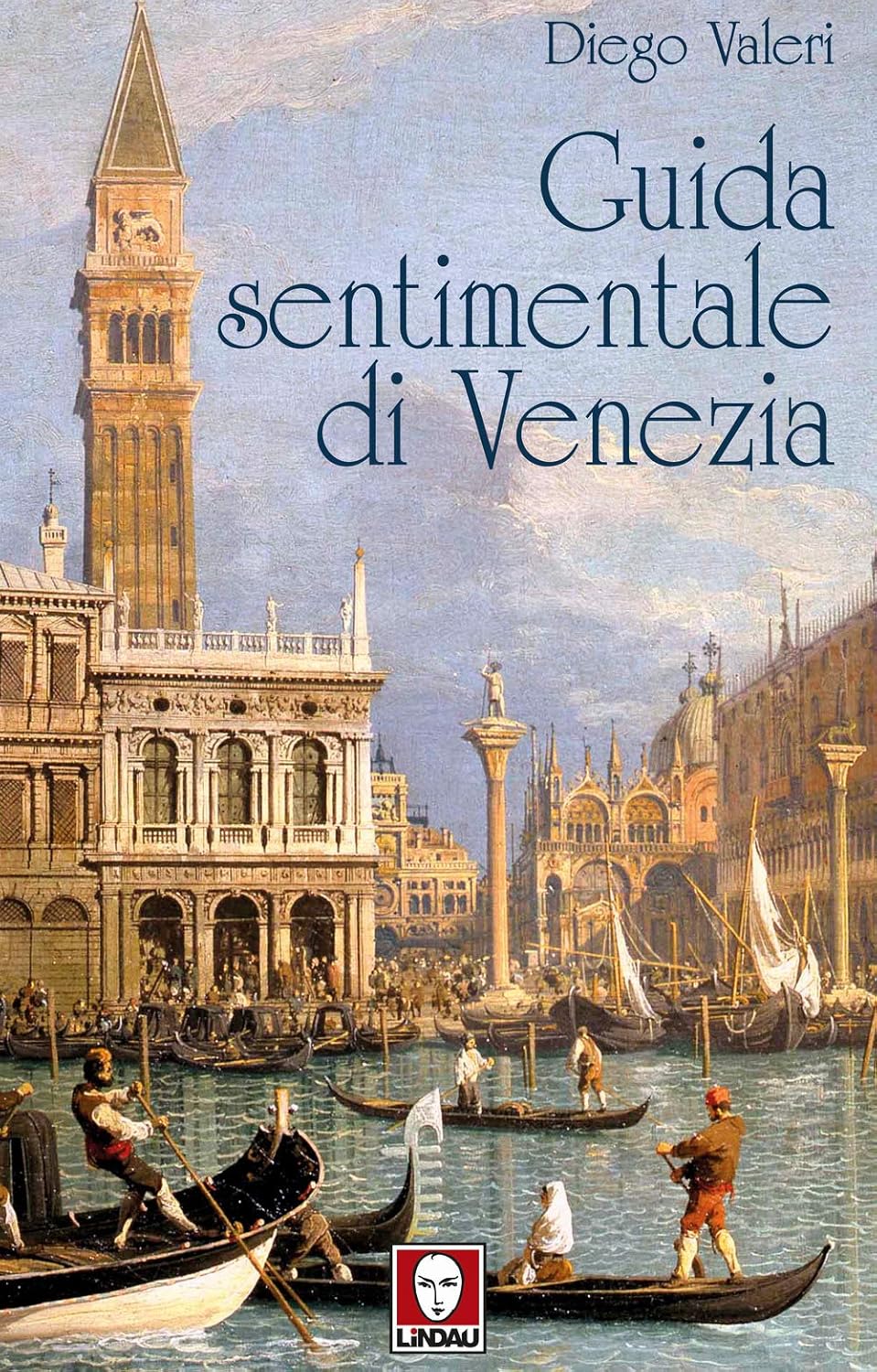






Commento all'articolo