Grammatica per cani e porci – Massimo Birattari
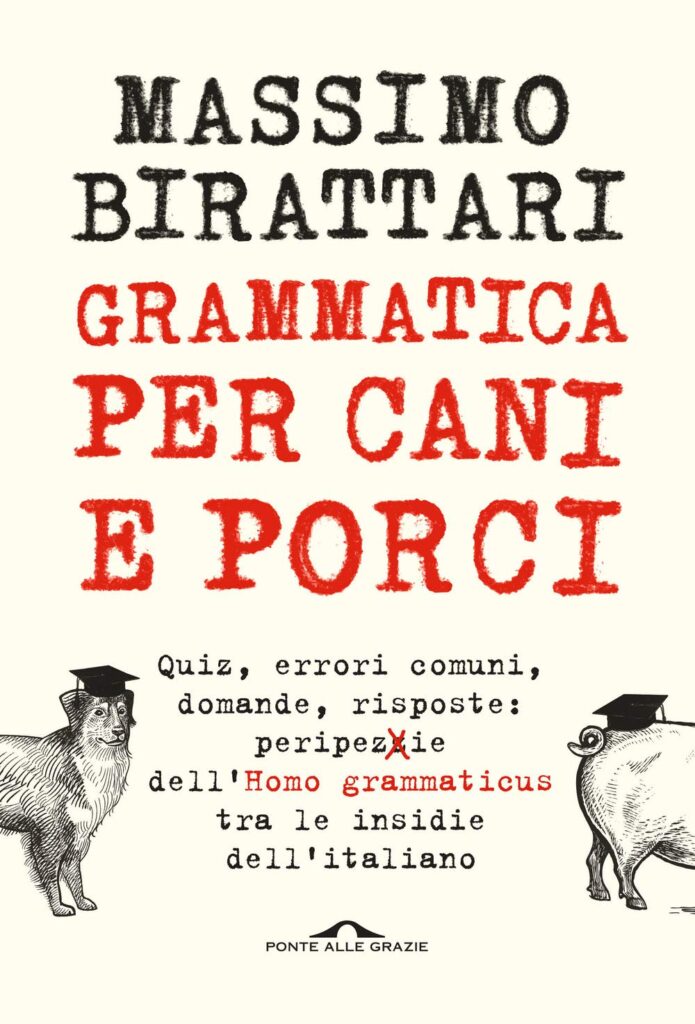
SINTESI DEL LIBRO:
Compaiono periodicamente, nelle edizioni online dei quotidiani, le
classifiche degli errori più comuni in italiano, o gallerie fotografiche
che documentano madornali spropositi comparsi su muri, cartelli di
negozi, messaggi privati o pubblici. Non sono sempre veri al cento
per cento (talvolta c’è lo zampino di Photoshop), strappano un
sorriso o una risata sguaiata, e in sé non sono né particolarmente
gravi né particolarmente interessanti. Non sono nemmeno la
testimonianza dell’irreparabile decadenza della nostra lingua.
Semplicemente, una volta un adulto sgrammaticato gli errori li
faceva a voce, a beneficio dei pochi che lo ascoltavano; al massimo,
poteva spingersi fino a storpiare i nomi delle verdure sui cartellini al
mercato (per anni mi sono chiesto come si chiamassero davvero
quegli strani bulbi simili a cipolle sporche di terra: lampaccioni,
l’ampascione?). Adesso tutti passiamo il tempo a scrivere, e (come
sa anche chi non conosce il latino) verba volant, scripta manent. E
gli errori scritti si possono fotografare, salvare, condividere.
Tra questi errori, molti hanno a che fare con la q, questa lettera un
po’ fossile vivente e un po’ marchio d’infamia che turba i nostri sonni
fin dalle elementari e la cui presenza o assenza è associata ad
alcuni tra i peggiori strafalcioni dell’ortografia italiana.
Per questa ragione non manca mai, nelle gallerie degli orrori, un
cartello da supermercato più o meno come questo:
Scoppiamo a ridere, ed è una risata consolatoria (noi così in basso
non cadremo mai, ci diciamo), e il riso diventa irrefrenabile quando,
al banco dei salumi, vediamo un cartello fatto con le letterine di
plastica per comporre le parole:
Ma non è possibile! Lo sanno tutti che nelle parole italiane la q è
sempre seguita non solo dalla u ma anche da un’altra vocale: quel
qulatello grida vendetta. Come capita spesso, però, l’indignazione
grammaticale ottunde le nostre facoltà critiche, e ci impedisce di
notare una cosa ben più impossibile: il prezzo insolitamente basso di
quello che è considerato il re dei salumi.
Non servono molte ricerche per scoprire che il Qulatello non è il
culatello: un celebre salumificio ha messo in commercio un prodotto
ricavato dalla stessa parte della coscia del maiale e stagionato allo
stesso modo del culatello, ma che evidentemente non può essere
chiamato culatello, perché il culatello di Zibello è un salume a
denominazione di origine protetta sottoposto a un rigido disciplinare,
nel quale non rientrerà il Qulatello. Quindi quella q serve a creare un
nome commerciale (esiste anche il Qubo, ed è un furgone) e a
evitare accuse ben più gravi della lesa ortografia.
In
attesa di esaminare altri usi creativi della grammatica,
concentriamoci sulle implicazioni di normali errori involontari con la q
protagonista.
Qualche anno fa dovevo fare un bonifico, e al momento di indicare
la
«causale» avevo spiegato all’impiegato della banca che il
versamento serviva per un colloquio di selezione di mia figlia.
L’impiegato procede con l’operazione, scrive al computer, stampa la
ricevuta e me la fa firmare. A casa mi cade l’occhio sul foglio:
È grave scrivere collocquio col cq? In fondo, le cose essenziali (la
cifra, il conto corrente del destinatario) erano giuste. Però…
Però mi è tornato in mente che qualche mese prima dovevo
pagare le spese condominiali, e lo stesso impiegato aveva preso i
soldi dal mio conto corrente per versarli, invece che su quello del
condominio, di nuovo sul mio conto (e me ne sono accorto il mese
dopo; certo, se li avesse girati su un conto nigeriano sarebbe stato
peggio). Non ho potuto fare a meno di pensare che l’errore di
ortografia fosse il sintomo di una più generale incompetenza (o di
una distrazione patologica, chissà).
Potremmo dire allora che gli errori di ortografia sono gravi perché
mettono in mostra le nostre carenze, non solo grammaticali. Quindi
conviene imparare l’ortografia, se non vogliamo attirare l’attenzione
del mondo sui nostri punti deboli. Più seriamente: padroneggiare la
grammatica serve a evitare che chi ci legge e ascolta badi ai nostri
errori invece che a quello che abbiamo da dire. La cura formale
contribuisce all’efficacia della comunicazione perché elimina il
«disturbo» degli errori.
Nel caso della q, i disturbi sono ubiqui, nel senso che si trovano
anche in testi scritti da persone che con l’ortografia dovrebbero
avere una certa dimestichezza, visto che con le parole ci lavorano.
In un’altra galleria fotografica (lo so, sono una vittima di queste armi
di distrazione di massa), dedicata ai cocktail più venduti al mondo, si
parla del Penicillin («che può sembrare una medicina ai più
sprovveduti, ma non lo è»), a base di scotch.
A un anno di distanza dalla pubblicazione, quel risquotere è sempre
lì. Forse vuol dire semplicemente che testi del genere non li legge
nessuno, e non li rileggono nemmeno quelli che li scrivono. O forse
è la certificazione delle trappole che la q continua a piazzare sotto i
piedi di chi scrive in italiano.
Arriviamo allora alla soluzione del quiz 1. Sì, c’è un errore nella
frase: proficuo non si scrive con la q ma con la c, come innocuo e
promiscuo, e non come obliquo e ubiquo, che ho usato (apposta)
poco sopra.
Domande da (cani e) porci
Perché proficuo, innocuo e promiscuo si scrivono con la c, mentre
obliquo e ubiquo vogliono la q?
La ragione va cercata nell’etimologia: le corrispondenti parole
latine avevano la c o la q. E perché le parole latine avevano la c o la
q? Gli aggettivi proficuus, innocuus e promiscuus derivano da verbi
che hanno la c nel tema (profice˘re, «giovare»; nocēre, «nuocere»;
miscēre, «mescolare»); ubiquo deriva, attraverso il sostantivo
ubiquità, dall’avverbio latino ubique («in ogni luogo»), e la q è
presente in obliquus (che secondo i dizionari è «di etimologia
incerta»).
Dunque l’italiano è una lingua conservatrice, visto che mantiene le
scelte grafiche del latino, anche se non c’è nessuna differenza di
pronuncia tra il gruppo -cuo e il gruppo -quo?
Da un certo punto di vista sì (e lo vedremo anche nel prossimo
capitolo). Però tenete presente che tutti gli aggettivi che abbiamo
citato sono di origine dotta: non sono passati cioè attraverso
l’evoluzione naturale dal latino parlato ai volgari italiani, ma sono
stati presi nei testi latini e inseriti così com’erano (con il semplice
adattamento delle desinenze, per cui -us diventa -o) nel lessico
italiano. E non vorrei turbarvi, ma sappiate che nel vocabolario
troverete molte grafie alternative, precedute dalla croce † (che
significa «arcaico», «non più in uso»), che dimostrano che
l’incertezza non è solo nostra e non è solo segno di ignoranza:
†obblico, e pure †quore, †quoio e †quocere.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :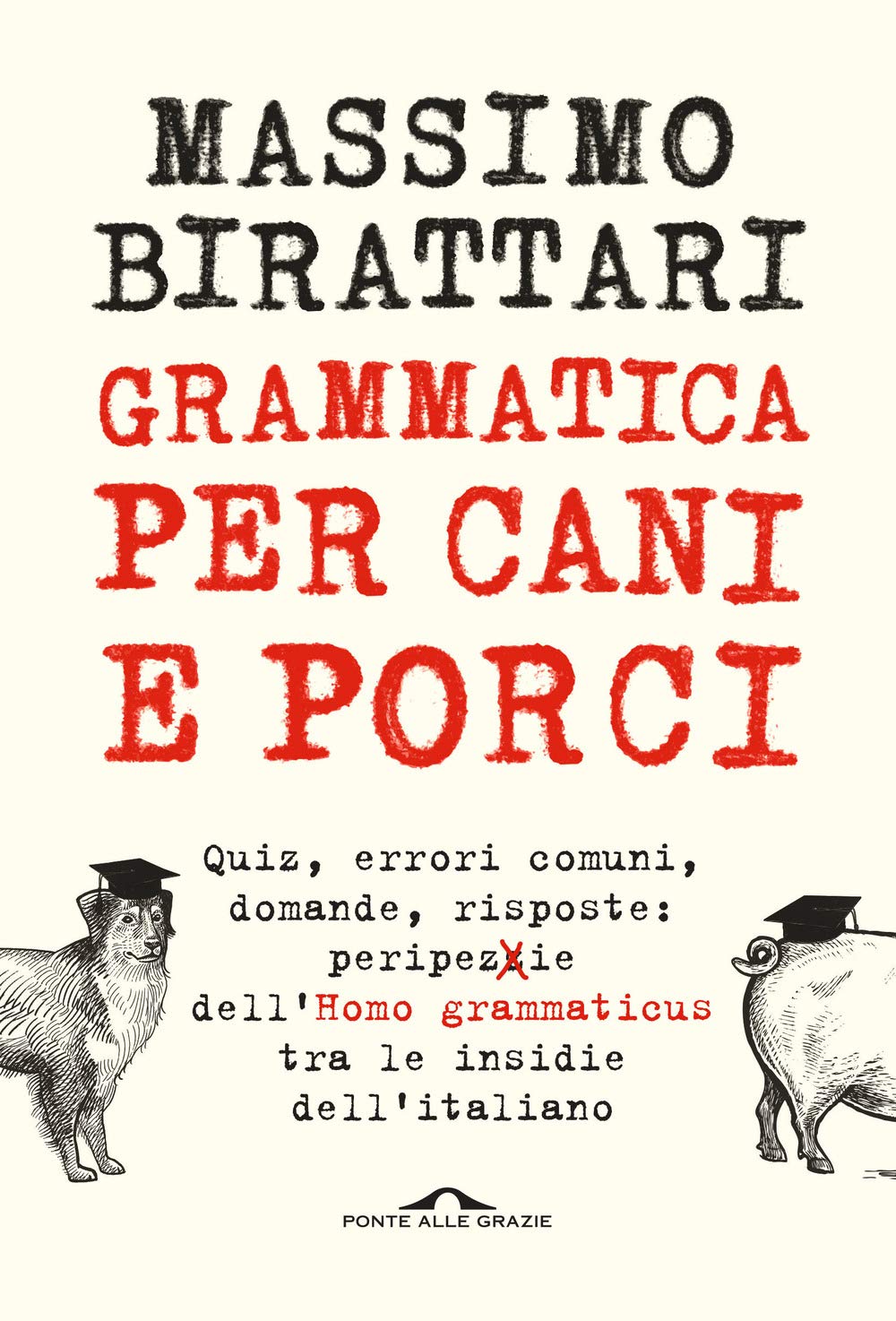






Commento all'articolo