Grand National – Roland Buti
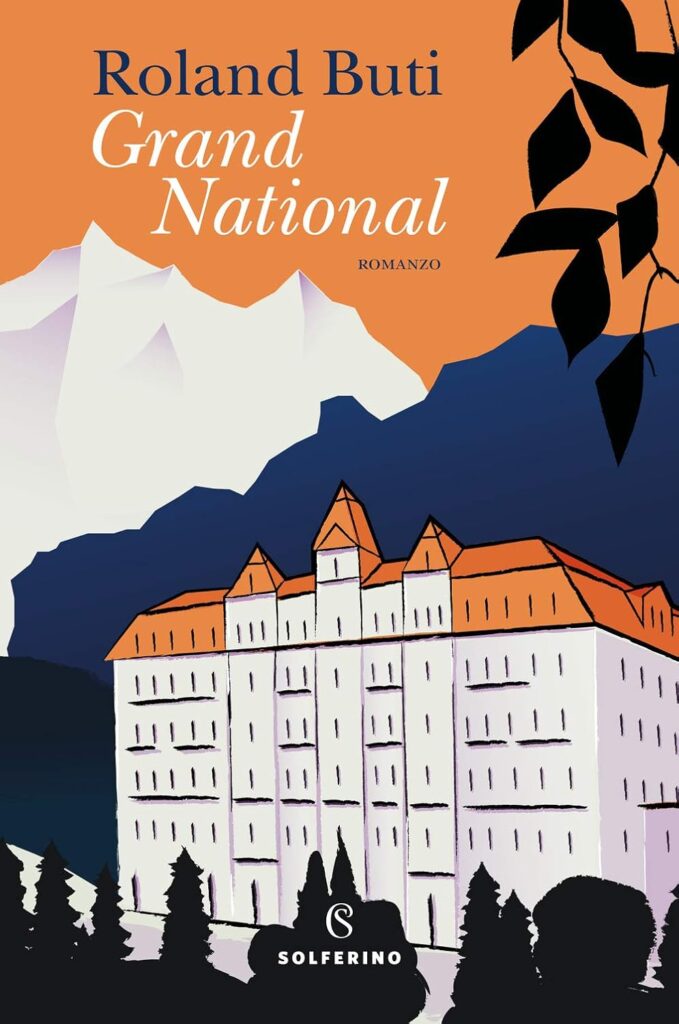
SINTESI DEL LIBRO:
La mia fretta di lasciare l’appartamento, di scendere le scale, di
attraversare poi con passo rapido l’ingresso del palazzo, ingombro di
biciclette e passeggini, mi faceva pensare alla fuga di un intruso
colto alla sprovvista dalle prime luci dell’alba.
Ci eravamo trasferiti lì, a meno di un quarto d’ora a piedi
dall’ospedale, perché Ana ci lavorava facendo turni pesanti.
Si era portata via diverse cose che non avevo sostituito. Cercavo
di ricordare quali suppellettili stessero sugli scaffali a prender polvere
prima della sua partenza, cosa ci fosse sul davanzale, nello
sgabuzzino fra la cucina a gas e la credenza con le pentole.
Riuscivo a ricomporre l’ambiente senza difficoltà, ma l’assenza del
tostapane, del bollitore, dei lunghi utensili ficcati in vasi di porcellana
rendeva tutto ciò che era rimasto un po’ ridicolo.
Le proporzioni della cucina in cui percepivo, più di prima, ogni
rumore, erano cambiate per effetto di uno strano fenomeno. C’era
una distanza insolita fra le cose, come se il luogo in cui avevamo
mangiato due volte al giorno per sedici anni si fosse dilatato con il
tempo.
Stavo facendo una rapida colazione al Penalty. Ristrutturato
qualche anno prima per attirare una nuova clientela, il vecchio caffè
del quartiere aveva mantenuto il suo nome, un ricordo del periodo in
cui la squadra cittadina giocava in serie A. Gli esseri umani amano
ripetere sempre gli stessi errori, ma chi aveva concepito quella
ristrutturazione doveva essere dotato di una particolare forma di
testardaggine. Le sedie in plastica effetto legno, i cuscini in finta
pelle viola, la mascotte sopra l’insegna all’ingresso: tutto era già
decrepito e io ero costretto a lottare contro la mia dolce intermittenza
mattutina.
Agon doveva arrivare, ma era in ritardo.
Raccoglievo le forze e mi impegnavo soprattutto affinché nessun
tipo di fratellanza si instaurasse con i clienti seduti ai tavoli: vecchie
e vecchi rinsecchiti nel loro sconforto, che parlavano a voce bassa e
leggevano distrattamente il giornale in quell’atmosfera da sala
d’attesa. Sembravano temere l’arrivo di un medico che confermasse
la precarietà della loro esistenza sulla terra.
Oltre la vetrina del locale, una luce bianca scoloriva la strada
invasa dall’arredo urbano. La pensilina con il tettuccio in vetro, i
dissuasori stradali rossi e gialli posizionati per rallentare il traffico e i
lampioni comunali dalla forma allungata, ricurvi nell’umidità gessosa:
tutto il quartiere sembrava ripiegato su se stesso, senza peraltro
costituire un ambiente particolarmente vivace.
Alcuni mesi prima avevo letto su «National Geographic»
l’intervista a un biologo; diceva che l’infinita varietà in natura dipende
dal fatto che ogni singola specie segue regole proprie. Si può forse
dire lo stesso degli esseri umani? Io amo sentire la presenza del
cielo sopra la mia testa quando lavoro nei giardini.
Dopo aver strappato le erbacce da un’aiuola, rastrellato l’erba o
tagliato una siepe, quando la luce del sole dà importanza a ogni
dettaglio, spesso mi fermo a contemplare il risultato. Quando sono al
chiuso le cose mi sembrano quasi sempre fuori posto.
«Mi fai pensare a un prigioniero condannato a non uscire mai più
dalla sua cella» mi aveva detto Ana una mattina, con la faccia
accartocciata in mezzo alla cornice di capelli arruffati.
Passavo sempre più tempo a guardare dalla finestra della cucina
quand’ero in cucina, dalla finestra del salotto quand’ero in salotto,
dalla finestra della camera da letto quand’ero in camera da letto. «È
un rimprovero?» le avevo chiesto. «No, mi piacciono i tipi distratti.
Sono meno concentrati su se stessi. Sono meno noiosi della
media.» Questa risposta mi era parsa allora molto delicata.
Ma lei non mi raccontava più le sue giornate di lavoro, non mi
parlava più dei rischi del mestiere, dei pazienti, dei medici attenti o
arroganti con lei o con le altre infermiere. Quando la sera la trovavo
addormentata, sfinita dal ritmo dei turni, odorava di ospedale:
un’esalazione tenace che una doccia non bastava a cancellare. Le
baciavo la fronte. Il suo viso era contratto come per lo sforzo di non
svegliarsi, la testa affondata nel cuscino.
Era già da diversi mesi che mi parlava solo dei decessi. L’ultima
volta che avevamo fatto l’amore mi aveva detto, subito dopo: «Ne
avevo veramente bisogno. Jela è morta ieri pomeriggio». Ricordo
quel momento, perché è stato allora che ho capito che non avremmo
più vissuto insieme.
Era sdraiata sul letto, a gambe aperte, le lenzuola stropicciate
intorno ai piedi. Mi ero sempre stupito della straordinaria ampiezza
che acquisivano i suoi capelli durante la notte. Al mattino avevo la
sensazione di vederla come era realmente. E credevo ancora che
questa parte segreta della sua vita, la più vera forse, fosse soltanto
mia.
Jela era entrata in coma in seguito a un incidente con lo scooter.
Aveva la stessa età di nostra figlia Mina.
In cucina mi ero versato un bicchiere d’acqua del rubinetto
mentre Ana oziava in camera. Una luce obliqua inondava la stanza,
una luce impietosa che colpiva tutto lo spazio come uno schiaffo.
Una mosca incastrata nel tubo al neon ronzava, impazzita per il
calore.
«È la seconda morte in un mese nel tuo reparto?» le ho chiesto.
«Sì.»
«Dieci giorni fa, giusto?»
«Sì. Era domenica. Un giovane.»
«Mi ricordo.»
«Si chiamava Loran.»
Ed è stato allora che mi sono chiesto se ogni nostro amplesso
coincidesse con la morte di un suo paziente.
«Buongiorno Weiss!»
Tutte le teste si sono alzate all’unisono e il silenzio è calato
all’interno del Penalty, perché Agon camminava a grandi falcate
lungo le file di tavoli – che di colpo sembravano prossimi a
rovesciarsi – per venire a sedersi davanti a me.
Agon mi chiamava per cognome. Lo faceva con la gente famosa
e con le persone che considerava importanti. Era come dire «capo».
Con il lavoro in regola e le sue buste paga assolutamente dignitose
sperava di ottenere il permesso di soggiorno in Svizzera, un
permesso di tipo C con autorizzazione definitiva di insediamento.
Imbevuto di gratitudine, non avrebbe scordato a chi doveva quel
dono prezioso.
Conosceva bene la cameriera. Florije gli ha portato il caffè con
un cestino di vimini pieno di croissant. Ha svuotato tre bustine di
zucchero nella tazzina e fatto tintinnare il cucchiaino con il sorriso di
un bimbo concentrato su un gioco musicale.
Diverse volte al giorno, alla minima occasione, spesso
all’improvviso e senza regole chiaramente intuibili, Agon ritorna
bambino. Non dura mai a lungo, ma la tenacia con cui l’innocenza
sopravvive in quel corpo massiccio da forestale non finisce mai di
stupirmi.
«Hai il materiale?» ho chiesto.
«È arrivato ieri in stazione. L’ho caricato sul rimorchio.»
«E come ti sembra?»
«I pezzi sono tutti imballati. Non ho potuto vedere bene.»
«E il montaggio?»
«Nessun problema. Mio cugino ha pensato a tutto» mi ha detto
con un gran sorriso.
Le espressioni del suo volto – più largo, più articolato del
normale, ma in realtà proporzionato al resto della sua anatomia
sembravano sempre un po’ esagerate. Sicuramente il tipo di
persona alla cui presenza è difficile trovare una scappatoia.
Non c’era nulla da rispondere. Il riferimento a uno dei suoi tanti
contatti, per giunta membro della sua famiglia, doveva bastarmi
come garanzia.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :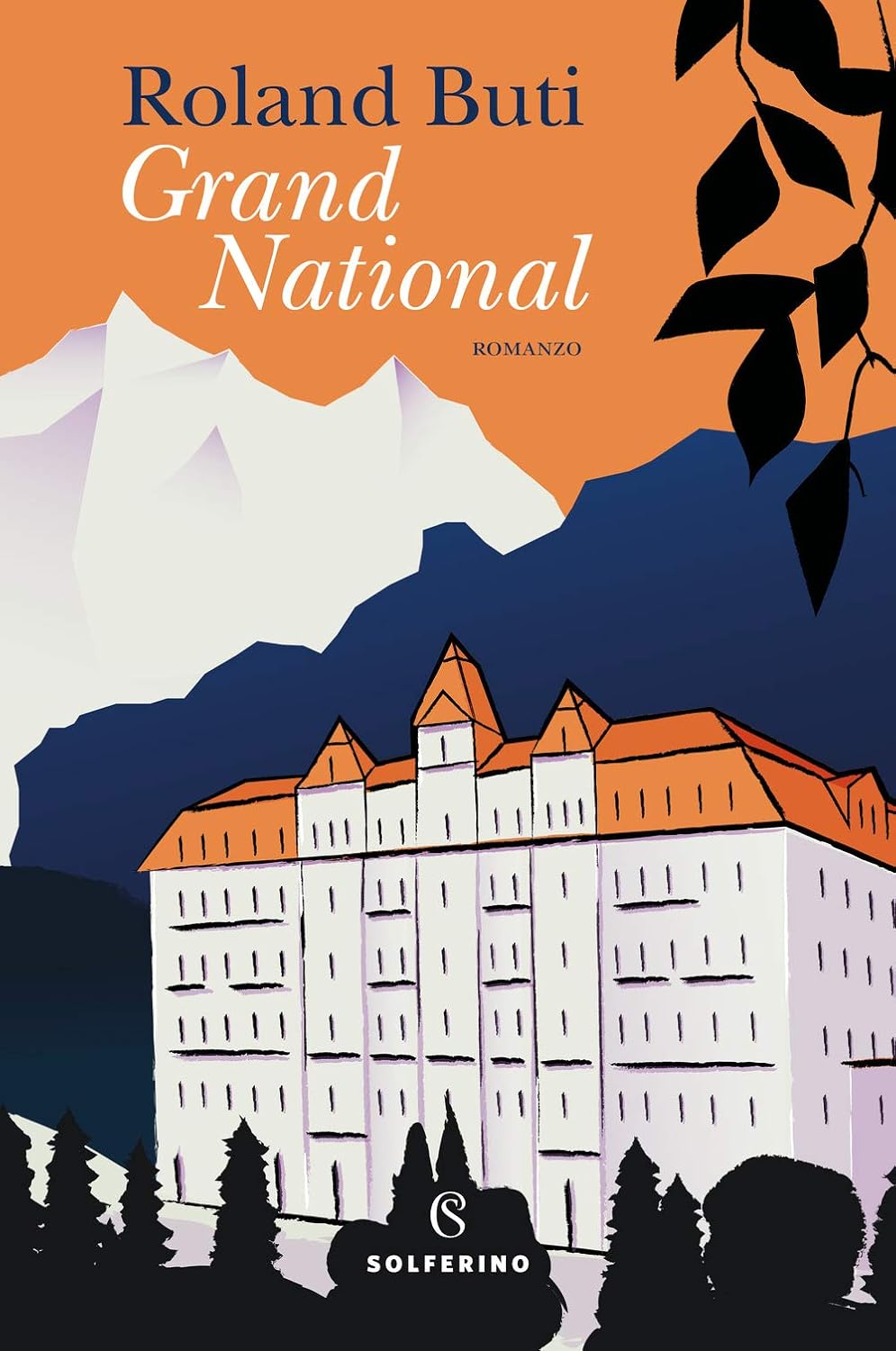






Commento all'articolo