Florida – Lauren Groff
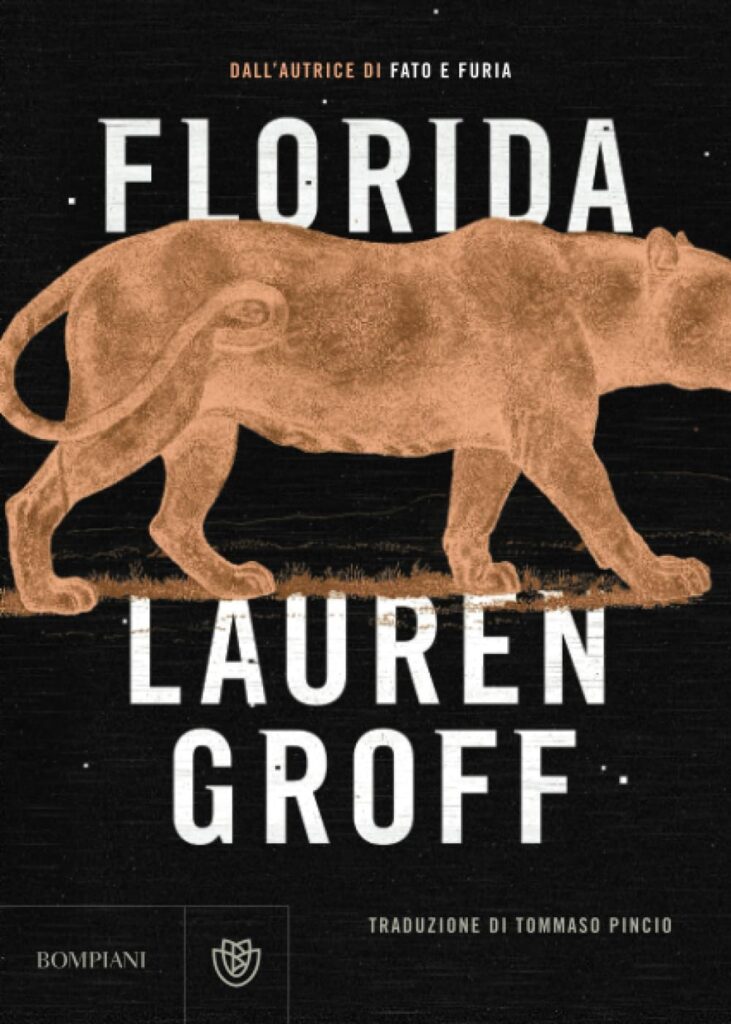
SINTESI DEL LIBRO:
Non so come ma sono diventata una donna che strilla, e poiché
non mi piace essere una donna che strilla, i cui bambini si aggirano
con la faccia raggelata e guardinga, ho preso l’abitudine di
allacciarmi le scarpe da corsa dopo cena e uscire nella penombra
crepuscolare delle strade per una passeggiata, lasciando che sia
mio marito, un uomo che non strilla, a far spogliare e lavare i
ragazzi, a leggergli e cantargli qualcosa, a rimboccargli le coperte.
Il quartiere si fa buio mentre cammino, e un secondo quartiere si
srotola sopra quello diurno. I lampioni sono pochi e quelli sotto cui
passo attribuiscono alla mia ombra un andamento spensierato;
l’ombra si attarda dietro di me, si scapicolla sotto i miei piedi, saltella
qualche passo più avanti. Le uniche altre fonti di illuminazione sono
le finestre delle case e la luna che mi ordina di levare lo sguardo.
Alza gli occhi, su! Gatti inselvatichiti mi schizzano tra i piedi, fiori di
sterlizia si sporgono dalle ombre, odori si sprigionano nell’aria:
polvere di quercia, funghi mucillaginosi, canfora.
La Florida del Nord è fredda a gennaio e io cammino veloce per
scaldarmi, ma anche perché, malgrado questo sia un quartiere
antico – enormi case vittoriane si irradiano dal centro cedendo il
posto prima ai bungalow degli anni venti e poi ai moderni ranch anni
cinquanta – non è proprio sicuro. C’è stato uno stupro un mese fa,
una cinquantenne che faceva jogging è stata trascinata a forza tra le
azalee; e una settimana fa un branco di pitbull sciolti è piombato su
una madre con bimbo nel passeggino e ha sbranato entrambi,
seppure con esiti non mortali. Non è colpa dei cani, è colpa dei
padroni! hanno protestato gli amanti dei cani nella mailing list del
quartiere, ma quei cani erano sociopatici. Quando si è cominciato a
edificare in periferia, negli anni settanta, le case storiche del centro
città sono state lasciate nelle mani di dottorandi che scaldavano i
fagioli sopra il becco Bunsen sui pavimenti di pino e affettavano
grandi sale da ballo per ricavarne stanze in cui vivere. Quando
incuria e umidità hanno portato le case a marcire, cadere a pezzi e
sviluppare squame di ruggine, è sopraggiunta una seconda ondata,
quella della povera gente, degli occupanti abusivi. Ci siamo trasferiti
in questa casa dieci anni fa perché costava poco e il legname dello
scheletro veniva da foreste vergini, e anche perché avevo deciso
che se dovevo vivere al Sud, tra le arachidi bollite e il muschio che
penzola dappertutto come peli di ascella, almeno non mi sarei
barricata con la mia pelle bianca in una comunità protetta. Ma non
è… pericoloso? diceva la gente dell’età dei nostri genitori con una
smorfia quando gli spiegavamo dove vivevamo, e ci è voluta tutta la
mia forza di volontà per non dire Intendi nero o solo povero? Perché
il quartiere era entrambe le cose.
Da allora il ceto medio bianco ha comunque infettato la zona, e
adesso è tutto un delirio di ristrutturazioni. Negli ultimi anni se ne
sono andati quasi tutti i neri. I senzatetto sono rimasti un po’ più a
lungo, perché il quartiere confina con Bo Diddley Plaza dove fino a
poco tempo fa le chiese distribuivano cibo e Dio e dove la marea di
Occupy è arrivata rivendicando il diritto di dormirci, finché, stanca di
vivere nella sporcizia, è defluita, lasciandosi alle spalle i relitti umani
dei senzatetto nei sacchi a pelo. Durante il nostro primo mese in
questa casa, abbiamo ospitato una coppia di senzatetto che noi
abbiamo sempre visto solo sgattaiolare via all’alba: al tramonto,
sollevavano senza far rumore la grata per infilarsi nell’intercapedine;
dormivano lì, con il pavimento della nostra camera a far loro da tetto,
e quando noi ci alzavamo nel cuore della notte cercavamo di
muoverci piano perché ci sembrava sgarbato camminare pochi
centimetri sopra la faccia di una persona che sogna.
In questi giri serali mi si svelano le vite dei vicini, le finestre
illuminate diventano acquari domestici. A volte sono testimone
silenziosa di scontri che sembrano un lento senza musica. È
sbalorditivo come vive la gente, il caos che sopporta, le deliziose
zaffate che dalle cucine arrivano fino in strada, le decorazioni
natalizie che lentamente entrano a far parte del normale arredo. Per
tutto gennaio ho osservato un bouquet di rose sulla mensola di un
camino rattrappirsi finché i fiori si sono ridotti a un grumo avvizzito e
l’acqua a una schiuma verde; un enorme Babbo Natale in cima a un
bastoncino sorrideva ancora felice tra quei resti. Finestra dopo
finestra la vita si avvicina, si raggela nella foschia azzurrina della
luce televisiva o in una coppia curva su una pizza, si ferma un attimo
al mio passaggio, poi scivola nel dimenticatoio. Penso a come
l’acqua si ammassa colando lungo un ghiacciolo, indugia per dare
forma a una goccia lucente, diventa troppo grossa per restare
ancora sospesa e piomba a terra.
Una casa del quartiere è quasi priva di finestre però la adoro,
perché ospita le suore. Vi abitavano in sei, prima, ma in seguito agli
attriti che spesso si creano tra donne molto anziane, in quello spazio
immenso rimangono ora soltanto tre sorelle a pigolare con garbo
nelle loro scarpe comode. Un agente immobiliare nostro amico ci ha
raccontato che quando fu costruito il convento, negli anni cinquanta
del secolo scorso, venne calato un rifugio antiatomico nella porosa
pietra calcarea del giardino, e durante le mie notti insonni, quando il
corpo è a letto ma la mente è ancora fuori a camminare nel buio, mi
piace immaginare le suore in pompa magna nel loro rifugio, intente a
cantare inni e pedalare su una cyclette per tenere acceso lo sfrigolio
di una lampadina, mentre, in superficie, impera la devastazione più
nera e i cardini arrugginiti stridono nel vento.
* * *
Poiché le sere sono così fredde, condivido le strade con poche
persone. C’è una giovane coppia che trotterella a un’andatura
appena più lenta della mia camminata sostenuta. Li seguo,
ascoltando la tiritera dei loro progetti matrimoniali, i litigi con gli
amici. Una volta mi sono dimenticata di me stessa e ho riso per
qualcosa che hanno detto, al che hanno girato verso di me le facce
nottambule e innervosite per poi accelerare il passo e svoltare alla
prima occasione; ho lasciato che sparissero nel buio.
C’è una donna alta ed elegante con al guinzaglio un alano
tedesco dal colore identico a quello del laniccio che si accumula sul
filtro dell’asciugatrice; ho paura che la donna stia poco bene per via
dell’andatura rigida, del viso che palpita come scosso da un dolore
intermittente. A volte penso a quel che farei se dovessi trovarla
stramazzata a terra dopo avere svoltato un angolo a tutta birra, a
come la deporrei sulla schiena del cane, alla pacca che gli darei al
garrese per poi restare a guardare l’animale che con grande dignità
riporta a casa la padrona.
C’è un ragazzo, un quindicenne o giù di lì, grasso da morire,
sempre a torso nudo e sempre sul tapis roulant, dietro la vetrata
della sua veranda. Per quante volte mi ritrovi a passare con il mio
incedere deciso, lui è lì, i suoi piedi martellano così duro che riesco a
sentirli a due isolati di distanza. Poiché le luci sono tutte interne alla
casa, per lui non c’è nulla oltre il nero della finestra, e chissà se
osserva il proprio riflesso allo stesso modo in cui lo osservo io, se
vede lo stomaco incresparsi al ritmo dei suoi passi come uno stagno
in cui qualcuno abbia lanciato una pietra grande quanto un pugno.
C’è la senzatetto timida e brontolona, una raccoglitrice di lattine,
che issa le sue buste sferraglianti sul retro della bicicletta e monta in
sella servendosi dei vecchi blocchi di cemento davanti alle case più
maestose; il suo effluvio mi fa pensare alle ricche dame del Sud in
seta scura che un tempo si servivano di quei blocchi per salire sulle
carrozze, emanando un lezzo femmineo altrettanto intimo. L’igiene
cambia con il tempo, ma non il corpo di noi umani.
C’è un uomo che sussurra porcherie sotto la luce esterna di una
bodega con le sbarre alle finestre. Io assumo la mia espressione
non-provarci-neanche-per-scherzo, e lui non ha che da spingersi
oltre le porcherie, perché una parte di me è più che pronta, vogliosa
di servirsi dei muscoli che va mettendo su.
A volte credo di scorgere la coppia che vive nascosta sotto casa
nostra, in particolare la premura che il marito riserva alla moglie, le
mani di lui sulla schiena di lei, ma quando mi avvicino scopro che si
tratta soltanto di un albero di papaia piegato sopra un barile o di due
ragazzi che fumano tra i cespugli, che si voltano circospetti al mio
passaggio.
E poi c’è il terapista che ogni sera siede alla scrivania dello
studio, in una casa vittoriana che pare un galeone malconcio. Uno
dei pazienti lo ha sorpreso a letto con sua moglie; il paziente teneva
nell’auto un fucile da caccia carico. La moglie è morta nell’amplesso,
mentre il terapista l’ha scampata ma ha ancora un proiettile nel
fianco che lo fa barcollare quando si alza per versarsi dell’altro
scotch. Gira voce che vada tutte le settimane in carcere per far visita
all’omicida cornificato, anche se la ragione resta oscura, se per
gentilezza o per vantarsene; del resto le motivazioni non sono mai
troppo limpide. Mio marito e io ci siamo trasferiti qui poco prima
dell’omicidio; stavamo raschiando la vernice cadente dalle
modanature di quercia della sala da pranzo quando gli spari hanno
squarciato l’aria, ma abbiamo pensato fossero fuochi di artificio
accesi dai ragazzini che abitavano qualche isolato più in là.
Mentre cammino, vedo estranei ma anche persone che conosco.
Levo lo sguardo nell’inizio di febbraio e sorprendo una cara amica
alla finestra in body rosa a fare stretching, ma poi, in un attimo di
illuminazione, capisco che non fa stretching, si asciuga le gambe, e il
body è in effetti il suo corpo, rosa per via della doccia calda. Sono
andata a trovarla in ospedale quando ha dato alla luce entrambi i
suoi figli, e ho tenuto in braccio i neonati con l’odore della madre
ancora addosso, e visto l’incisione del cesareo prima che si
rimarginasse, ma è solo nel vederla asciugarsi che capisco quanto
sesso ci sia in lei, e già mi vedo costretta ad arrossire in occasione
del nostro prossimo incontro, a sopportare visioni di lei in posizioni
estreme. Quelle che vedo sono perlopiù madri che conosco per
immagini fugaci, curve come un bastone da pastorella, intente a
scandagliare il pavimento in cerca di minuscoli pezzi di Lego o
chicchi d’uva mangiucchiati, o accasciate in un angolo a ripensare
alla persona che erano un tempo.
È troppo, è troppo, grido a mio marito certe notti quando rientro in
casa, e lui, questo gigante gentile, mi guarda dal letto, impaurito e,
alzandosi dal suo computer, dice, con voce sommessa, Mi sa che
non hai camminato abbastanza, amore, forse è meglio se ti fai un
altro giro. Esco di nuovo, inviperita, perché le strade diventano più
pericolose quand’è così tardi, e come osa mio marito propormi un
rischio simile, proprio adesso che mi sono mostrata vulnerabile; ma,
d’altra parte, forse pure la mia casa è diventata più pericolosa.
Durante il giorno, mentre i miei figli sono a scuola, non riesco a
smettere di leggere di quel grande disastro che è il mondo, i
ghiacciai che muoiono come creature viventi, la grande chiazza di
immondizia del Pacifico, la scomparsa non documentata di centinaia
di specie, millenni annientati come non avessero alcun valore. Leggo
e mi prende una pena selvaggia, come se leggere potesse in
qualche modo saziare questa fame di dolore, invece di alimentarla,
come in effetti mi succede.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :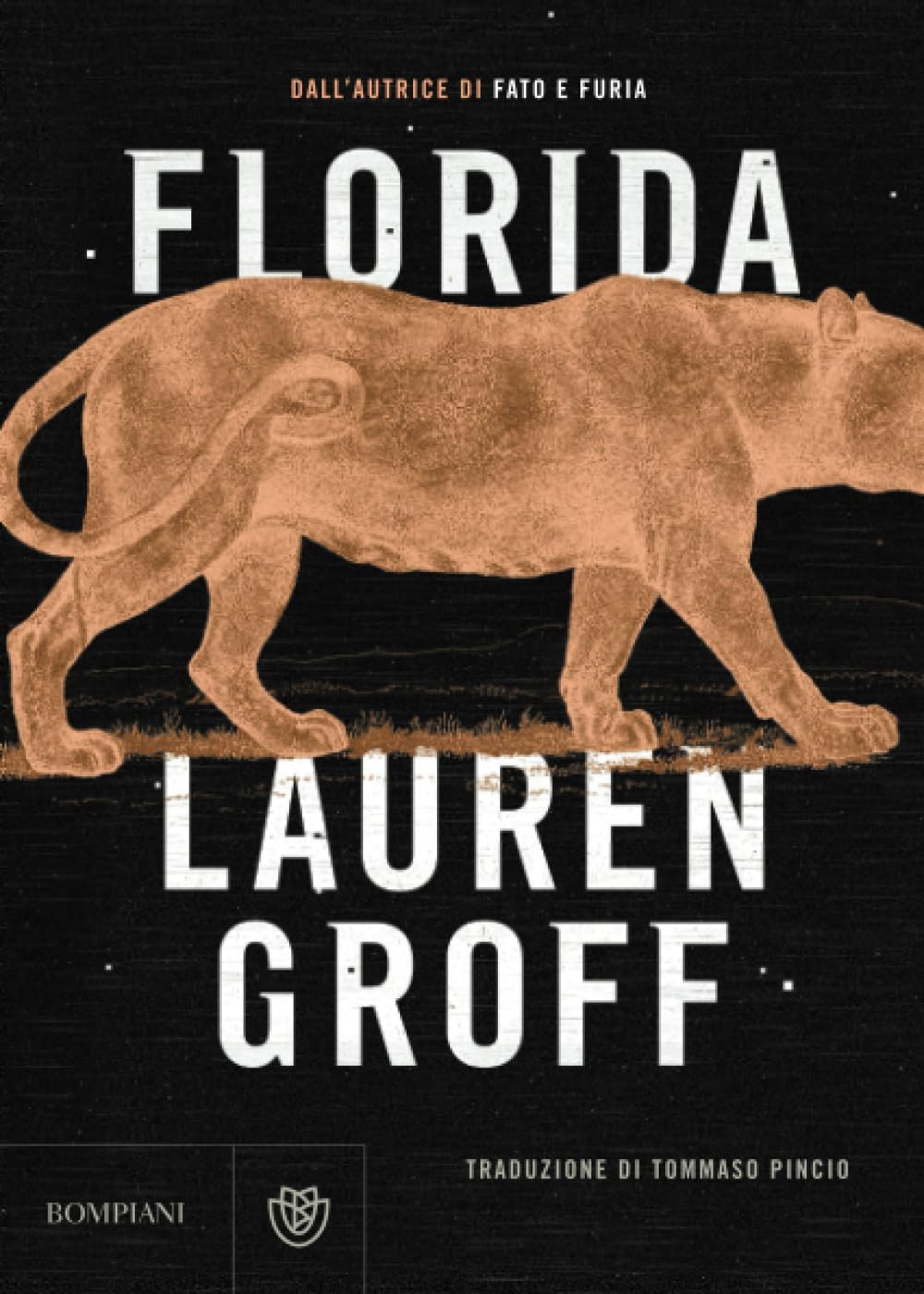






Commento all'articolo