Dream on – Tania Paxia
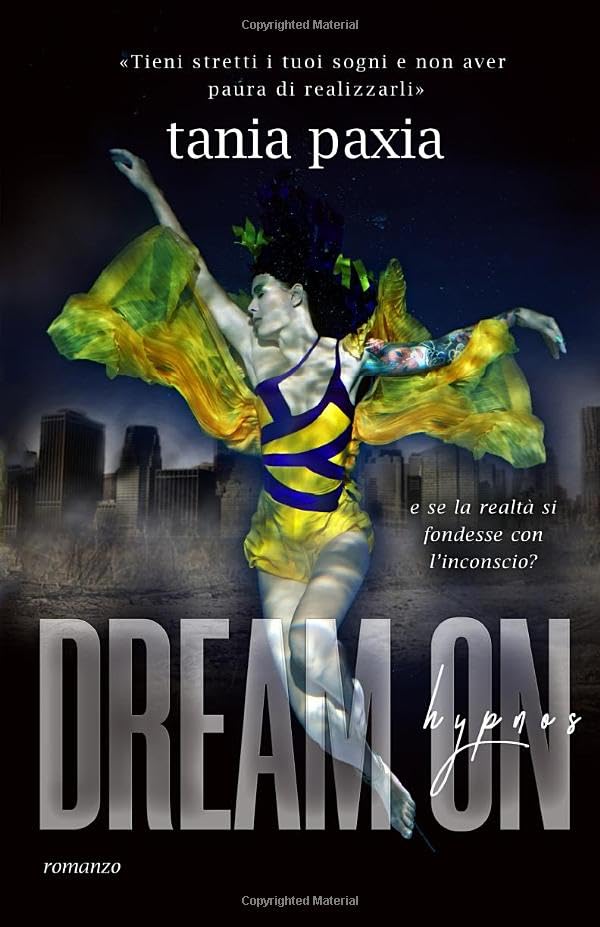
SINTESI DEL LIBRO:
“E poi…” il signor Kusac sospirò, dopo aver fatto una smorfia
sprezzante, come se gli avessi chiesto di catturare la Luna. “E poi mi sono
svegliato. Che domande”.
Ecco, appunto. Il nervosismo del signor Kusac veniva fuori anche per la più
piccola sciocchezza. Non come quando lo avevo conosciuto, ma rimaneva
pur sempre un caso delicato da non trascurare. Era uno dei miei pazienti da
quando lo avevano dimesso dall’istituto psichiatrico dal quale era uscito sei
mesi prima. Diceva di vedere cose strane nei sogni e, dopo qualche tempo,
accadevano sul serio. Questo, però, era quello che lui affermava. Paul
Kusac aveva cinquant’anni e una carriera da poliziotto alle spalle. Ma, dopo
un caso irrisolto, aveva iniziato a dare i numeri. Letteralmente. Scriveva
cose senza senso dove capitava: sui fogli, sui libri, sui tavoli, sui muri,
pavimenti, porte…ovunque gli capitasse. Sua moglie lo aveva lasciato e
fatto internare, stremata dai suoi comportamenti schizofrenici e oltre il
limite della pazzia. Dopo due anni, era stato dichiarato idoneo al ritorno alla
vita di tutti i giorni, seguito da una psicoterapeuta – la sottoscritta – che
collaborava con l’istituto di igiene mentale di Pasadena, in California.
Il suo sguardo, per un istante, si fece serrato, come in preda a una furia
omicida, poi prese un respiro profondo e strinse la mandibola squadrata,
coperta da un sottile strato di barba ingrigita. I suoi occhi color castano
chiaro rimasero a contemplare il soffitto per alcuni secondi, del tutto
abbandonati a chissà quale pensiero, prima di voltarli nella mia direzione.
“Allora, secondo lei, che significa? Che sto diventando pazzo? Di nuovo?”
si aggiustò le gambe sulla morbida poltrona di finta pelle nera del mio
studio, per accavallarle; poi cominciò a giocherellare con le dita delle mani,
con le unghie mangiucchiate a sangue poggiate sul petto. Arpionò il mio
sguardo e non sembrava intenzionato a mollarlo fin quando non avessi
risposto alla sua domanda.
“Non si arrovelli il cervello per i sogni. I sogni”, feci una pausa, cercando
di scegliere le parole giuste da rivolgergli, “sono solo sogni. Il più delle
volte non hanno senso, mentre nelle altre occasioni è soltanto il nostro
subconscio che ci ricorda qualcosa che abbiamo ignorato, qualcosa che
non ci è chiaro, qualcosa che non vogliamo ammettere o che desideriamo
con tutto il nostro animo, ma che, nella vita, purtroppo non si realizza.
Sono i nostri desideri più reconditi che vengono fuori durante il sonno”.
Ero fiera di me per aver tirato fuori quelle precise parole, così, d’impulso.
Sperai che fossero sufficienti a fargli capire il concetto. Ma non esiste una
persona più sorda di chi non vuol sentire.
“E come se lo spiega il fatto che io veda volti di persone a me sconosciute
e quella città devastata?” sbatté le palpebre più di una volta, alterato dalla
piega che stava prendendo la nostra chiacchierata.
“La sua mente potrebbe aver veicolato varie informazioni prese da
notiziari, film di azione, oppure dalla vita di tutti i giorni, persino da una
camminata per strada, e rielaborate durante la fase R.e.m.”. Lo fermai con
un gesto della mano prima che potesse interrompermi. “Non sa da quante
informazioni il cervello è bombardato ogni giorno. Pensi a quando è
entrato in questo edificio”. Provai ad esporgli un esempio pratico: “Si
ricorda i volti di ogni persona che ha incontrato durante il tragitto? I suoi
occhi sì, ma la mente ha selezionato soltanto i pochi dati della quale
aveva bisogno. Non se li ricorda, ma se ci riflette con attenzione, i volti
offuscati, pian piano, diventano chiari e limpidi”.
Si alzò di scatto, fermandosi a sedere. Ebbi un sussulto quando serrò ancora
quegli occhi enigmatici. “Mi hanno detto che lei pratica l’ipnosi. Se non mi
crede in questo stato, potrebbe credermi nell’altro”.
Praticavo l’ipnosi? Sì, quando ero una ragazzaccia che voleva sbarcare il
lunario, raggirando qualche povero malcapitato. Scossi il capo con vigore,
facendomi il solletico sul volto con i ciuffi di capelli dal taglio moderno,
scalato. Mi portai il pollice e l’indice intorno al setto nasale,
massaggiandomi gli incavi degli occhi. Sbuffai. “Chi le ha detto una cosa
simile?”
Kusac sorrise beffardo lasciando intravedere dei denti marroni, colpa delle
tante sigarette che si fumava e della carenza igienica dovuta alla
depressione. Dovevamo ancora lavorare su quell’aspetto. Era già tanto se
adesso fosse in grado di dialogare con le persone e non gli urlasse addosso
cose senza senso, ringhiando come un cane randagio. “Me lo ha detto una
persona, in sogno”.
Non trattenni una risata. Lo so, non è molto professionale, ma, come dire,
non ero proprio una delle più ordinarie psicoterapeute in circolazione.
Avevo i miei metodi. “Certo, in sogno. È sicuro che non sia stata Fathma, la
mia segretaria?” mi soffermai a studiare il suo volto. Ero un’esperta nel
notare i cambi di espressione e, studiando i comportamenti del signor
Kusac, avevo imparato a capire quando mentiva o quando diceva la verità
soltanto da un piccolo particolare: il tic nervoso che aveva, proprio sul
labbro superiore, il quale si contraeva e si protendeva in un ghigno
scomposto, quasi distorto, come se stesse faticando per trattenere un sorriso.
“No”. Aveva il ghigno. “Assolutamente no”. Aveva ancora il ghigno. “Me
lo ha detto un certo Flynn”. Senza ghigno.
O aveva barato, oppure diceva una mezza bugia. Avrei visto di nuovo la
conversazione tramite la telecamera nascosta in un finto soprammobile che
avevo piazzato sulla mia scrivania in direzione del lettino-poltrona. Doveva
essere solo per fini di studio. In realtà l’avevo messo per sicurezza e per
rivedere le sedute a casa, il più delle volte al rallentatore per non perdermi
neanche un cambio di espressione nei volti dei pazienti che seguivo.
Cercai di reggere il suo gioco per scoprirne di più. “E questo Flynn, come
lo sa?” alzai le sopracciglia per fargli capire che ero seriamente incuriosita.
Il signor Kusac scoppiò in una risata acida, di scherno. “Lui ha detto di
sapere molte cose, su di lei”.
“Tipo?” lo incalzai. Posai i gomiti sulla scrivania, portandomi le mani
sulle guance. Quella conversazione si stava facendo interessante.
“Ha un tatuaggio”. Divenne serio all’improvviso. Si rabbuiò in volto,
assumendo un’aria solenne, facendomi venire la pelle d’oca.
Era vero. Ma poteva benissimo esserselo inventato sul momento. Poteva
aver tirato a caso o intravisto sotto qualche camicia di cotone semi
trasparente alla luce del sole che filtrava dalle finestre panoramiche del mio
ufficio.
“Mmm, dove esattamente?” lo incalzai.
Mi diede una risposta fulminea, come se non avesse neanche riflettuto sulle
parole. “Braccio sinistro, dalla spalla in giù”. Si passò la mano destra sulla
spalla e ripercorse il braccio fino al gomito. Anche a quaranta gradi, a
lavoro, indossavo sempre camicie o magliette a maniche lunghe, perché non
volevo che quel tatuaggio grande come una casa – fatto in gioventù – fosse
notato dai miei colleghi e dai miei pazienti. D’estate tenevo al massimo
l’aria condizionata, ma era quello che dovevo sopportare per evitare di far
sorgere delle strane domande nelle persone. “Perché si è fatta quel
tatuaggio? È enorme”. Oppure, “non sta bene che una dottoressa abbia una
cosa del genere sul braccio”, o ancora, “Dio, ma eri drogata quando te lo sei
fatto fare?”, o, come mi ero sentita dire tante di quelle volte all’università:
“Ma i tuoi cos’hanno detto quando te lo hanno visto?”
Cosa mi hanno detto? Niente. Perché? Perché non li avevo mai conosciuti.
Fino a diciotto anni ero stata sballottata tra una famiglia e l’altra, vedendole
di tutti i colori. Avevo messo la testa a posto, a quasi vent’anni, dopo aver
subìto un trauma che mi aveva segnato profondamente due anni prima,
ovvero quando Adam, il ragazzo al quale ero legata da tutta una vita, era
morto in una sparatoria.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo