Cosa rispondere a un razzista: Storia, scienza, razza e realtà – Adam Rutherford
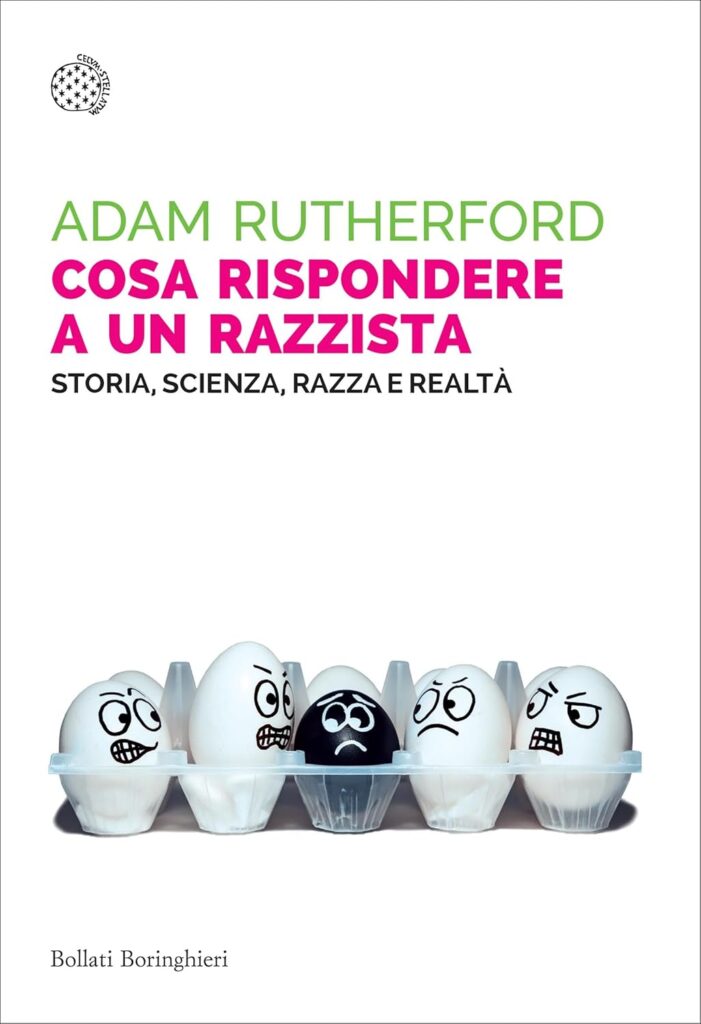
SINTESI DEL LIBRO:
Di tutti gli indicatori razziali impiegati dagli esseri umani, la pelle è
il più evidente: cominciamo dunque con il colore. Siamo una specie
molto visiva e la pigmentazione è il primo e principale segno al quale
ci affidiamo per categorizzare gli altri. Tolto l’effetto marginale dei
raggi solari, il colore della pelle è determinato dai geni.
I
geni codificano le proteine; queste mettono in moto la nostra
biologia, vale a dire che tutta la vita è costituita di o da proteine. I
capelli sono fatti di cheratina, che è una proteina, così come lo è la
melanina, da cui dipende il colore della pelle. E anche se
condividiamo tutti lo stesso set di geni, essi sono uguali e al
contempo diversi. Differenze minori nella sequenza di un gene di
due persone corrisponderanno a proteine leggermente diverse, ed è
questo che determina le differenze biologiche fra gli esseri umani:
modi diversi di scrivere i circa 20000 geni che tutti condividiamo.
Siamo certi di aver compreso le fondamenta della genetica, ma
correlare il codice genetico di base alla forma e alla funzione di una
proteina è complicato. Con il progressivo aumento delle scoperte
nella nostra epoca genomica, non è mai semplice, anzi, è quasi
impossibile prevedere la manifestazione fisica del gene nel quale è
codificata, cioè individuare il fenotipo dal genotipo. Nel XIX secolo lo
scienziato Gregor Mendel incrociò migliaia di piante di pisello e ne
dedusse che i tratti vengono trasmessi di generazione in
generazione secondo modelli discreti che seguono regole rigide. In
seguito alla riscoperta del suo lavoro, all’inizio del XX secolo il
concetto di «gene» venne definito come l’unità dell’ereditarietà; una
porzione discreta di informazione ereditabile. In effetti, benché in
ambito scientifico sia stata fissata soltanto nel XX secolo, tale
nozione risale a molti anni prima. La più antica descrizione di una
malattia genetica si trova nel Talmud, in un decreto rabbinico che
esenta alcuni bambini dalla circoncisione nei primi giorni di vita nel
caso in cui altri uomini della famiglia siano morti dissanguati nel
corso della procedura, cioè abbiano sofferto di quella che oggi
conosciamo come emofilia. Questo modello di ereditarietà, proprio
come la forma o il colore delle piante di pisello di Mendel duemila
anni dopo, si basa su principi innegabilmente corretti che chiamiamo
«leggi di Mendel».
Il
quadro dell’ereditarietà genetica si è però rivelato ben più
complesso negli umani che nei piselli. Negli ultimi vent’anni, i vecchi
schemi semplicistici che descrivevano il legame tra un gene
specifico e una particolare caratteristica sono venuti meno. La cosa
non stupisce se pensiamo a tratti umani complessi, come
l’intelligenza, o malattie come la schizofrenia, nel cui sviluppo, si è
scoperto, decine e a volte centinaia di geni ricoprono un ruolo
minore ma cumulativo. Questo lo sappiamo da alcuni anni. I genomi
sono ecosistemi complessi e dinamici, all’interno dei quali i geni
hanno vari compiti nel corpo, a seconda di dove e quando sono
coinvolti. Un gene coinvolto nella crescita di un embrione subito
dopo il concepimento potrebbe svolgere un ruolo molto diverso in
seguito, o anche non svolgerne più. Un gene può anche avere ruoli
multipli, un fenomeno noto come pleiotropia. Un altro fenomeno,
l’epistasi, fa sì che l’impatto di un gene dipenda dagli altri; i suoi
effetti possono essere positivi o negativi, e verificarsi a livello
reticolare tra geni del tutto diversi, o anche tra le due copie dei geni
presenti in ognuno di noi, ciascuna ereditata da un genitore. I geni
fanno molte cose in molti modi e, anche studiandoli per una vita
intera, si continueranno a scoprire nuovi funzionamenti del genoma
umano. Il codice genetico è rimasto fermo per miliardi di anni, ma
l’evoluzione ci traffica da sempre per creare la vita.
Gli esempi da manuale che utilizziamo per illustrare i principi
essenziali dell’ereditarietà biologica spesso sono incentrati sulla
pigmentazione, per esempio il colore degli occhi, ma in verità non
sono affatto semplici come li insegniamo. A scuola si impara che gli
occhi blu e quelli marroni sono codificati da diverse versioni dello
stesso gene (definite alleli; l’allele marrone è dominante rispetto al
blu, dunque per avere gli occhi blu si deve ereditare un allele blu da
entrambi i genitori, mentre la presenza di uno o due alleli marroni si
tradurrà in occhi marroni). Questo è più o meno vero, ma la cosa è
complicata dal fatto che esiste un gene legato alla pigmentazione
verde, ed è stato dimostrato che almeno una dozzina di altri geni
contribuisce alla colorazione dell’iride. Il risultato di questa rete è
che, al contrario di quanto apprendiamo a scuola, un bambino può
avere occhi di qualunque colore, a prescindere dalla combinazione
del colore di occhi dei suoi genitori.
Un altro esempio centrale a sostegno del modello semplice di
Mendel sull’ereditarietà era l’MC1R, un gene coinvolto in tutta la
pigmentazione, ma in particolare in un tratto molto visibile, cioè il
colore dei capelli. L’MC1R ha numerose varianti, ma all’incirca
diciassette di esse modificano il comportamento della proteina che vi
è codificata, la quale produce così un tipo specifico e non comune
del pigmento melanina. Chi ha due copie di una di queste varianti ha
i
capelli rossi. In tal senso, la colorazione rossa è un classico tratto
recessivo: ce l’avrà soltanto chi possiede due alleli rossi di MC1R.
Questo dicevano i manuali fino al dicembre 2018, quando uno
studio genetico ad ampio raggio ha rivelato che le varianti rosse
nell’MC1R sono responsabili del 70% circa degli individui con capelli
rossi e che, nella maggioranza dei casi, chi presenta due varianti
teoricamente rosse ha in realtà i capelli castani o biondi. Sembra che
quasi duecento geni influenzino in qualche modo il colore dei capelli,
pari all’1% circa del numero totale di geni presenti nel genoma
umano. Un simile risultato si poteva ottenere soltanto disponendo
degli immensi dataset attuali: gli autori dello studio hanno esaminato
350000 persone per scoprire che il modello dei capelli rossi, un
tempo elementare, è in realtà fin troppo complesso.
Nel corso della breve storia della genetica ci siamo aggrappati a
modelli semplici che spiegavano tratti altrettanto semplici
all’apparenza, come il colore degli occhi e dei capelli. Ma anche
considerando soltanto gli occhi, vi si ritrova un’intera gamma
cromatica, che va dall’azzurro più chiaro a un colore quasi nero, per
non parlare della mescolanza di colori in una sola iride, delle
macchioline di sfumature diverse e dell’eterocromia vera e propria,
quando negli occhi sono presenti settori ben definiti di colori diversi,
o, in alcuni casi, un colore diverso per occhio.
1 Non è facile
categorizzare gli esseri umani secondo tratti che sono semplici
soltanto all’apparenza e dipendono da una genetica davvero
complicata.
Lo stesso vale per il colore della pelle. Una proteina chiamata
melanina è il pigmento principale della pelle e ha una funzione
protettiva. Oltre un milione di anni fa, spostandosi dalla giungla agli
spazi aperti della savana, i nostri antenati in Africa cominciarono a
perdere il pelo. Una fitta coltre di peluria tiene caldo, e l’evoluzione
fornì loro nuove strategie per mantenersi freschi, come una
sudorazione migliore e la perdita della maggior parte dei peli
corporei. L’esposizione improvvisa della pelle, però, accresce il
rischio sviluppare una carenza di acido folico, una delle vitamine
fondamentali per l’organismo, che viene distrutta dai raggi
ultravioletti. Da questa mancanza deriva una serie di gravi disturbi,
come l’anemia e problemi alla spina dorsale durante lo sviluppo del
feto. Si tratta di pressioni evolutive non da poco, e la pelle ha
reagito, adattandosi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :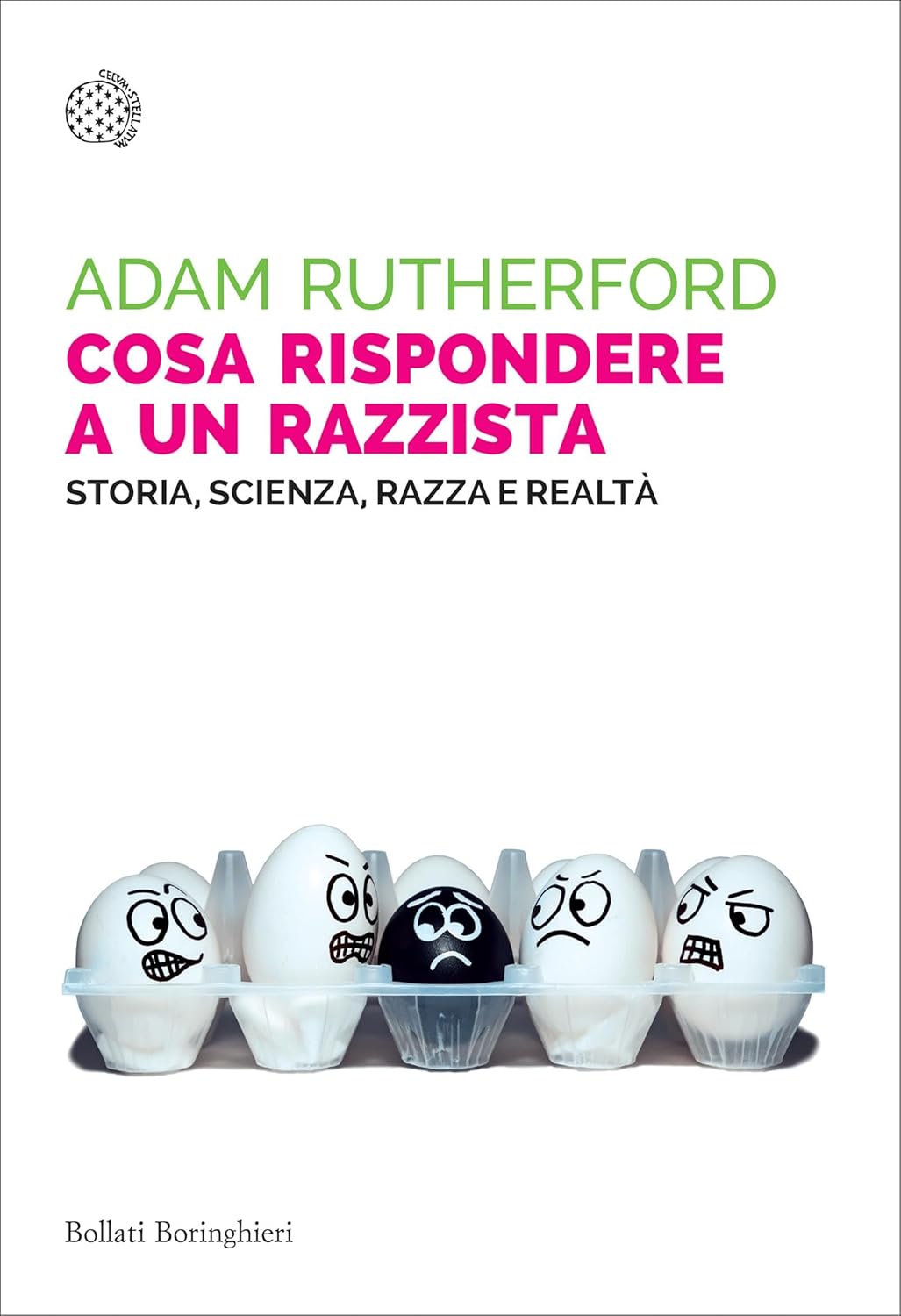






Commento all'articolo