Coronavirus ed emergenza climatica – Mario Agostinelli
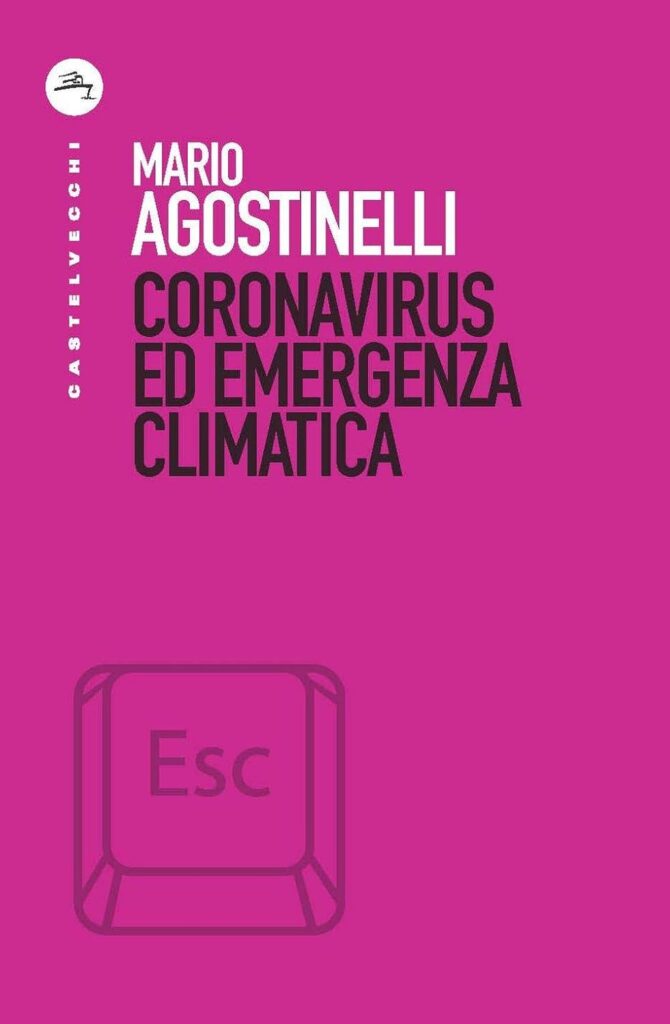
SINTESI DEL LIBRO:
Di fronte al virus, quasi ogni misura è stata contemplata e resa
possibile, al punto che la libertà, il valore cardine della modernità, è
stata messa tra parentesi non per l’ascesa di un nuovo tiranno, ma a
causa della paura di perdere la propria e l’altrui incolumità, in
un’emozione generale che domina su tutte le altre. Invece, la
reazione a un’altra crisi, assai più gravida di conseguenze in un
tempo assai prossimo – che è la minaccia alla vita sulla terra
causata dal caos climatico e dall’estinzione di massa delle specie
rimane,
soprattutto
in
irrecuperabilmente rimossa.
questo
drammatico
frangente,
Questo contrasto è tanto più sorprendente in quanto la pandemia da
coronavirus è, anche secondo le previsioni più cupe, di molti ordini di
grandezza meno mortale di un disastro climatico, che la scienza
prevede brusco e fuori controllo. Eppure, il futuro arriva quando
meno te lo aspetti e se ne procrastini la percezione diventerà ancor
meno governabile.
Ma da dove viene la pandemia che ci strazia nel fisico, nei
sentimenti, negli affetti e riconsegna dolorosamente alla natura il suo
primato, dopo che una sbornia di dominio aveva colto la nostra
specie, incapace di sentirsi connessa al resto del vivente, al Pianeta,
al Cosmo, che hanno tutti alle spalle un’unica storia comune di 14
miliardi di trasformazioni, ricombinazioni, stupefacenti magie, con
tempi e spazi propri?
Siamo frutto di una cosmogenesi permanente che la scienza
moderna viene a precisare con sempre maggior rigore e prove,
indicando che l’universo possiede una lunga tormentata storia che lo
conduce ai giorni nostri nella più totale connessione di tutti i suoi
elementi costitutivi. Ma anche la cultura più raffinata, così come
l’informazione a livello diffuso, sono schiacciate sul presente e sulla
presunzione umana di dominare la natura e orientare il suo
possesso, per poter compiere su di essa sue trasformazioni, senza
limite. Quella storia comune, nel pensiero occidentale e nella
presunzione antropocentrica è stata semplicemente cancellata.
È il caso qui di ricostruire per sommi capi l’arrivo di un osservatore
cosciente sulla Terra. Dall’inizio (subito dopo il Big Bang) prendono
sequenzialmente forma energia materia spazio e tempo. E una volta
comparsa la luce, e dopo un primo raffreddamento di uno spazio già
ampiamente espanso, vanno aggregandosi le stelle rosse, dove si
forgiano gli atomi e le prime molecole degli elementi che noi
conosciamo. Da quell’unica fonte primordiale, in continua e lenta
trasformazione, prenderà forma locale il sistema solare, con alcuni
pianeti e la Terra che ruotano intorno alla loro stella e sarà
successivamente resa possibile, per la presenza di una sottile
pellicola atmosferica che intercetta la radiazione solare, la nascita
della vita organica su un pianeta e l’alimentazione di una biosfera in
evoluzione, fino alla comparsa dell’uomo, solo qualche centinaia di
migliaia di anni fa. Un’apparizione che, per dirla con lo storico
Malmesbury – che definì la misura della “yarda” inglese come la
lunghezza di un filo che andava dalla punta del naso di Enrico I fino
all’estremità del suo pollice teso avanti agli occhi – corrisponde al
massimo a una sottile limatina dell’unghia del re. Insomma, tutti gli
organismi vivi, dai batteri, alle foreste, agli animali sono costituiti
degli stessi elementi che maturarono nel cuore delle grandi stelle
miliardi di anni fa. Francesco lo dice: siamo tutti fatti di polvere di
stelle: tutto il vivente, cioè, possiede un medesimo alfabeto genetico
di base ed è circondato da elementi nell’immenso universo non
differenti da quelli con cui lavoriamo, giochiamo, sfrecciamo per le
strade. Siamo pertanto totalmente interdipendenti, al culmine di un
susseguirsi di eventi che dura dal Big Bang con una direzione
ascendente per complessità e differenziazione e che tiene in un
inestricabile intreccio la luce, l’acqua, l’atmosfera, i batteri, i virus, gli
uccelli, gli umani. A buon ragione «nulla di questo mondo può
esserci indifferente», aveva affermato Francesco nell’enciclica.
È facile allora capire come anche la tua salute dipenda da quella
degli altri, e come nel tempo e nello spazio della pandemia
l’imperativo di isolarsi possa essere interpretato come un’inedita e
generosa forma di riconoscimento della nostra interdipendenza
globale.
La minaccia climatica “fagocitata” dalla pandemia
Passeremo ora dalla pandemia al clima, seguendo per analogia la
stessa linea interpretativa appena illustrata.
È sempre più evidente come la nostra salute e il nostro benessere
dipendano strettamente da come ci rapportiamo al pianeta che ci
ospita: il nostro destino non è avulso da quello degli ecosistemi, del
clima, della complessa rete che sostiene la vita come si è sviluppata
sino a oggi sul pianeta.
Dato che il cosmo ha un suo modo di riequilibrare le cose e le sue
leggi quando vengono stravolte, diventa possibile che le epidemie
devastanti, che stavano acquattate nelle regioni più derelitte,
comincino a far irruzione anche nel mondo ricco e igienizzato delle
potenze dotate di flotte e di armi, di chirurgia a risonanza magnetico
nucleare, di sistemi di comunicazione raffinatissimi. Basta un virus a
illuminare la precarietà della comunità umana, se questa si fa trovare
non solo tecnologicamente, ma soprattutto culturalmente e
socialmente, impreparata. Può così stabilirsi un contatto malvagio,
causato dalla presenza sempre più importante degli esseri umani
nelle “ecozone”, una volta fuori dalla nostra portata, ma ora
sovrappopolate, deforestate, sfruttate con l’agricoltura intensiva o
l’estrazione di petrolio, di gas e minerali, il bracconaggio, lo
stoccaggio in condizioni dannose di specie selvatiche e il loro
consumo. Di conseguenza possiamo confermare che i percorsi di
contaminazione e ricombinazione di virus alla specie umana – la più
efficiente ai fini della diffusione – vadano di pari passo con la
drastica diminuzione di biodiversità, l’agricoltura chimicizzata, gli
allevamenti intensivi, l’industrializzazione, l’urbanizzazione e
l’inquinamento, che tutti insieme modificano i percorsi di connettività
tra le specie.
Mai come oggi abbiamo davanti l’opportunità e gli strumenti per
affrontare in modo integrato la salute del pianeta e quella umana, su
solide basi scientifiche. Possiamo dire che dopo un lungo periodo di
benefici per la salute derivanti dall’industrializzazione, nonostante il
ricorso ai combustibili fossili, da decenni ne vediamo i limiti e i danni
profondi e distruttivi a lungo termine. Questa è una formidabile
occasione per ripensare l’economia e i nostri stili di vita alla radice,
nel quadro di un’ecologia integrale.
Fatte queste considerazioni, perché mai dovremmo stoltamente e
colpevolmente respingere sullo sfondo – dato che siamo alle prese
con la lotta al coronavirus – la minaccia ancor più grave di un
irreversibile cambio del clima che avrebbe effetti devastanti anche
sulla salute? “Saturati” dalla lotta al contagio globale, siamo ancor
più avvertiti di dover superare altre ancor più grandi emergenze
guerre, clima, migrazioni, ingiustizia sociale – che non a caso
Francesco e gli studenti di FFF non smettono di mettere a fuoco,
anche nel brusio dei giornalisti che, sempre gli stessi, da un giorno
con l’altro, spalleggiati da politici, esperti, più o meno competenti,
con o senza mascherina, predicono l’inizio di chissà quale “fase
due”.
È il caso di chiederci perché l’ascolto devoto del sapere scientifico
dei virologi non sia stato rivolto con pari intensità verso gli scienziati
del clima: eppure, le comuni origini e i legami interdisciplinari stretti
dei sintomi e della patologia delle malattie del genere umano e del
pianeta nell’Antropocene dovrebbero dare credibilità e confidenza
alle affermazioni degli uni e degli altri. Se, infatti, il principio di
precauzione si può applicare al coronavirus, perché non dovrebbe
applicarsi anche al clima? Perché mai le vite delle attuali e future
vittime del clima dovrebbero essere meno degne delle persone
messe a rischio dal virus? Quali standard etici vengono applicati a
queste decisioni? Provo a elencare sommessamente due ragioni.
La prima: per misurarsi con successo con una riconversione
strutturale come quella richiesta dalla decarbonizzazione, occorre
senz’altro uno slancio verso una politica universale, non fatta solo di
competenze, ma di consenso democratico verso principi di
precauzione, che farebbero maturare risultati in un futuro prossimo,
ma che da subito penalizzerebbero i mercati e sconvolgerebbero la
distribuzione di enormi profitti. Si dovrebbe, cioè, non riconoscere
più al capitalismo che conosciamo un suo “stato di natura”, vale a
dire abbattere in un solo colpo il trionfo del 1989.
La seconda: durante la crisi del coronavirus, qualsiasi politico che
metta in discussione misure estreme di distanziamento sociale, o
altrettanto sconvolgenti, deve temere per la sua carriera, poiché è
considerato un irresponsabile e una minaccia per la vita delle
persone, mentre non ci sono conseguenze politiche di alcun tipo per
coloro che affrontano la crisi climatica non facendo nulla.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :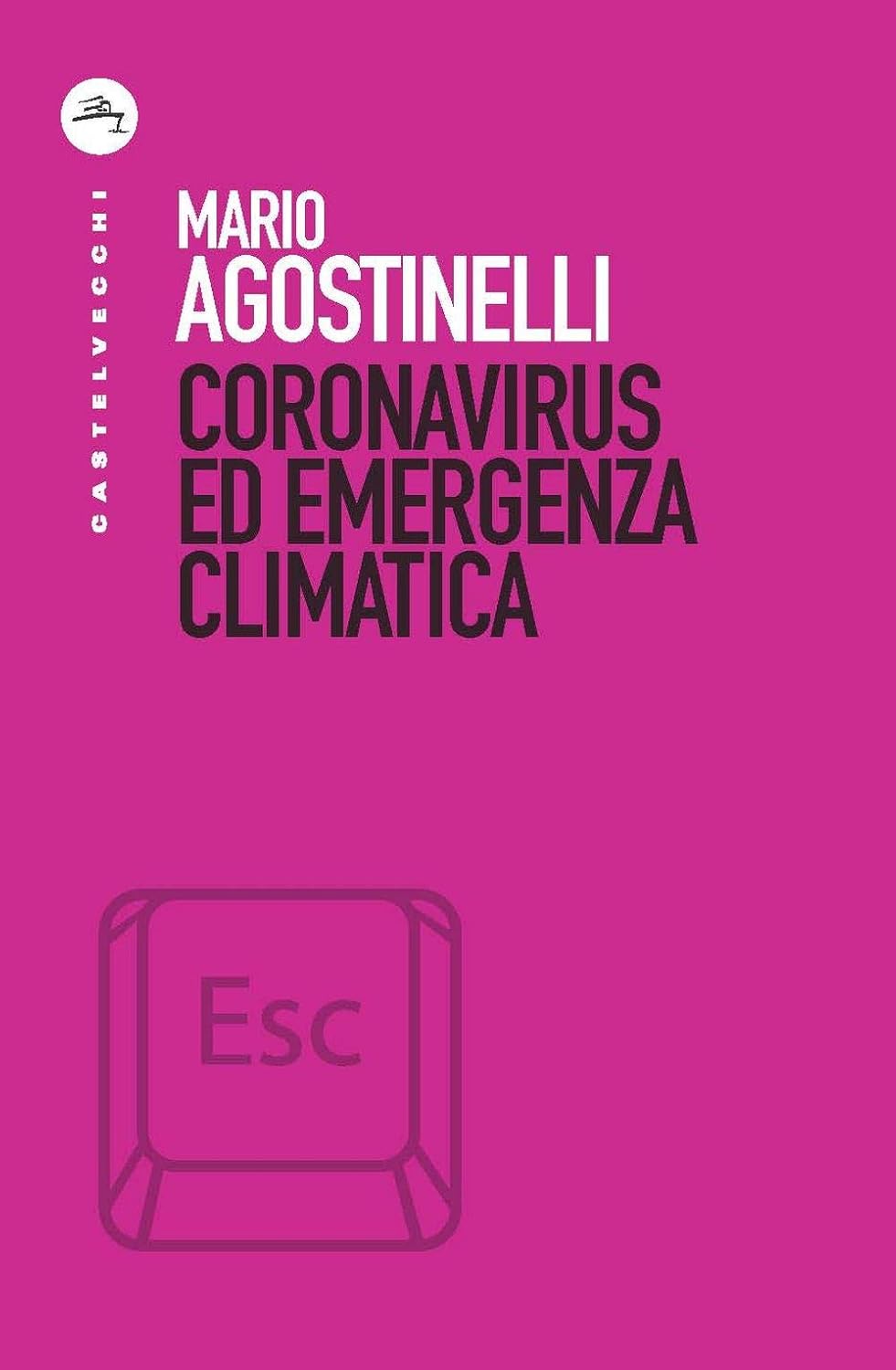






Commento all'articolo