I magnifici 7 capolavori della letteratura inglese – Autori Vari

SINTESI DEL LIBRO:
Quando Dickens inizia a scrivere Hard Times, nel gennaio del 1854, ha
già alle spalle una cospicua e varia produzione narrativa, che include
Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop,
Barnaby Rudge, Dombey and Son, David Copperfield. Ultimo in ordine di
tempo è il grandioso quadro sociale di Bleak House, ed è appena completato
questo, nell’agosto del 1853, che Dickens concepisce il nuovo romanzo: Hard
Times prosegue perciò Bleak House per la vastità dell’orizzonte sociale che
anche il nuovo romanzo vuole abbracciare.
La pubblicazione avviene a puntate settimanali (cadenza adottata
soltanto per The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge e, successivamente, per
Great Expectations), tra il 1° aprile e il 12 agosto del 1854, e se lo scopo è di
risollevare e sostenere le vendite della rivista, diretta dallo stesso Dickens,
«Household Words» sulla quale compare, ciò puntualmente avviene con il
pressoché immediato raddoppio dei numeri venduti. Il successo è in parte
collegabile a tale forma di pubblicazione, che condiziona da un lato la
misura della narrazione, ridotta a circa un terzo rispetto a quella di Bleak
House; dall’altro, tende a un ritmo più serrato rispetto a quello della
cadenza mensile. Da qui, anche, la marcata densità di questa narrazione.
Hard Times, «for these times», come precisa il sottotitolo, vuole essere
dunque un’ulteriore anatomia del presente storico. L’aggettivazione hard
introduce una immediata indicazione critica rispetto alla prevalente
ottimistica coscienza di sé di questa fase centrale del vittorianesimo. La
civiltà borghese di questo primo sviluppo industriale nella storia
dell’Occidente ha da poco celebrato la sua immagine e le «magnifiche sorti e
progressive», con la prima Esposizione Universale tenutasi a Londra nel
1851: ed è comprensibile in che senso Dickens, pur votato a rappresentare la
sua contemporaneità, «these times», non abbia mai utilizzato questo soggetto
così evidentemente simbolico ai nostri occhi, così apparentemente congruo
alla sua dimensione di giornalista e reporter. L’Hard che è parola iniziale
del titolo rimanda infatti piuttosto alla crisi di quel modello di sviluppo, sia
nel denunciare attraverso una martellante ironia la durezza e pochezza di
quei “fatti” che costituiscono la base gnoseologica ed etica del positivismo,
del pragmatismo e dell’utilitarismo inglese, sia la durezza e inumanità delle
condizioni di vita e di lavoro di chi subisce quel sistema economico, in primo
luogo la nuova classe creata dalla rivoluzione e che di questa si avvia anzi a
diventare il suo motore mobile: la classe operaia.
Hard Times contribuisce in modo cospicuo a fondare quel sottogenere
narrativo vittoriano particolarmente importante, noto come «industrial
novel», il romanzo della rivoluzione industriale, di cui si hanno altri esempi
contemporanei in Mary Barton (1848) e North and South (1855) di Mrs
Gaskell e in Sybil (1845) di Disraeli
1. L’ambientazione – diversa da quella
londinese privilegiata dal Dickens – è quella del nord dell’Inghilterra, e più
in particolare: la città fittizia di Coketown; la scena narrativa è la
trasfigurazione fantastica della città di Preston, vicino Manchester, nel
Lancashire dell’industria tessile cotoniera. Hard Times si innesta
sull’interesse sociale di cui è testimonianza già il resoconto giornalistico
fatto da Dickens sullo sciopero dei lavoratori di Preston (sciopero che si
prolungò per otto mesi, tra il 1853 e il 1854) e che egli pubblica sulla sua
rivista «Household Words», nel febbraio del 1854 con il titolo On Strike
2.
Merito indubbio del romanzo è dunque quello di aver sottoposto al suo
pubblico la centralità e l’urgenza dei riflessi sociali dello sviluppo
industriale; merito che non passa in second’ordine per via della chiave
sentimentale-emotiva con cui la questione operaia è trattata (e cioè le
ragioni della dissociazione di Stephen dagli altri operai) a discapito della
coerenza e lucidità di posizione ideologica. Né – prescindendo dalla
complessità formale del romanzo – si può spiegare come una involuzione il
passaggio da una posizione sostanzialmente solidale con le ragioni degli
scioperanti e con l’azione della dirigenza sindacale rintracciabile nel
resoconto giornalistico a cui accennavamo, alla incertezza e ambiguità
(secondo alcuni) della rielaborazione immaginativa, coi ritratti
apparentemente negativi sia del protagonista operaio Stephen Blackpool che
del dirigente sindacale Slackbrigde. I due, che emblematicamente si
contrappongono nella riunione sindacale e nella organizzazione dello
sciopero descritti nella seconda parte, sono momenti estremi, polarità
euristiche: l’uno della burocratizzazione del movimento e delle
rivendicazioni; l’altro della rassegnazione delle classi umili, della
paradossale e limitante interiorizzazione di un codice di dignità e di onestà.
In effetti, la frattura tra codice individuale e sociale, tra privato e pubblico in
Stephen, quella frattura che lo porterà a dissociarsi dall’azione sindacale, è
manifestamente pretestuosa: tutto il melodramma della impossibilità da parte
di Blackpool a sostenere lo sciopero si riduce alla promessa fatta alla donna
che ama, ma ella stessa – rammaricandosi delle conseguenze – dirà poi di
avergli chiesto soltanto di non cacciarsi nei guai: plausibilmente, forse, di
non esporsi da una posizione di individuale vulnerabilità contro quella legge,
quegli strumenti repressivi e coercitivi definiti «muddle» da Stephen, che
avrebbero facilmente ragione della sua ribellione. Ma se Slackbridge e
Blackpool sono deformazioni estreme, resta la massa operaia sullo sfondo,
una serie di voci di solidarietà con Blackpool e di intuitiva percezione della
retorica artificiosa di Slackbridge, che è tutta in termini di dignità umana ma
anche di coerenza politica. L’assemblea che Slackbridge pretende di guidare
e orientare si sviluppa in realtà al di fuori delle ragioni della sua retorica,
contempera pubblico e privato. C’è comunque una solidarietà degli altri
operai verso Stephen, ma essa è data fino a quando non danneggia le ragioni
di tutti. Forse Dickens non poteva fare molto di più, da borghese qual era,
che rappresentare così un “oggetto”-“soggetto” sociale che gli era in parte
sconosciuto. Ma proprio per questo va tenuto conto degli altri punti di vista
che ci si mostrano sullo sciopero e sul problema operaio. Quello stesso
oggetto che Dickens tratta direttamente in maniera forse goffa, lo
rappresenta in maniera superba attraverso il pregiudizio borghese: ad
esempio, la scena in cui Bitzer e la signora Sparsit commentano la situazione
sociale di Coketown, la irrequietezza operaia e lo spuntare delle loro
sediziose associazioni contro cui si invoca l’azione delle associazioni
padronali (pure scoperte già inefficaci), nella seconda parte.
Discorso analogo è da farsi in relazione ad altri aspetti del quadro
sociale, come la rappresentazione dell’ambiente operaio. La città
dickensiana di Coketown è di nuovo memorabile per come combina dato
realistico con dato simbolico, corrispondenza storica e distorsione. Non è
quindi informata sociologicamente, non fa intendere un disegno urbanistico
della città e delle sue strade, non dà nomi di strade e piazze.
Da questo punto di vista altre rappresentazioni hanno più efficacia. Va
ricordato soprattutto il quadro che il giovane Engels ci offre basandosi
sull’esempio di Manchester particolarmente nel capitolo intitolato The Great
Towns del fondamentale saggio La situazione della classe operaia in
Inghilterra
3: un quadro pressoché coevo, di straordinaria precisione e
lucidità conoscitiva, tutto funzionale alla prassi politica. Ecco quindi la
distinzione in tre zone: centro commerciale, anello operaio e cintura
periferica residenziale; e le grandi arterie di comunicazione tra periferia e
centro tendenti sempre a nascondere all’occhio borghese, che le percorre, la
scomoda realtà che il suo modello di sviluppo ha creato e su cui la sua
ricchezza organicamente si fonda.
Quindi il percorso, in senso orario, dei distretti operai della città. S.
Marcus afferma che le due rappresentazioni di quell’illeggibile, di quel
nuovo e sconosciuto universo che sono le città, hanno pregi diversi, e che in
Dickens va apprezzata soprattutto la continuità della sua indagine
dell’universo cittadino e il senso della dinamicità e del continuo mutamento
che di essa sa dare, ampiamente compensativi dei tratti rapsodici e della
mancanza di uno schema conoscitivo chiaro.
Il quadro di Coketown obbedisce però anche a ulteriori logiche. Il nome
della città rivela l’intenzione allegorica
4. La città di “Coke” prende il nome
dal tipo di carbone che ha costituito la fonte di energia primaria della
rivoluzione industriale: evoca immediatamente l’industria mineraria e la
lavorazione del ferro; dunque le ferrovie, e la rivoluzione dei trasporti. E
così è in effetti: nei dintorni di Coketown sono fatti correre i treni, su viadotti
che scavalcano la landa desolata in mezzo alla quale è posta la città, con
cavalli e carrozze relegati a spostamenti marginali; ci sono i pozzi e i loro
macchinari, attivi o abbandonati, pericolosamente disseminati nella
campagna e nascosti dalla vegetazione: i pozzi che, come dice Stephen, non
hanno mai cessato di uccidere senza motivo, anche dopo essere passati in
disuso. C’è, ancora, il fuoco – energia infernale – i cui bagliori risaltano
sull’oscuro paesaggio e fin dentro le case, dove il bruciare ormai
inarrestabile dà luogo al continuo spegnersi, al continuo raffreddarsi in
cenere di ogni scintilla di vita. La visione della città è spesso notturna,
oppure oppressa da un cielo tipicamente plumbeo, o annerita dai giganteschi
serpenti di fumo che stazionano perennemente sulla città. Non a caso il pozzo
in cui cade Stephen si chiama “Infernetto”.
Gli effetti della meccanizzazione industriale – e da qui l’ulteriore forza
del quadro di Hard Times – sono collocati all’interno di una complessa
organizzazione sociale. È lo Stato, ancillare rispetto alla sfera economica
dominata dalla borghesia, che nel suo processo di burocratizzazione diviene
bersaglio della critica dickensiana. Vediamo in effetti come lo Stato sia
funzione dell’apparato produttivo nel suo primo articolarsi in Scuola e
Istruzione
5, ed è perciò mostrato come “superstruttura” nel senso più
classico del termine. E anzi, se la vicenda operaia occupa la centrale delle
tre parti della narrazione, la “nota dominante” appena indicata è quella che
risuona per prima, già nei due capitoli iniziali, dove vediamo comminata a
una classe di alunni-vaselli, la nozione che la vita coincide con i “fatti”, che
conoscenza vuol dire scienza, ovvero parcellizzazione e misurabilità del
reale; che, di fronte a questo, ogni soggettività umana (sentimento,
immaginazione, amore del prossimo) diventa irrilevante. Vistosa in proposito
– in quel gusto di polarità radicali – la refrattarietà assoluta di Sissy.
Hard Times, nell’affrontare di nuovo un tema caro a Dickens quale
quello dell’istruzione, coglie l’inizio di un processo storico parallelo alla
rivoluzione economica e altrettanto importante. Sottolinea infatti che quanto
sta avvenendo nella scuola Gradgrind sta contemporaneamente avvenendo,
ed esattamente allo stesso modo, in altre scuole del Regno. In questo caso il
grottesco della rappresentazione non è fine a se stesso, ma è la modalità con
cui si manifesta la particolare preveggenza antiutopica di Dickens. Il nuovo
credo educativo, collegato a una intera visione della società e del vivere
umano, è portato da nuovi maestri di cui si sperimenta, qui, l’efficacia e la
funzionalità, nella fattispecie del signor M’Choakumchild che, «assieme ad
altri centoquaranta maestri, o giù di lì, era da poco giunto alla fine di un
processo di tornitura simultanea, nella stessa fabbrica e in base ai medesimi
princìpi, come fossero state tante gambe di pianoforte».
E ben si coglie questa preoccupante rispondenza tra le varie articolazioni
della società nella descrizione della stessa Coketown: una città edificata in
base a criteri di “razionalità” ma che, nel capitolo quinto, si presenta
piuttosto come incubo. Niente differenzia nella sostanza la scuola dalla
prigione, la chiesa dalla fabbrica o dall’ospedale. L’indifferenziato
urbanistico risponde all’indifferenziato della forza lavoro, the hands (“le
mani”), che abitano viuzze simili una all’altra, «che uscivano e rientravano
tutte alla stessa ora, con lo stesso scalpiccio sugli stessi selciati, per fare lo
stesso lavoro».
Emerge una civiltà in cui il potere, nelle sue varie articolazioni, è
dominio totale sull’individuo: in ciò la visione dickensiana si fa distopica, e
anticipa uno dei filoni più importanti della narrativa moderna, che partendo
da Swift passa a Huxley, a Orwell. E sorprende in effetti che quest’ultimo,
che a Dickens dedica un intelligente saggio, seppure non privo di una dose di
ambiguità, non abbia avvertito ciò che di 1984 sia già in nuce qui.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
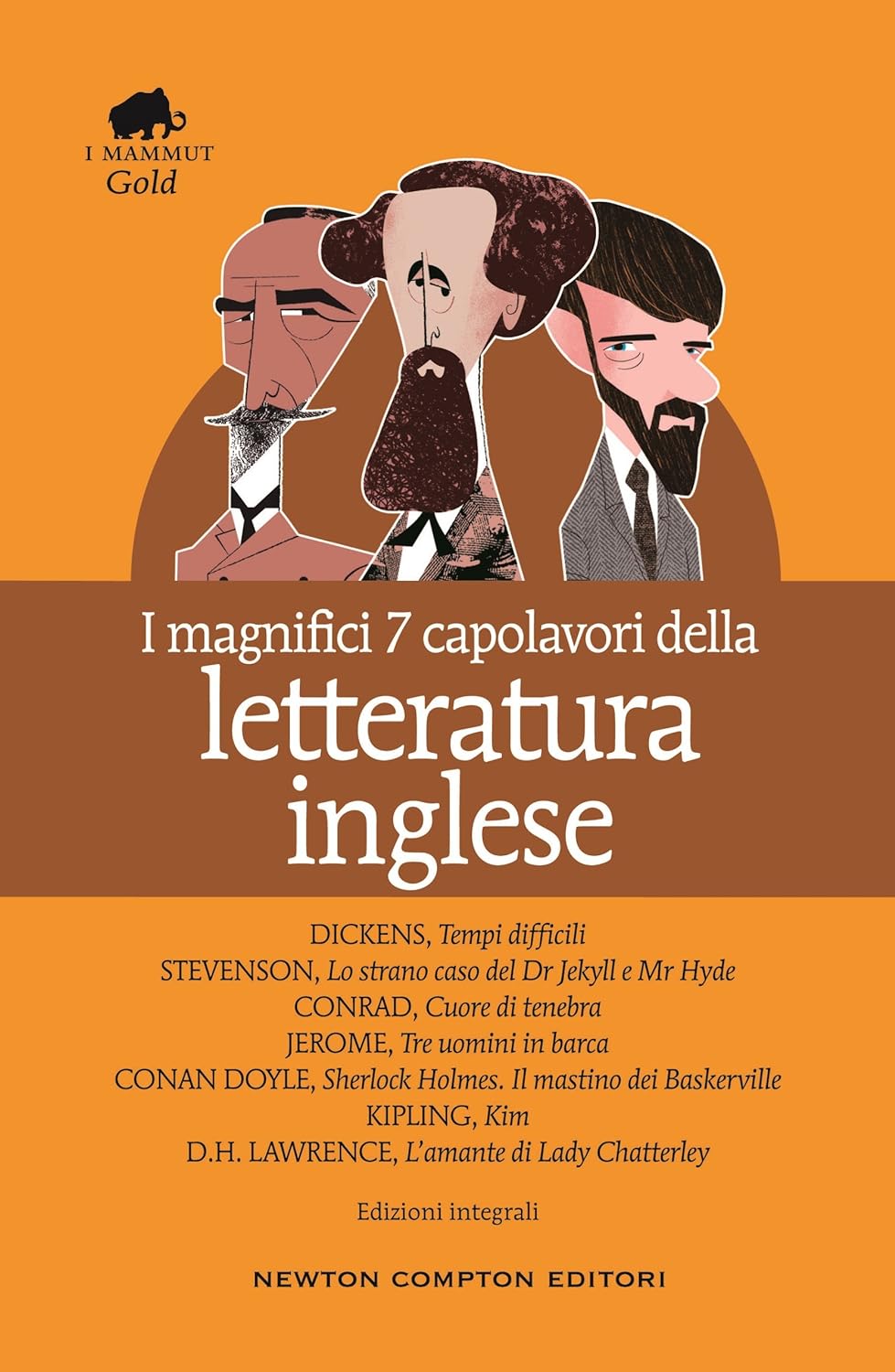





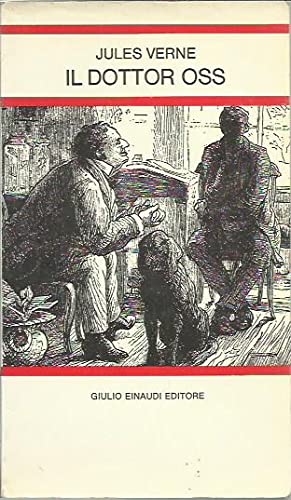
Commento all'articolo