I magnifici 7 capolavori della letteratura francese – Autori Vari

SINTESI DEL LIBRO:
LA CERTOSA DI PARMA
Introduzione di Attilio Scarpellini
Titolo originale: La Chartreuse de Parme, traduzione di Ferdinando Martini.
Introduzione
Bisogna adorare Fabrizio Del Dongo.
Maurice Barrès
Nell’autunno del 1893 un giovane scrittore francese vaga per Parma in
balia della commozione. Si abbandona ad una delle sue fantasticherie
preferite: indovinare le parole della preghiera che Fabrizio Del Dongo lesse
nella chiesa della Visitazione la sera in cui Clelia Conti venne ad ascoltarlo.
Maurice Barrès non cerca la precisione dei luoghi stendhaliani, sa che La
Certosa di Parma non è un Baedeker. Cerca le parole che nel testo non ci
sono, circola nei vicoli ariosi del non detto, dove l’ombra di Fabrizio è
ancora in agguato, alla Steccata, dove ora suonano le sette, mentre un tempo
suonò la mezzanotte. L’autore di Du sang, de la volupté et de la mort ha
capito che il segreto della Certosa di Parma sta proprio nella sua elusività,
anche rispetto alla letteratura. La forza di Fabrizio consiste nell’essere
ignoto a se stesso, l’incanto della Sanseverina nell’essere inconoscibile agli
altri. La Certosa è un libro che viene dopo il libro: resistendo
all’interpretazione, ottusamente, si riapre nel respiro voluttuoso dei ritratti
del Correggio o inseguendo il crepuscolo per le vie di Parma dove l’anima
cita direttamente da se stessa. Barrès recensisce un «piacere mortale di
soffrire volontariamente su aghi acuminati, sapendo che la nostra vita passa,
perdendosi in volgarità», un’espressione quasi perfettamente stendhaliana
che dipinge la nostalgia per la felicità che ci sfugge nei prosaici primi piani
della realtà. Mentre l’arte riporta a noi la luce tremula della lontananza, è
un sogno che fa tralucere la superficie, come in un’epifania: «L’arte del
Correggio», scrive Stendhal nella sua Histoire de la peinture en Italie, «fu di
dipingere come in lontananza anche le figure di primo piano». Potrebbe
esser questo il manifesto compositivo della Certosa, l’idea di sovrapporre
alla parabola inesorabile di un destino l’incertezza di un’aura, di rispondere
al determinismo del tema (e tutto il romanzo stendhaliano si offre come lo
sviluppo dello sfortunato tema astrale di Fabrizio) con la felicità della
variazione e l’infinito del ritratto. Questa resistenza all’interpretazione non è
l’ultima delle ragioni del relativo insuccesso della Certosa all’epoca della
sua pubblicazione. Quando Barrès scrive, la strada al cuore “anti-storico”
del romanzo stendhaliano è stata già aperta da Barbey d’Aurevilly e da
Bourget, da scrittori cioè che nel fallimento di Fabrizio – l’eroe che traversa
il campo di Waterloo senza vedere nulla – possono pienamente riconoscersi.
Nel frattempo l’anacronismo della Certosa è stato salutato da una salva di
scomuniche eccellenti che portano le firme di Sainte-Beuve, de Vigny,
Flaubert e si prolungano nella bocciatura di Zola. Tra tanti misconoscimenti,
il più duro, il più impietoso è forse quello espresso da Flaubert nel suo
carteggio con Louise Colet. Ma esso desta meno scandalo perché è frutto di
un’idiosincrasia estetica: il romanziere che vuole portare la prosa al livello
della poesia non può simpatizzare con uno scrittore che esprime ad un tempo
una caparbia volontà di raccontare – di «raccontare narrativamente», per
servirsi di una ridondante formula dello stesso Stendhal – ed una grande
diffidenza nei confronti del linguaggio. Stendhal è pur sempre colui che con
Rousseau antepone l’unità del sentimento, l’ensemble de la vie qui doit
parler, a quella della forma, lo scrittore che ne La Duchessa di Palliano si
lascia sfuggire questa ammissione rivelatrice: «Le parole sono sempre una
forza che cerchiamo fuori di noi». Le parole vengono dopo. Ma la condanna
di Zola è ancor più significativa perché espelle l’autore della Certosa dal
canone del realismo e decreta senza mezzi termini che il romanzo è
letterariamente un fallimento: «Tutti noi siamo molto infastiditi dalla
composizione frettolosa e dallo stile scorretto di Stendhal». Tra i
contemporanei della Certosa solo Balzac sembra accogliere con entusiasmo
un’opera in cui «il sublime irrompe di capitolo in capitolo». Ma anche tra gli
elogi e le riserve che l’autore de La Comédie Humaine esprime sul romanzo
italiano del «signor Beyle» si agita l’ombra del fraintendimento. Per Balzac
la Certosa è soprattutto un romanzo politico, una sorta di Principe Moderno,
l’opera che Machiavelli «scriverebbe se vivesse proscritto nell’Italia del XIX
secolo». Se il romanzo tarda a conquistarsi un pubblico è perché in realtà
esso è destinato ai diplomatici, agli statisti, a quelle «dodici o quindicimila
persone che sono alla testa dell’Europa». Lo Stendhal della Certosa di Parma
sarebbe insomma soprattutto un diplomatico che scrive, un fine politologo
alle prese con un soggetto grandioso – l’Italia paralizzata dall’assolutismo –
nel quale non è difficile scorgere l’altra faccia del moralista giacobino de Il
rosso e il nero. Lo scrittore che per tutta la vita ha lottato per non essere
schiacciato nei limiti angusti della propria identità pubblica, l’uomo che per
essere se stesso si rifugia nella pseudonimia, come i suoi personaggi
assaporano la felicità nelle torri, nei conventi, nella penombra degli amori
furtivi, si ritrova segregato in una definizione all’interno della sua stessa
opera. Nel lusinghiero giudizio di Balzac la lotta tra Beyle e Stendhal si sta
ancora risolvendo con lo smacco di quest’ultimo. Il riduttivismo dell’autore
di Papà Goriot, d’altronde, diventa ben visibile quando dal contenuto si
passa alla forma: alla forza delle idee della Certosa corrisponde la debolezza
di uno stile trascurato, dove gli strafalcioni grammaticali non si contano e la
lingua è appena «una vernice messa sul pensiero». Il risultato artistico in
altre parole è mediocre. E se la tesi del Principe Moderno non farà poi tanta
strada, il paragrafo sulle incongruenze compositive e stilistiche diverrà una
sosta obbligata per quasi tutte le letture successive. Per essere un capolavoro
– ripeterà più di recente il francesista italiano Mario Bonfantini – alla
Certosa manca ancora qualcosa, la compatta unità di una costruzione
integrata in tutte le sue parti, la possibilità di reperire in ogni sua pagina
qualcosa di memorabile, come se quest’opera della vecchiaia non riuscisse
ad esser saggia. E di fatti saggia non è, se mai è santa e dunque stolta: un
po’ come quell’energumeno di Fabrizio Del Dongo e tutti quei personaggi –
dalla Sanseverina al conte Mosca, dall’abate Blanes a Clelia Conti –
costruiti solo dal rilievo di una profonda simpatia, con quell’impasto di
«tenerezza ed allegria» che affascinava Stendhal nella musica di Cimarosa.
E forse non è un capolavoro: è un miracolo, un dono della vita alla
letteratura, che nella lingua è rimasto mal tradotto.
Sulla Francia romantica la figura di Fabrizio Del Dongo passa come una
meteora fugace e, soprattutto, anomala. Questo figlio tardivo della solitudine
rousseauiana, che a Sainte-Beuve appare piatto solo perché e incapace di
rappresentarsi a se stesso, sembra ancora meno degno di imitazione di Julien
Sorel, il suo alter ego de Il rosso e il nero. A Hippolyte Taine, stendhaliano
della prima ora, occorrerà passare attraverso la Comune e la repressione
versagliese per giudicare «odioso» Julien e sostituire al suo romanzo quello
di Fabrizio come libro di culto. Ma La Certosa non è una semplice
ritrattazione del Rosso e il nero: Fabrizio è ancora Julien, lo specchio è stato
solo rovesciato; le movenze calcolate di quest’ultimo si sono rotte nella sua
fluidità, ciò che prima era lontano – la grazia dell’assoluta identità con se
stessi – ora irrompe, e irrompe nella vicinanza dell’altro, nell’inno
appassionato dell’amore. Di preferibile alla solitudine, per Stendhal, c’è solo
la solitudine amplificata dell’amore, il cerchio magico che si stringe intorno
a due esseri nel momento del loro totale spaesamento rispetto al mondo. La
parabola di Fabrizio Del Dongo va nel senso opposto a quella di Julien
Sorel. Julien entra nel mondo, Fabrizio ne esce. Il figlio del carpentiere tenta
l’assalto al cielo della considerazione sociale, lotta per conquistarsi un posto
al sole nella Francia della Restaurazione. Si esercita nell’ipocrisia, segue
costantemente dei modelli (primo tra tutti quello napoleonico), cade in corsa.
Il figlio del marchese Del Dongo lascia quell’aristocrazia senza nobiltà che
per Stendhal rappresenta il peggiore dei mali e cerca anch’egli la strada
della gloria, assiste all’entrata dei francesi a Milano, fugge verso Waterloo,
si lega agli ambienti liberali, uccide un uomo, ma alla fine un fondamentale
sviamento lo porta altrove, non a costruirsi una carriera, bensì a dileguarsi
tra le mura di un convento. Questo sviamento è la differenza della passione:
Fabrizio cade inseguendo se stesso, Julien inseguendo il riconoscimento
degli altri. Cosa li accomuna, dunque, a parte l’ammirazione per
Napoleone? L’immaginazione, il potere dell’immaginazione di azzerare le
pretese della volontà, rendendo lontano quel che è vicino e vicino quel che è
lontano, facendo vedere quel che non si era previsto di vedere, dissolvendo
quel che doveva esser visto: la Waterloo di Fabrizio, la Parigi di Julien.
Queste miracolose cancellazioni dell’evento, che nella trasparenza del
protagonista della Certosa riescono a fluire senza intoppi, aggrediscono il
volitivo Julien a tradimento. «Quando scorse Parigi di lontano», dice
Stendhal descrivendo l’ingresso del giovane Sorel nella capitale, «rimase
quasi indifferente. I suoi sogni d’avvenire erano sopraffatti dal ricordo ancor
vivo delle ultime ventiquattr’ore trascorse a Verrières». Il congegno
romanzesco del Rosso dipende dalla volontà di Julien di non lasciarsi
sopraffare dalla tenerezza, quello anti-romanzesco della Certosa
dall’abbandono di Fabrizio all’imprevedibilità della passione – a Clelia
contemplata dalla finestra di una prigione. Tra l’uno e l’altro, l’urgenza di
vivere la bellezza ha provocato uno spasmo imperioso nel cuore di un
vecchio amante. In poco più di un mese Beyle ha composto il suo testamento
romanzesco. La relativa sfortuna critica, i fraintendimenti nei quali il
romanzo è incappato fin dal suo primo apparire, le reticenze che ancora lo
velano, destano così meno stupore: Fabrizio è tutt’altro che un eroe
dialettico, è una figura della grazia colta nel pieno fallimento della sua
venuta al mondo (la bizzarra profezia di Blanes in cui si iscrive il suo tema:
«Non avrai molto onore»). Invece di esibirsi: nessuna sfida lanciata dai
gradini del patibolo, nessuna confessione per quest’anima che si scruta nel
dubbio e nella certezza si acceca. Solo il sudario della Certosa che alla fine
gli si avvolge attorno, rilanciando chissà dove il suo segreto. Il vento soffia
dove vuole.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
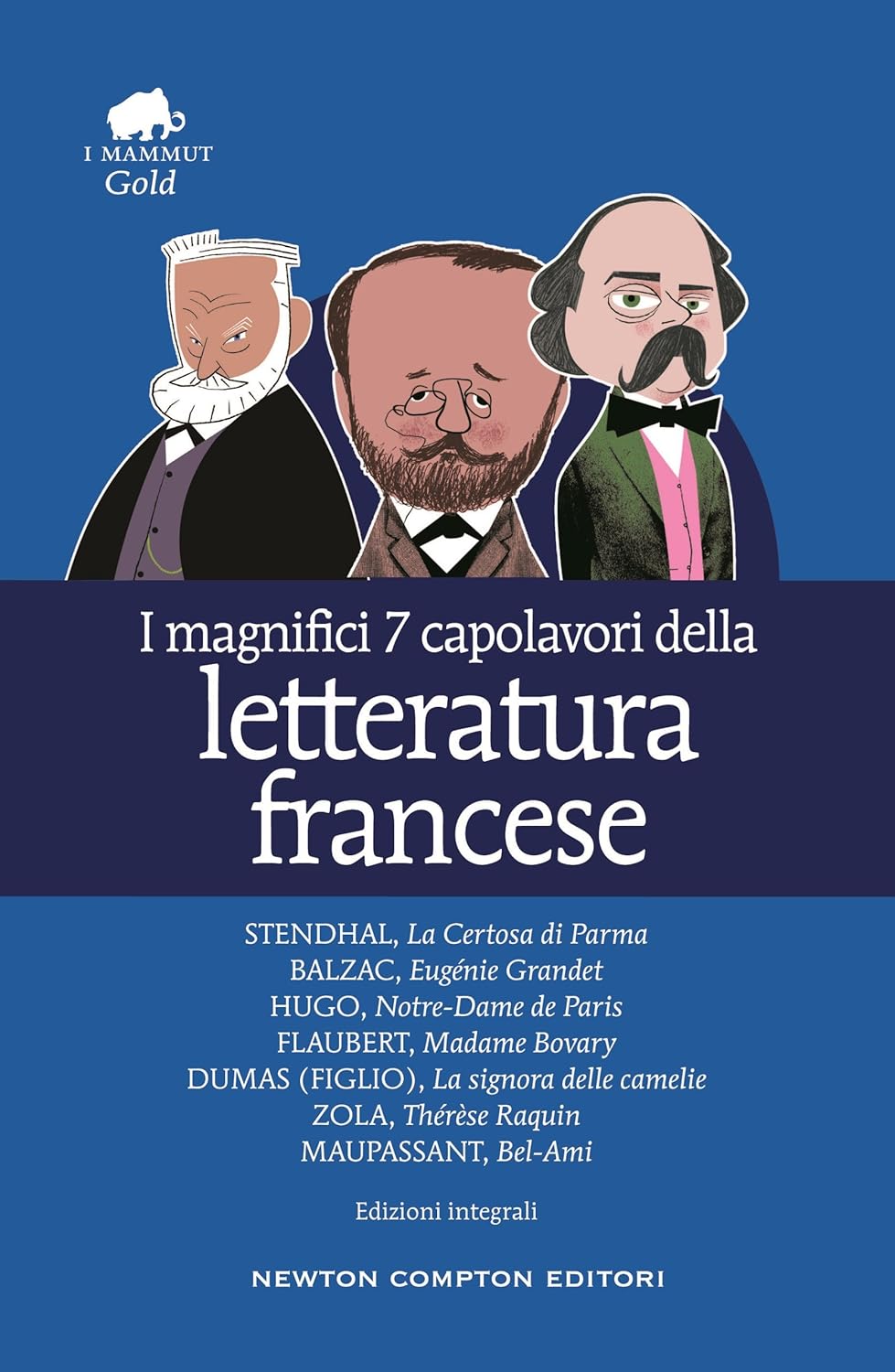





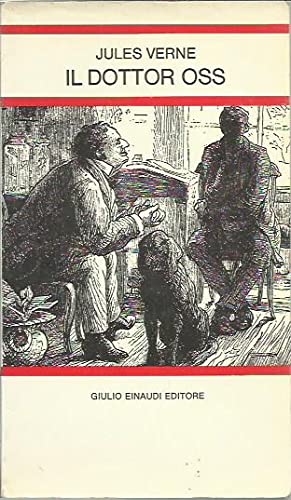
Commento all'articolo