Chi ha paura muore ogni giorno – I miei anni con Falcone e Borsellino – Giuseppe Ayala
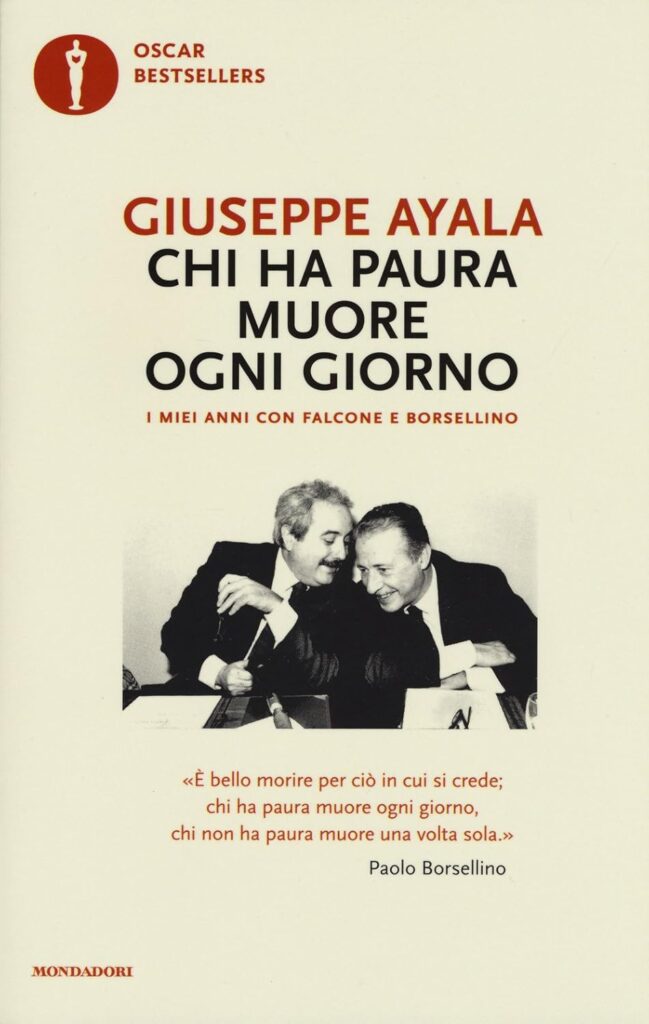
SINTESI DEL LIBRO:
Rientrato in magistratura dopo tanti anni di Parlamento, mi è
capitato di dover redigere una sentenza di condanna per il furto
aggravato di nove galline ovaiole e un gallo. Nel generale imbarazzo
sono scoppiato a ridere. Ma non ero solo. Ho sentito Giovanni e
Paolo farlo con me. A crepapelle. Ho la presunzione di sapere
esattamente quello che mi avrebbero detto: «Finalmente fai quello
per cui sei tagliato!», o qualcosa di simile. E poi, passando dal faceto
al serio: «Se dal maxiprocesso sei finito tra i ladri di polli, il problema
non è tuo, ma delle istituzioni, ancora oggi padrone infedeli dei loro
migliori servitori. Noi ne sappiamo qualcosa. E comunque, futtitinni e
pensa ‘a salute!».
Qualcuno ha scritto che, dopo più di quindici anni da quel
tremendo 1992, «forse Giuseppe Ayala ha scontato abbastanza la
colpa d’essere rimasto vivo». Spero abbia ragione.
Mi è venuta così voglia di scrivere, per me innanzitutto ma
anche per chi mi leggerà (i venticinque di manzoniana memoria?), la
storia di una grande amicizia nata per caso e vissuta tra successi e
drammi. Che si ostina a non morire e che continua a farmi piangere,
ma anche ridere. Con loro due, ancora.
23 maggio - 19 luglio 1992
L’appuntamento era fissato per il primo pomeriggio di venerdì 22
maggio all’aeroporto di Ciampino. Falcone, come spesso accadeva,
mi avrebbe dato un passaggio per Palermo sul volo di Stato.
In mattinata mi telefonò per avvertirmi di un cambiamento di
programma.
Francesca non si sarebbe liberata dal lavoro in tempo. Il decollo
era spostato di ventiquattr’ore. «Giovanni, arrivare a Palermo sabato
sera per ripartire lunedì mattina mi fa pensare che è meglio che io
rimanga a Roma. Ti ringrazio, ci vediamo la settimana prossima.»
Alle 17.59 di quel sabato cinquecento chili di tritolo fecero
scempio di cinque vite e della dignità di questo Paese. Avrei dovuto
esserci. Il «nonnulla» che non aveva salvato Ninni Cassarà rimase al
mio fianco. Gli debbo la vita.
Domenica 19 luglio, tornato dal mare, stavo riposando. Intorno
alle sei del pomeriggio sentii un boato che mi fece saltare dal letto.
Mi affacciai, ma non notai nulla di particolare. Dopo qualche minuto
vidi un’enorme nube nera superare i dieci piani del palazzo di fronte
a casa mia. Scesi in strada. La scorta mi seguì. Dopo duecento metri
i
nostri occhi furono costretti a una visione che a qualunque essere
umano andrebbe risparmiata. E che non descrivo. Inciampai in un
tronco di uomo bruciato. Era quello che restava di Paolo Borsellino.
Fui il primo a vederlo in quello stato. Sarò l’ultimo a dimenticarlo.
I
La voglia di schierarmi
«Signor pretore, lei lavora troppo.» Fu questo il saluto che mi
rivolse, con tono confidenziale ma rispettoso, il cancelliere della
pretura di Mussomeli, dottor Catania, al mio rientro dalle ferie estive
del 1979.
Conoscevo ormai da qualche anno l’uomo e ne apprezzavo la
correttezza ma, soprattutto, per me giovane pretore, la consumata
esperienza professionale. Specie all’inizio era stata preziosa e aveva
contribuito, nel tempo, a consolidare tra noi un rapporto fatto non
solo di stima reciproca, ma anche di simpatia. Capii così che non
poteva trattarsi di una battuta. Lo invitai nel mio ufficio, chiusi la
porta e gli chiesi di spiegarmi meglio. Che di un messaggio si
trattasse, era sin troppo ovvio.
Il
dottor Catania fu chiarissimo e, dati alla mano, mi spiegò:
«Vede, signor giudice, ho controllato le pendenze sia civili che
penali. Basse sono. Troppi provvedimenti lei deposita. Lo sa quale
sarà il risultato? Lei non riceverà né complimenti né encomi, ma tutti
e due saremo applicati: lei al tribunale di Caltanissetta e io alla
pretura di Villalba, che è da tempo senza cancelliere. Così saremo
premiati. Con un aumento di lavoro e con la seccatura di dover
viaggiare». Sarebbe stato, perciò, davvero opportuno che le
«pendenze» risalissero.
Risposi con un sorriso, al quale affidai la trasmissione del mio
pensiero. Non mi sembrava affatto di lavorare troppo. Ma, al tempo
stesso, mi rendevo conto di non potermi mostrare indifferente (e non
lo ero) al fatto che sarei stato comunque io la causa dei disagi del
povero dottor Catania, che proprio non li meritava.
Trovai un argomento. Ricordai al mio interlocutore che il
Consiglio superiore della magistratura aveva svolto un capillare
monitoraggio, ricavandone, per ciascun ufficio giudiziario, un indice
numerico rappresentativo del rapporto tra mole di lavoro e risorse
umane disponibili. L’indice uno fissava l’impiego ottimale della
risorsa umana, e cioè del magistrato addetto a quel determinato
ufficio. Di conseguenza, tutti gli indici superiori all’unità segnalavano
un eccesso di carico di lavoro, quelli inferiori il contrario. Il dottor
Catania sapeva bene che l’indice relativo alla nostra pretura
cominciava con uno zero virgola. Non potevo, quindi, abbassare il
ritmo di produttività. Sarei passato per uno scansafatiche.
Anche se sapevamo bene tutti e due che non sarebbe successo
proprio nulla, la perorazione della futura vittima del lavoro altrui si
infrangeva lo stesso contro il mio orgoglio, ancor più che contro il
mio senso del dovere. Allargai le braccia e, con un nuovo sorriso,
chiesi la sua comprensione. La ottenni.
Naturalmente Catania aveva ragione. Di lì a poco arrivarono,
inesorabili, le temute applicazioni e i conseguenti disagi. Il
cancelliere commentò i provvedimenti con un:
«Che le avevo detto?». Al quale replicai: «E che potevo fare?».
Ma lui continuò a volermi bene lo stesso. L’episodio mi fece riflettere
sul reale funzionamento della macchina della giustizia in Italia. Ma,
sul piano personale, mi lasciò del tutto indifferente, se non per i
fastidi che avevo provocato al mio apprezzatissimo collaboratore.
Stavo muovendo i primi passi da magistrato, ma non ero un
pivello, perché subito dopo la laurea avevo frequentato l’ambiente
giudiziario come giovane avvocato, fino a quando una mia meditata
rinuncia non aveva posto fine a quella carriera.
Superati gli esami di procuratore legale, ero stato accolto in uno
degli studi penalistici più importanti di Palermo, quello del professor
Girolamo Bellavista, ordinario di procedura penale in quella
università e quindi mio ex docente. Nonché autentico principe del
foro, dotato di un’oratoria magnetica, ma anche di una enciclopedica
cultura giuridica e umanistica. Una grande personalità. Ero entrato
presto nelle sue grazie: faceva in modo che venissi nominato anch’io
dai suoi clienti per affiancarlo, specie nei casi che richiedevano un
più assiduo impegno.
L’ultimo era stato un processo di mafia, con molti imputati
chiamati a rispondere anche di diversi omicidi, che si era celebrato
davanti alla Corte d’assise di Agrigento dall’ottobre 1973, appena
qualche giorno dopo l’improvvisa morte di mio padre, alla primavera
del 1974.
Avevo trascorso buona parte di quei mesi a seguire le udienze,
trattenendomi spesso anche per la notte. La mia camera d’albergo si
affacciava su un terrazzo distante, in linea d’aria, poche decine di
metri dal tempio della Concordia. Mi soffermavo a contemplarlo ogni
sera, prima di andare a dormire e dopo aver trascorso interi
pomeriggi a colloquio con gli imputati in carcere. Il contrasto era
violento. La mia terra mi offriva le vestigia di una grande civiltà nelle
stesse giornate in cui per ore avevo vissuto in diretta la barbarie
mafiosa. Sembrava fatto apposta per aiutarmi a risolvere
definitivamente il disagio che mi provocava il contatto quotidiano con
quei delinquenti, divenuto ormai insopportabile.
Avevo ventotto anni e una gran voglia di schierarmi. La parte
giusta mi sembrò quella della Sicilia che combatteva la mafia, non
l’altra, che la tollerava. Alle quattro di un mattino, in perfetta
solitudine, decisi che il mio mestiere sarebbe stato un altro, quello
del magistrato. Non persi tempo e vinsi il primo concorso utile.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :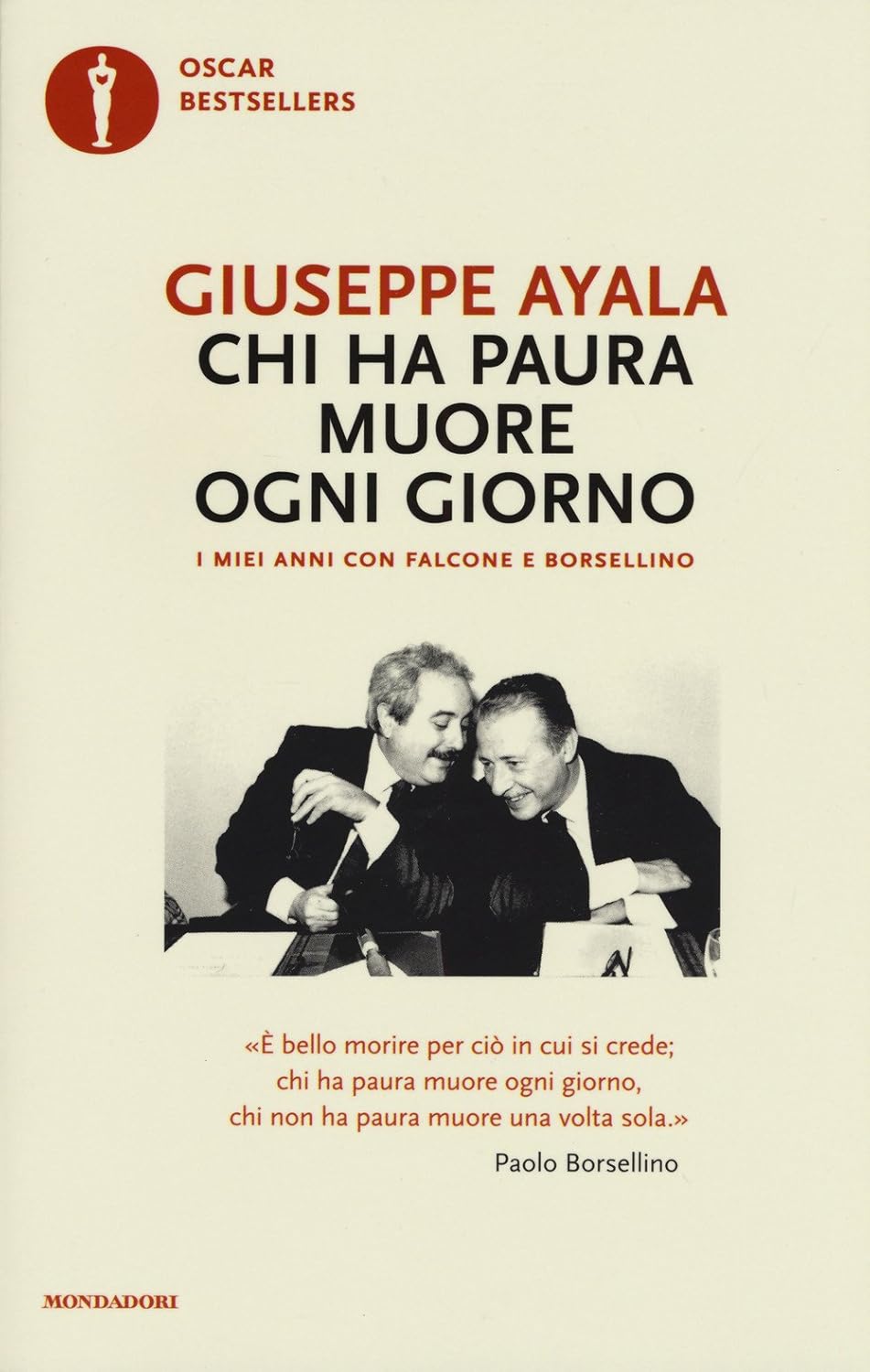






Commento all'articolo