Averroè o il segretario del diavolo – Gilbert Sinoué
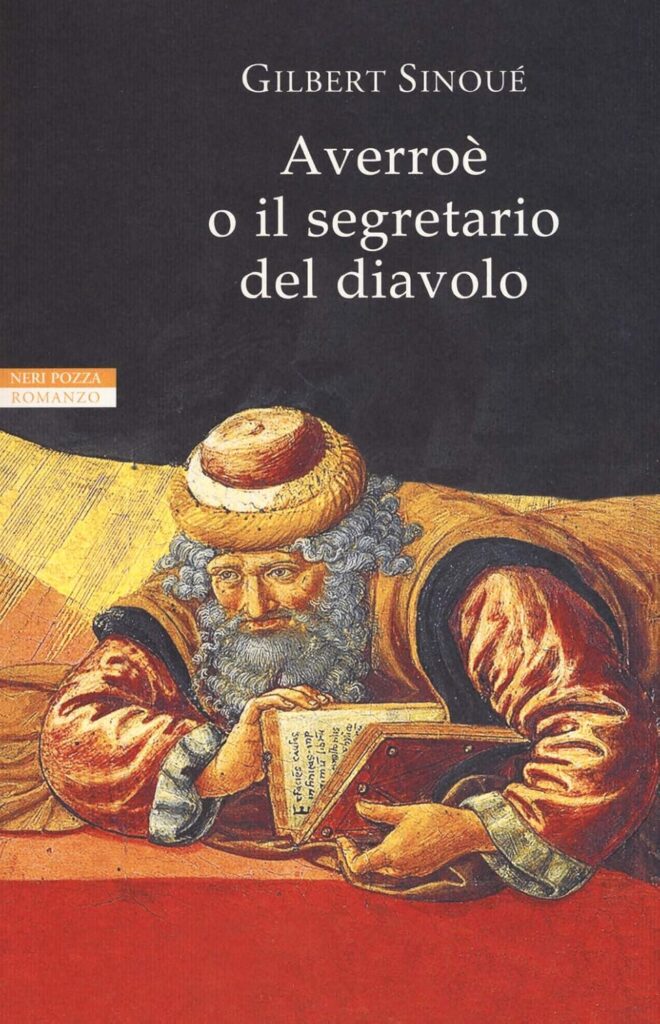
SINTESI DEL LIBRO:
Giungendo dalle stelle, discendono profumi inebrianti e risuonano antiche
melopee, mentre, addossata ai bastioni della Città rossa, la notte parla alla mia
memoria.
Sono giunto come l’acqua.
Partirò come il vento.
Presto l’alba getterà nella coppa delle tenebre la pietra che farà fuggire le
stelle.
Chi sono io?
I latini mi chiamano Averroè. Gli ebrei, Ben Roshd.
Per gli arabi sono Abu al-Walid Mohammad Ibn Ahmad Ibn Roshd.
Sono venuto alla luce settantadue anni fa a Cordova, tra i contrafforti della
Sierra Morena e le ricche pianure di Campiña. Vivevamo allora un’epoca di
grande scienza, ma anche di grandi tumulti.
Quattro secoli prima della mia nascita, un capo guerriero berbero aveva
attraversato lo stretto che separa l’Occidente dal Maghreb ed era sbarcato in un
luogo conosciuto da migliaia di uomini. Quel guerriero posò la sua impronta su
tutto il sud, prima di dilagare verso nord e impadronirsi di Toledo.
Sono dunque quattro secoli che gli arabi occupano una vasta parte della
penisola. Quattro secoli, durante i quali più dinastie si sono dilaniate. Omayyadi,
Abbasidi, Almoravidi; mentre scrivo, sono gli Almohadi a regnare. Quanto ai re
cristiani, nonostante i loro reiterati attacchi non sono riusciti a porre fine alla
nostra presenza. Per quanto tempo ancora?
Scrivo per mio figlio, Jehad. L’unico sopravvissuto dei miei tre bambini.
Scrivo unicamente per lui.
Consapevole della deriva che sta trascinando il nostro mondo verso
l’intolleranza, come potrei non metterlo in guardia e non rivelargli ciò che mi
venne proibito di palesare fin quando avessi avuto vita? Ho vissuto con un
bavaglio, ho vissuto sotto minaccia, e stasera il mio estremo timore è che queste
pagine finiscano sotto occhi indiscreti. Conoscerò allora una doppia morte. Dopo
aver letto le mie parole, i teologi che di Allah non conoscono che il nome mi
strapperanno al mio sudario per gettarmi in pasto ai cani. Per la maggior parte di
loro, ahimè, l’obiettivo non è la spiegazione del Corano, del quale non capiscono
nulla. Sono elementi oscurantisti che si impadroniscono del testo sacro per
elaborare un’altra forma di religione. Così facendo, essi costituiscono un
pericolo di discordia per la comunità musulmana, e una minaccia all’unità.
Se il Creatore dei mondi mi concederà il tempo per terminare queste
memorie, le affiderò a mio figlio, che, dopo averne preso conoscenza, le
consegnerà a qualcuno di sua fiducia, poiché io non voglio in alcun modo che sia
lui a conservarle. Sarebbe troppo pericoloso. L’uomo a cui penso si chiama Ibn
al-‘Arabi. Non è un amico; anzi, a volte siamo stati in disaccordo. Ma il
tradimento non viene forse spesso da chi ci è più vicino?
Ibn al-‘Arabi era solo un adolescente imberbe quando lo incontrai per la
prima volta. Io avevo cinquantatré anni, lui quattordici. Ero un giurista e uno
stimato filosofo, autore di numerosi scritti, tra i quali un libro che considero
essenziale tanto per le critiche velenose che ha suscitato, quanto perché ho la
certezza di aver realizzato un’opera fondamentale1.
Quel che avevo sentito dire su Ibn al-‘Arabi mi aveva molto sorpreso. Nel
corso di varie sedute di meditazione, il ragazzo aveva ricevuto le risposte alle
domande che noi filosofi ci poniamo. Mi interessava verificare di persona come
qualcuno, immersosi del tutto ignorante in un processo meditativo, potesse
uscirne così trasformato. Essendo amico di suo padre, lo pregai di organizzare
l’incontro.
Nel giorno fissato, il ragazzo si presentò a casa mia. Lo accolsi con calore, lo
abbracciai perfino. Dopo che se ne fu andato, mi ero fatto un’idea chiara. Quello
che avevo avuto di fronte non era un filosofo, come avevo creduto all’inizio, ma
un mistico.
Il ragazzo era uno di quegli esseri che rivendicano un’esperienza nella quale
conoscenza, amore, puro intelletto e sensi si confondono tutti tra loro. Sono
convinti che la meditazione consenta di oltrepassare i limiti in cui la ragione è
talvolta costretta a rinchiudersi. Nel corso del nostro colloquio aveva parlato di
«ispirazione divina». Ma non esiste alcuna «ispirazione divina»! Per accedere
alla conoscenza conta solo il pensiero razionale, separato da ogni influsso
d’ordine emozionale.
Da allora non ho più rivisto Ibn al-‘Arabi, ma di recente lui mi ha fatto
pervenire i versi di una poesia ancora incompiuta. Li ho imparati a memoria e li
trascrivo tali e quali: «Il mio cuore è aperto a tutte le forme; esso è pastura per le
gazzelle, cenobio per i monaci, tempio per gli idoli, e la Ka’ba per chi ne
percorre il perimetro. È le Tavole della Torah e anche le pagine del Corano. Mia
è la religione dell’Amore. Dove le sue carovane dirigono i loro passi, l’Amore è
la mia religione e la mia fede».
Ho trovato questo testo di grande bellezza, ma non dubito che, se un giorno
venisse pubblicato, esso attirerebbe gli anatemi degli uomini di religione.
Sappiamo quanto sia pericoloso discostarsi dai sentieri da loro indicati.
Comunque sia, ho conservato per questo pensatore un affetto sincero, nonostante
in vari passi egli abbia dichiarato di non aver imparato nulla dalle mie opere.
Potrà stupire che io voglia affidare questo manoscritto a qualcuno che non ho
più rivisto da quando era un ragazzo. La risposta è semplice: a farmi decidere in
questo senso sono stati proprio i versi di quella poesia. Un uomo capace di
esprimere in quel modo l’amore, non può tradire. Un uomo capace di affrontare
le leggi e di resistere ostinatamente a ogni vincolo, è un uomo che conserverà
queste pagine senza timore e saprà a chi trasmetterle in futuro.
Certi giorni, quando il cielo è limpido, dalla mia terrazza intravedo, oltre la
pianura e il deserto, le cime innevate dell’Atlante, e in qualche punto di esso
immagino la sommità maestosa del Jebel Tubkal, immobile ed eterna.
La natura rimane.
Gli uomini passano.
Solo la montagna, impassibile come il tempo, conosce la verità. Ha visto
vincitori e vinti; sultani e gente misera; palazzi e capanne; il tramonto degli
Almoravidi e il trionfo degli Almohadi. Due dinastie, due aquile che, di volta in
volta, si sono disputate il diritto di infrangere le reni della terra per versarvi il
loro seme.
Tanto sangue. Tanti morti. Tante rovine. Ma anche tanta grandezza.
Quando osservo il mio volto nello specchio di bronzo, non riesco più a contare le
rughe. Ognuna di esse rappresenta le domande che mi ossessionarono, e che
ancora ossessionano quanto mi rimane da vivere.
Solo. Partirò solo. Poco importa! Una volta che le ali della morte si siano
ripiegate sulle nostre ossa, non siamo più nulla, se non un ricordo arenato nella
memoria di coloro che ci hanno conosciuto. I nostri figli ci avranno amato?
Certamente ci avranno giudicato. I nostri figli, e forse un uomo o una donna che
abbiano provato nei nostri confronti qualche considerazione poiché, in verità,
ben rari sono coloro che si preoccupano di sapere se siamo vivi o morti.
Chi sono io?
Quale granello di sabbia, cadendo, farà scattare il momento della mia ultima
ora? Dove andrà la mia anima, quell’anima sulla quale tanto ho scritto? In quale
divino palmeto?
Io, che ho evocato l’unicità del tutto, che ho affermato che l’universo e il suo
Creatore non sono che un tutt’uno, oggi vacillo sotto la violenza del dubbio
mentre, nel mio intimo, ho sempre saputo che la verità non potrebbe mai essere
contraria alla verità, che gli esseri e le loro cause nascono dalla conoscenza di
Allah. È così: coloro che sanno sono in preda ai dubbi, e gli ignoranti si nutrono
di certezze.
Teologia, matematiche, giurisprudenza, filosofia, medicina, Aristotele.
Aristotele, maestro mio, Aristotele, fonte di ogni mio sapere. Fedeli amici,
compagni di sventura! Grazie a voi ho compreso il cielo. A causa vostra ho
sfiorato la Gehenna. Sono stato amato. Sono stato molto più odiato che amato.
Lo sarò senza dubbio per molto tempo dopo la mia morte, perché l’ignoranza
conduce alla paura e la paura conduce all’odio.
È questa l’equazione.
1. Senza dubbio Averroè allude al Discorso decisivo, la cui stesura risale circa al 1179 (N.d.A.).
2.
Dodici anni dopo la morte di Averroè
Parigi, novembre 1210
Già da alcuni giorni, su suggerimento di Pierre de Corbeil, arcivescovo di Sens,
il Concilio si era riunito a Parigi. Parigi, la città in cui il gusto risorgente della
scienza e della ricerca della verità – conformi o meno ai canoni della Chiesa
produceva ogni giorno idee nuove, alcune delle quali, ovviamente, non
mancavano di sollevare critiche violente, al punto che l’individuazione degli
eretici era divenuta l’occupazione principale dei legati del papa. Le inchieste si
erano succedute alle inchieste, e si erano concluse con l’arresto di quattordici
persone – tredici chierici e un laico.
Il primo della lista, il più ardente, era il sottodiacono Bernard, che si diceva
ignorasse del tutto la teologia. C’era anche Guillaume d’Aire, un orafo
impudente, settario e devoto di una religione nuova, assieme ai suoi complici:
Etienne, diacono del Vieux-Corbeil1, Jean, curato di Orsigny, non lontano da
Palaiseau2, e Pierre de Saint-Cloud. Quest’ultimo aveva tentato invano di
sottrarsi alle ricerche degli emissari vescovili. Travestito da monaco, era andato
in tutta fretta a nascondersi nell’abbazia di Saint-Denis. Il vescovo di Parigi
aveva preteso che gli venisse consegnato, ed era stato accontentato.
Agli occhi dei prelati, la colpevolezza di queste persone era al di là di ogni
dubbio. Quei chierici avevano osato negare la virtù dei sacramenti, annunciato la
prossima dissoluzione della comunità fondata dai discepoli di Cristo e
proclamato, come primo articolo di un nuovo Vangelo, la libertà individuale
delle coscienze.
Quasi tutti gli accusati, non avendo potuto smentire le accuse a loro carico o
disdegnando di farlo, avevano finito per riconoscere di fronte al Concilio tutto
ciò che veniva loro imputato.
In un ultimo slancio di sfida, il sottodiacono Bernard aveva osato affrontare
il rigorismo ortodosso dei suoi giudici professando la seguente dottrina, a dir
poco originale: «Tra tutte le cose che partecipano della vita, vi è un’essenza
comune, e questa essenza comune a tutte le cose è Dio. Consegnate, consegnate
pure il mio corpo alle fiamme del rogo, o tormentatelo con qualche altro
supplizio! Tutto il vostro furore non distruggerà nemmeno una piccola parte del
mio essere, perché, essendo ciò che sono, io sono Dio».
Com’era logico attendersi, Bernard venne inserito per primo nella lista dei
destinati al supplizio. Alcuni dissero che quella era la gloria che aveva
perseguito.
Venne condannato anche un certo Maitre Amaury, originario di Bène, nella
regione di Chartres. Ma, cosa davvero strana, Amaury era già morto e sepolto da
due anni! Si era creato una reputazione nell’insegnamento della logica, e aveva
affrontato l’insegnamento della teologia seguendo un metodo elaborato
personalmente. Egli affermava che ogni cristiano è un membro del Cristo e ha
patito con lui il supplizio della croce. Amaury insegnava anche, invece del Dio
come entità distinta dei cristiani, un Dio profano presente in ogni più piccola
particella di materia. Affermazioni, queste, che non potevano mancare di
attirargli le maledizioni del clero.
Quella mattina di novembre del 1210, la condanna dei quattordici accusati,
tra i quali alcuni discepoli di Amaury, fu compito dei vescovi. Compito poi dei
teologi presenti al Concilio fu quello di individuare quali semi velenosi avessero
fatto germogliare nelle menti degli accusati una tale messe di eresie. Dove
avevano attinto ispirazione? Da quale maestro? Con quali letture?
Da poco tempo l’Università di Parigi possedeva una versione latina della
Metafisica di Aristotele, alla quale erano allegati alcuni commenti anonimi. Ecco
dunque trovato il colpevole: Aristotele! Quel «miserabile Aristotele», come
l’aveva definito Tertulliano. Ecco il responsabile della follia che si era
impadronita di quegli uomini.
Il 13 novembre venne pronunciata la sentenza.
«Sotto pena di scomunica, nella città di Parigi d’ora in avanti è proibito
leggere, sia pubblicamente che in privato, i libri di filosofia che portano il nome
di Aristotele e i commenti che li accompagnano. È proibito copiarli e possederli.
Essi saranno sequestrati e gettati nel fuoco».
Il 19 novembre, consegnati al braccio secolare, dieci accusati salirono sul
patibolo; quattro furono condannati alla prigione a vita. Le ossa di Amaury
vennero dissotterrate e bruciate.
Quel giorno qualcuno si domandò: «Si sa chi sia l’autore dei commenti ad
Aristotele?»
1. Località a ventinove chilometri a sud-est di Parigi, nel Dipartimento dell’Essonne, nella regione dell’Île
de-France (N.d.T.).
2. Altro Comune dell’Essonne (N.d.T.).
3.
Sono nato a Cordova, nell’anno 1126 dell’era cristiana.
Cordova, la mia città, di cui costantemente avverto la mancanza. Cordova, i
cui profumi non hanno mai cessato di abitare la mia memoria, nella pena e nella
gioia, sulle strade d’argento da Siviglia fino a Lucena, da Fès a Marrakesh.
Sempre Cordova. Anche stasera, mentre mi sto perdendo verso l’ultimo estuario,
vibrano nel mio cuore le ottocento colonne di marmo della Grande Moschea,
ove, sin da quando fui in età di camminare, mio padre mi condusse a lodare il
Signore dei mondi. E nonostante quel che ha detto quel grande medico che fu
Galeno, io sostengo che oltre ai quattro climi da lui descritti – il caldo, il freddo,
l’umido e il secco – ne esiste un quinto, il più dolce: il clima di Cordova.
Cordova, centro della felicità, ma soprattutto città del sapere.
Quand’ero giovane, vi contai non meno di settanta biblioteche! Se ancor oggi
i libri latini rimangono sepolti nelle abbazie, a disposizione unicamente dei
religiosi, i nostri si trovano ovunque nella città: nei palazzi fastosi degli emiri,
nelle case dei giuristi e dei sapienti, ma anche presso i semplici cittadini.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :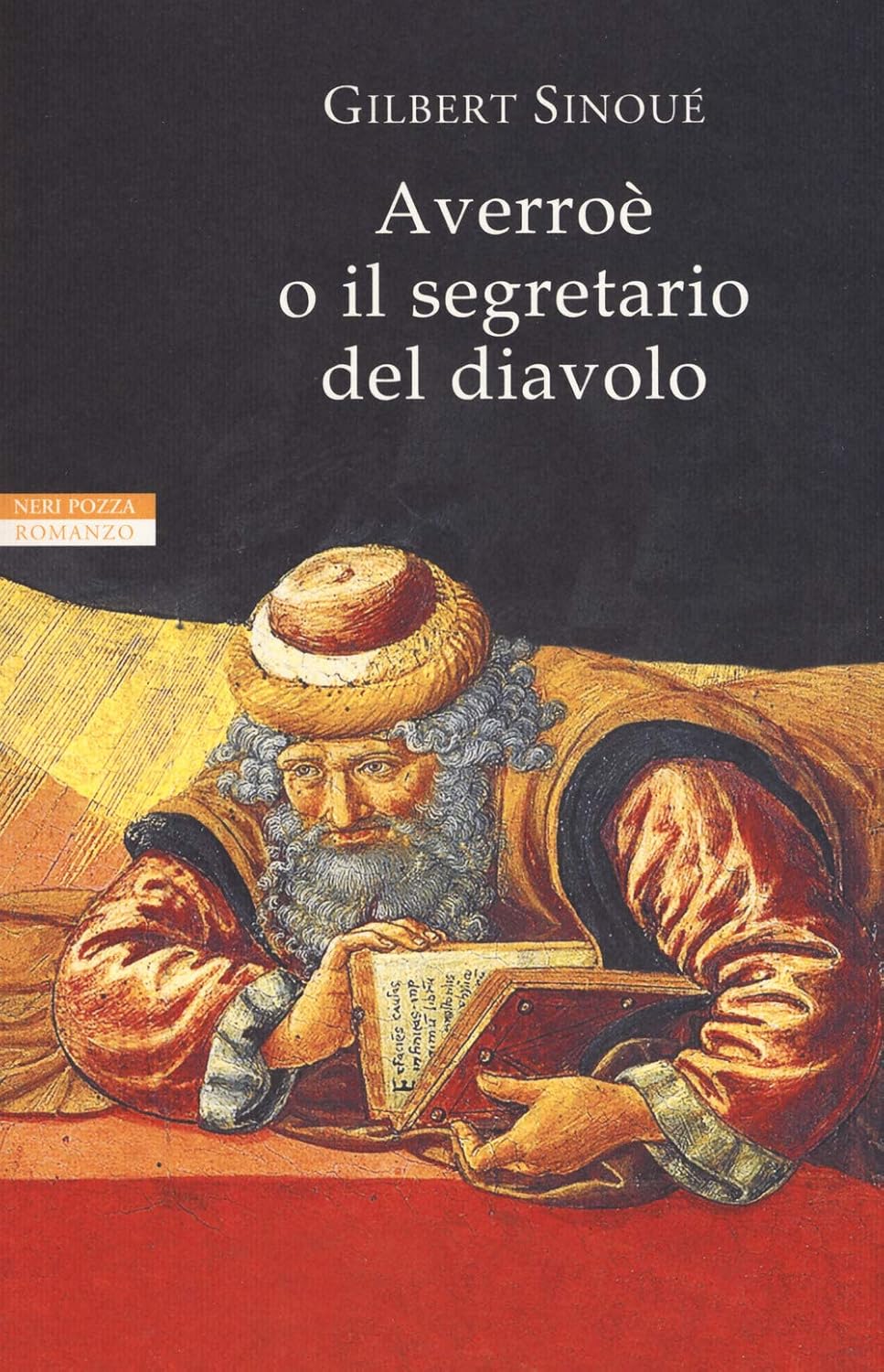






Commento all'articolo