Anna Magnani – Un urlo senza fine – Italo Moscati
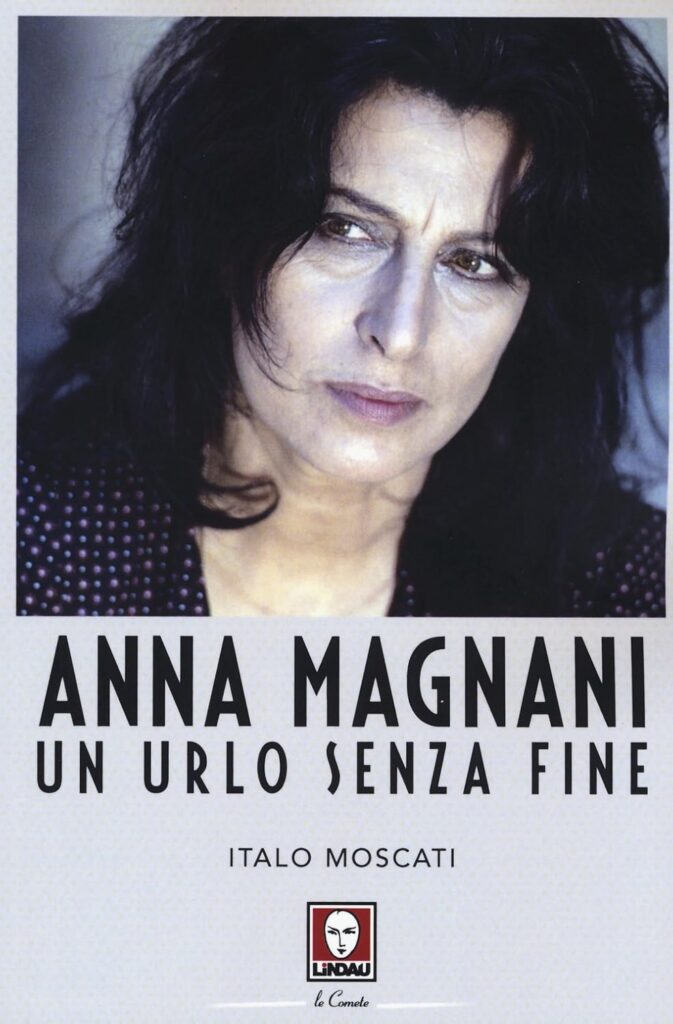
SINTESI DEL LIBRO:
«Anna guardava chiunque si
trovasse davanti ben dritto negli occhi, e
per me tutto il periodo in cui fummo amici
non udii una parola falsa sulla sua
bocca.»
Tennessee Williams
… starebbe benissimo in quel
vestitino nero con le stringhe alla Anna
Magnani.
Michael Cunningham, Le ore
Anna Magnani l’ho conosciuta quando avevo ventidue anni. Le
ho stretto la mano, timidamente, poi mi sono seduto accanto a lei e
guardandola, spesso abbassando gli occhi, l’ho sentita parlare di un
suo spettacolo, La lupa, un ritorno al teatro a metà degli anni ’60
dopo tanto cinema e tanti premi, fra cui l’Oscar.
Era come ascoltare il sonoro di un film che scorre nella memoria,
scena per scena, lungo una carriera. Alla fine, avrei voluto riavere
quella mano fra le mie per baciarla, gesto galante che già allora non
faceva nessuno e, siccome ero molto giovane, arrossivo al solo
pensiero di essere fuori moda agli occhi della diva poco divina che
avevo appena sfiorato e della piccola folla che ci circondava.
Me ne sono sempre pentito.
Come ogni volta che, assalito dall’ansia o dalla timidezza, anche
tu, spettatore comune, ammutolito per ammirazione, non sai dove
mettere la testa e le mani di fronte alla persona che guarda dritto
negli occhi, capisci che la voglia di esprimere sincerità può persino
soffocarti un poco.
Da quando ho aperto gli occhi al cinema, Anna l’ho
accompagnata strada facendo, come lei ha accompagnato me, e
tutti i suoi spettatori, anno per anno e anche dopo, senza saperlo.
Quando non c’era più, perché la morte se l’era portata via, sono
rimasti i suoi film. Quei film che scavano nel tempo. Ma non si tratta
sempre e solo di Roma città aperta perché Anna non è stata
esclusivamente proprietà di questa pellicola e del suo regista
Roberto Rossellini.
In questo senso, si possono fare scoperte curiose, come è
capitato a me e ai lettori di Le ore, il romanzo di Michael
Cunningham del 1998 che ha ispirato The Hours, il film di Stephen
Daldry con Meryl Streep, Nicole Kidman e Julian Moore.
Cunningham, in uno dei suoi racconti, a un certo punto, parlando di
compere e di abbigliamento, si ricorda della Magnani e cita un
vestitino nero con le stringhe.
Sono andato a cercare questo vestitino e queste stringhe nelle
foto e nei film che ho potuto recuperare. Non ho trovato nulla. Ma, mi
chiedo, posso telefonare e scrivere a Cunningham, Premio Pulitzer,
per chiedergli in quale film ha visto questo abito?
Si può morire di curiosità anche per piccole cose.
Le stringhe di Anna non appartengono però al mondo delle
piccole cose. Sono nella soffitta dove sono conservati tutti quei
segnali che il cinema, specie quello del divismo, ha sparso a piene
mani dai lenzuoli bianchi dello schermo in poco più di un secolo di
vita.
Una prova? Una prova che non riguarda l’attrice di Roma città
aperta?
La fornisce uno scrittore che è stato un grande regista: Pier
Paolo Pasolini. Pasolini scrive in Amado mio, lui omosessuale, di
essere rimasto folgorato da Rita Hayworth e dai suoi lunghi guanti
neri, oltre che «dal suo immenso corpo, il suo sorriso e il suo seno
da fanciulla, da prostituta equivoca e angelica». Anche agli
omosessuali possono piacere le donne, e non lo negano.
Follie! Follie!
Stringhe, lunghi guanti neri; oppure il nastro e il fiocco neri, i
polsini bianchi di pizzo della fidanzata d’America, Mary Pickford,
indossati in occasione del più grandioso dei funerali dedicato al più
famoso divo della storia del cinema, Rudy Valentino. Cerimonie
luttuose per celebrare le stelle del cinema. Follie di amori
Interrotti.
Le pagine di John Dos Passos intitolate «Tango lento» − capitolo
del suo libro Un mucchio di quattrini − descrivono la follia collettiva
intorno alla bara di Rudy. Ma il nero e il bianco delle strisce di stoffa
di Mary, in contrasto con il drappo d’oro posto sulla bara dell’attore
senza tempo, sembrano arrivare dall’aldilà; superando i deliri, gli
svenimenti, le grida dei bambini smarriti durante la cerimonia,
mentre, da oltre Atlantico, da Londra, sui giornali e alla radio giunge
appena attutita la voce di una giovane donna che si è tolta la vita per
l’amore perduto, per un divo sceso a baciarla dallo schermo senza
toccarla.
Le strisce di stoffa della fidanzata d’America, il drappo d’oro sulla
bara, sono le reliquie di una festa di morte che Dos Passos colloca
nell’Olimpo del cinema.
Il
catalogo delle piccole cose – il reliquiario del cinema – è
infinito, lacunoso e sempre incompleto. Malgrado ciò, anzi proprio
per questa sensazione di smarrimento, ci infilano le mani
Cunningham, Pasolini, Dos Passos, e tutti coloro che cercano di
capire il cinema e soprattutto i divi, sinuose anguille misteriose,
sublimi e sfuggenti nel mare profondo della celluloide.
Molti tentano di spiegare i divi e il divismo. Ieri e oggi. Edgar
Morin, uno dei più autorevoli studiosi di questi temi, ha scritto da
sociologo impassibile che i divi invadono tutto: prodotti di toletta,
pomate, frigoriferi, concorsi di bellezza, competizioni sportive, fiere
del libro, feste di beneficenza. In più, oggi che domina la TV, i nuovi
divi delle soap finiscono nelle pubblicità dei pannolini e dei rotoli che
non finiscono mai. Sorridono. Si può parlare di circolo virtuoso.
Dal canto suo, Leonardo Sciascia ricordava che ieri gli spettatori
scrivevano ai giornali per avere notizie, responsi grafologici e
astrologici, indirizzi dei loro beniamini, in un instancabile esercizio di
morbosa curiosità che continua, anzi aumenta. I media
incrementano la folla solitaria.
Oggi, in tempi di dominio, altri spettatori pedinano con costanza
le veline di Striscia la notizia o gli eroi e le eroine del Grande fratello
per copiarne lo stile, e fare la fila ai provini per prendere il loro posto.
Di quale fiamma paurosa vampeggi tu, stella del Nord?
Ieri, Sciascia citava uno scrittore degli anni ’30, Marco Ramperti,
che per risolvere il mistero dell’Olimpo scatenava una focosa
scrittura mitologizzante. Ecco, ad esempio, come descriveva Greta
Garbo: «Iside velata; Iside trasfigurabile; Iside nota e ignota, nei suoi
volti cangianti per ogni luna. La Garbo: l’Arcimaga!»; oppure, come
interrogava Marlene Dietrich: «Di che luce, di che fiamma paurosa
vampeggi tu, stella del Nord?». Oggi, la penna pungente di Guido
Ceronetti così scrive di Marilyn Monroe: «La sua vita, pur essendo
straordinaria, è poco interessante […]. Dopo Giungla d’asfalto non
era che un cadavere congelato, fatto camminare con tecniche di
rianimazione irresistibili per far piovere denaro sul tendone del
circo». E sempre oggi, grazie alla vittoria del piccolo sul grande
schermo, le pseudo dive e gli pseudo divi catodici della
contemporaneità risultano congelati nel gossip e in un perenne, vano
«saremo famosi».
E Anna?
La Magnani è la più svelta, flessuosa anguilla fra le anguille.
Appartiene al cinema della leggenda, quello che è durato fino agli
anni ’70. Lo stesso che Gore Vidal in Remotamente su questi
schermi ritiene un Rinascimento del gusto e della fantasia.
Anna appartiene al cinema della realtà, quello che l’ha resa
famosa nel mondo e l’ha chiusa in un’icona dalle stringhe strette
come le sbarre in una prigione di successo dalla memoria corta.
Anna è il prodotto di tante immagini che risentono in modo quasi
opprimente del tempo in cui l’attrice ha vissuto.
Il rischio rimane. L’idolatria del passato è caduta come le teste
dei dittatori del ’900 e le industrie dei sogni sono altrettante fabbriche
di divi in cui lavora a pieno ritmo una sorta di catena di montaggio
della banalità e del sorriso forzato. L’aura che circondava gli attori e i
loro segreti si è dissolta. Persino la cronaca nera del vecchio
cinema, narrata da Kenneth Anger in Hollywood Babilonia, con i suoi
delitti, la droga, la follia, il sesso e la depravazione, si è arresa,
sconfitta, superata, dimenticata.
La nuova Babilonia spalanca le sue porte da dove entrano ed
escono atleti dell’intrattenimento banale, propagandati dai media in
cui lo spettatore a casa, davanti alla TV, si riconosce come
semplicemente nella media.
Anna e i suoi film, che tornano insieme a caso nella galassia dei
palinsesti televisivi, si oppongono. Sono i sovversivi della durata e
della scienza del poi. Merito dello sguardo dritto dell’attrice e della
sua incapacità di dire il falso, anche quando vorrebbe farlo lei stessa
o glielo imporrebbe il copione.
Ci sono attrici, nella storia, che hanno fondato l’intera loro arte sul
semplice principio per cui non si deve «essere naturali» ma soltanto
«sembrare naturali»: una disposizione alla finzione talmente
interiorizzata da estendersi anche alla vita reale, interponendo uno
spesso diaframma fra l’attrice e l’autenticità dei suoi sentimenti e
delle sue emozioni.
La Magnani non appartiene né al partito dell’«essere naturali» né
a quello del «sembrare naturali». La Magnani non può essere
pirandellianamente «uno, nessuno e centomila» – come ad esempio
lo è la protagonista di La diva Julia, proibita, inafferrabile di
Somerset Maugham. Non si allinea in una serie cangiante di
immagini di sé che le conferiscono un severo controllo mentale su sé
stessa, sugli altri, sul mondo. Mente e nervi di Anna non
trasgrediscono le voci di dentro, le «sue» voci.
Anna è Anna, qualunque cosa faccia: occhi puntati, senza
ombre; bocca che non ha né paure, né reticenze. Anna recita Anna.
E recitare diventa il piacere di vincere i fantasmi e i sonnambuli di
tutti i giorni.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :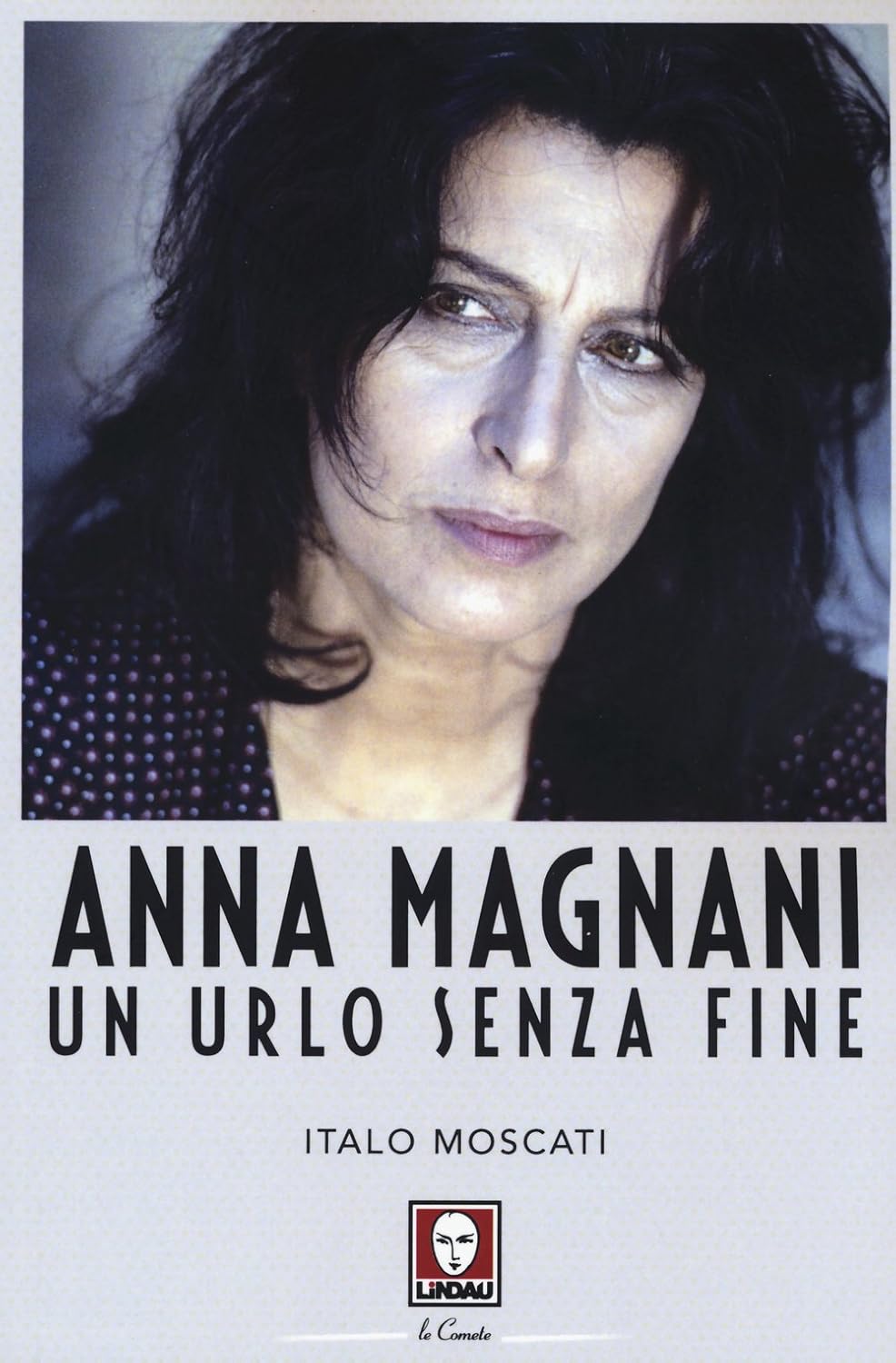






Commento all'articolo