Andando e stando – Sibilla Aleramo
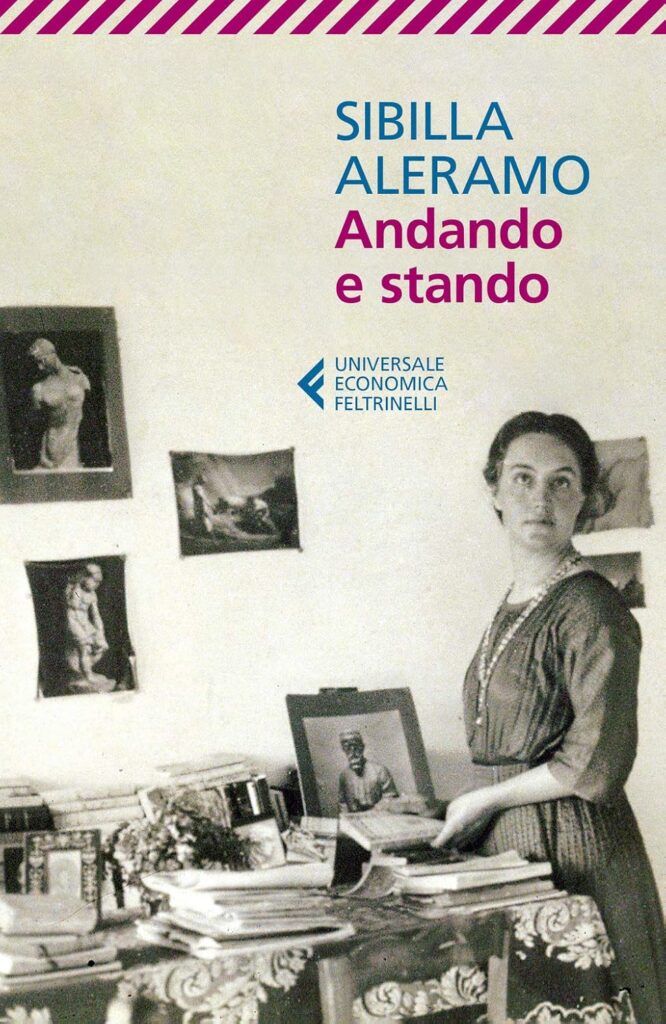
SINTESI DEL LIBRO:
L’invito dell’unione culturale mi ha commossa. Parlare a Torino ha
per me un significato speciale. I miei genitori erano torinesi, di
vecchie famiglie borghesi di qui, e sebbene io sia nata ad
Alessandria1 dove mio padre insegnava allora scienze, e dove non
vissi che qualche mese, ho sempre considerata Torino come mia
patria. Ma anche a Torino non ho mai vissuto. Ho passato la
fanciullezza a Milano, poi l’adolescenza e la prima giovinezza nelle
Marche. Fino ai miei dieci anni però in casa si parlò piemontese.
Sicché quando ora qualcuno mi dice che il mio accento è di quassù,
ne sono singolarmente lusingata, anche se chi me lo dice è un
toscano con una punta di cortese ironia. Lungi da me ogni
pregiudizio razziale. Tuttavia sono fiera della mia origine, fiera dei
tratti di carattere che eran quelli specialmente di mio padre, al quale
molto debbo della mia prima formazione. Questa fedeltà “regionale”
è del resto una specifica italiana, per ragioni storiche che tutti
sappiamo, non è vero? Quando, a grandi intervalli, io errabonda mi
trovo a passare per questa città, magari per pochi giorni, i ricordi mi
assalgono, così vivi e freschi, anche ora che ho sulle spalle ben
quindici lustri, già!
Ma ho detto che ho vissuto a Milano la mia fanciullezza, dai
cinque ai dodici anni, e là ho fatto le scuole elementari – le uniche
scuole ch’io ho frequentate. Così ho localizzato i miei sentimenti di
affetto patrio fra le due regioni, quella d’origine e quella dove ho
incominciato a prendere coscienza di me e della vita. Coscienza,
ecco. Se vi dico che a questa parola si riallaccia proprio uno dei
primissimi istanti di cui serbo lucida la rimembranza, forse vi parrà
una invenzione della fantasia posteriore: ma no: fu proprio un
mattino che camminavo a fianco della domestica, avviata alla
scuola; dovevo avere poco più di sei anni, e io mi fermai di colpo
chiedendo pensosa a me stessa quale fosse il significato preciso del
vocabolo coscienza, udito o letto probabilmente il giorno prima,
chissà come. Rivedo nitida la luce primaverile che mi circondava, e
la
strada tranquilla, e la domestica che mi scuoteva perché
riprendessi il cammino, che si faceva tardi. Non risolsi il quesito, né
allora né dopo. Ma il fatto dell’essersi fissato nella mia psiche
infantile quel momento interrogativo, quella confusa e pur sottile
curiosità intellettiva e, sì, anche morale, in una specie di prescienza
dei valori dello spirito, mi ha sempre, rievocandolo, stupita e
intenerita. Non ch’io fossi una bambina prodigio. Le maestre
dicevano è vero, ai miei genitori che ero molto intelligente, e anche
questa definizione mi sorprendeva, non riuscivo a trovarle un preciso
senso, a me pareva di essere assolutamente uguale alle mie
condiscepole, e se amavo la lettura e lo studio, mi piaceva del pari
giocare, saltare, e magari fare la prepotente, io primogenita, coi miei
minori. “La mia fanciullezza fu libera e gagliarda”, è la frase che
inizia il mio primo libro, Una donna, pubblicato quand’io compivo i
trent’anni.2 Cara fanciullezza, cara Milano di allora, per la quale
sentii tanta nostalgia nel selvaggio borgo marchigiano dove venni
trapiantata, dove non potei proseguire gli studi, e dove, sedicenne,
mi sposai...
Ma il tema che stasera mi è dato è: Esperienze d’una scrittrice. E
scrittrice divenni più tardi. Da piccola, ripeto, non mi riconoscevo
nulla di speciale: mi pare che verso i dodici anni componessi una
commediola per i nostri burattini, ma non ne ricordo nulla: e creassi
un giornaletto tutto ricopiato a mano, tiratura d’una decina di copie,
in collaborazione con una sorella e un fratello: titolo, Il Micino
grazioso: ma durò pochi numeri, e se ne è salvato uno solo, che
talora riprendo in mano con tremore. V’è un saluto “all’autunno che
s’avvicina”. Bimba, bimba, che immaginava di sapere che cos’è
l’autunno!
Era ancora un modo di giocare.
Vedete, è con qualche esitanza che m’avvicino all’argomento
datomi dal bravo presidente Antonicelli.
Una scrittrice esiste – quando esiste – nei suoi libri. In specie se è
autobiografica, come io sono stata definita perfino quando ho scritto
in terza persona. È vero che rimane sempre un alone un po’
misterioso attorno ad un’opera, alone che il pubblico ha spesso la
curiosità di penetrare: fatto di circostanze magari casuali, di incontri,
più o meno importanti, di date talora remote dei primi embrioni. Ed è
anche vero che un tale alone, diciamo, più realisticamente, tale
zona, è per l’autore stesso qualche volta insondabile...
Ad esempio, io ho visto saltar fuori, tempo fa, dai miei vecchi
manoscritti, alcune paginette conservate in una busta con
l’indicazione: “Nucleo ideologico di Una donna”.3 L’indicazione è
molto posteriore alla sera in cui buttai giù lagrimando quelle
paginette, sera del 1901, senza immaginare neppure lontanamente
che avrei scritto un giorno un libro, tanto meno quel libro. Una
donna, io lo incominciai nell’estate 1902, quando dal litorale adriatico
m’ero trasferita a Roma. Esattamente mezzo secolo fa. Fu il poeta
Giovanni Cena, che mi incitò a non disperdere la mia forza in
articoletti, e a tentar invece di concentrarla nel racconto della prima
fase della mia esistenza. Ma le “paginette” di cui vi ho parlato, egli
non le conosceva, né io le avevo mai rilette, tuttavia s’inserirono
nell’ultima parte del romanzo, al momento esatto, nella seconda o
terza stesura, non ricordo bene, quando le rintracciai per attestare
meglio a me stessa lo stato spirituale che aveva condotto
l’innominata protagonista del libro a lasciare la casa coniugale e il
figlioletto.
Fu da Torino che giunse il primo riconoscimento autorevole a quel
primo libro della scrittrice fino allora ignota. Fu Arturo Graf, che gli
dedicò, nel novembre 1906, un articolo nella “Nuova Antologia”.
Arturo Graf, che alcuni di voi ricordano maestro insigne, e ch’io vidi
solo una volta, ma del quale non ho mai dimenticato l’austera e
nobile immagine. Il libro mi valse l’amicizia fraterna di un altro eletto
spirito della nostra terra, il filosofo Annibale Pastore, tuttora mirabile
di attività e fervore. E quelle di Pellizza da Volpedo e di Leonardo
Bistolfi e di Anton Maria Mucchi. Eran tutti presenti, salvo Pellizza
purtroppo già scomparso, alla conferenza che nel 1909 tenni qui, mi
pare al Circolo della Stampa, sulle scuole dell’Agro romano.
I ricordi! Ci assalgono improvvisi, inattesi, come ritornelli musicali
obliati, dolci o strazianti. Una delle mie più recenti poesie rievoca
una mia ascensione a piedi da Aosta al Gran San Bernardo, con mio
padre, quando avevo dieci anni. Ma singolare è il fatto che il
richiamo, a tanta distanza, di quella mia infantile bravura, io l’abbia
avuto, del tutto imprevedibile, per dichiarare che se dovessi ritornare
oggi ad Aosta
sarebbe con lo sguardo limpido della bimba
che balda viveva la prima sua sera felice,
ch’io ormai fisa ho l’anima soltanto
in giorni in cui per tutti credo,
in un’era per sempre giusta di opere e luce,
che innumeri fratelli su la vasta terra
con rocciosa volontà preparano– e la volontà ci salda ci solleva ci alimenta
e tu, Aosta cara, nel cerchio incantato
delle tue mura auguste e delle tue montagne
sorridere fiera mi vedresti e sicura
come nell’alba mia augurale
ora nella sera di mia vita come allora.4
Ed ecco, con un altro balzo inatteso nel passato, adesso mi vien
fatto di rievocare per voi una delle esperienze più importanti della
mia vita. Avevo allora terminato il mio primo libro, che però uscì
soltanto due anni dopo. Non portavo ancora nemmeno il nome che
di poi ho assunto. Vivevo con Giovanni Cena. E un giorno, s’era nel
1904, fui tratta da Anna Celli, una giovane tedesca moglie del
grande scienziato malariologo,5 a fare con lei e col professore una
corsa nella Campagna romana.
Permettete che di quella remota gita vi legga il racconto che feci
la sera stessa a Giovanni Cena e che quarant’anni dopo riferii nel
volume Dal mio diario:
“M’hanno condotta a Lunghezza, presso Tivoli. La Celli m’ha
detto: ‘voglio che lei veda’. Sai, è già un mese che me ne aveva
parlato, a quella seduta dell’Unione femminile: forse aveva capito
che ascoltavo con più interesse delle altre. Bisogna che anche tu
veda, Giovanni, che anche tu veda. A due passi da Roma! Capanne
di paglia, come cumuli di strame. In capanne vivono, senza
pavimento, sembrano anche loro di fango, guardano attoniti, bimbi,
vecchi, le capanne stanno fuor di ogni strada, vi si va per un
sentiero, a piedi, è una specie di villaggio, tre, quattrocento persone,
e dicono i Celli che ve ne sono tanti altri sparsi così nella campagna,
tutti
intorno a Roma, e più giù, sino alle Paludi pontine,
aggruppamenti di veri tukul, abbandonati, senza medico, senza
scuola, e mi guardavano come se veramente fossi capitata in Africa,
scendono dalla Sabina, dalla Ciociaria e dagli Abruzzi, tornano al
loro paese soltanto da luglio a settembre, quando la malaria
infierisce più acuta. Il terreno appartiene a un principe. Li chiamano
guitti. Oggi c’era il sole. Ma quando piove, come possono vivere lì;
come?
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :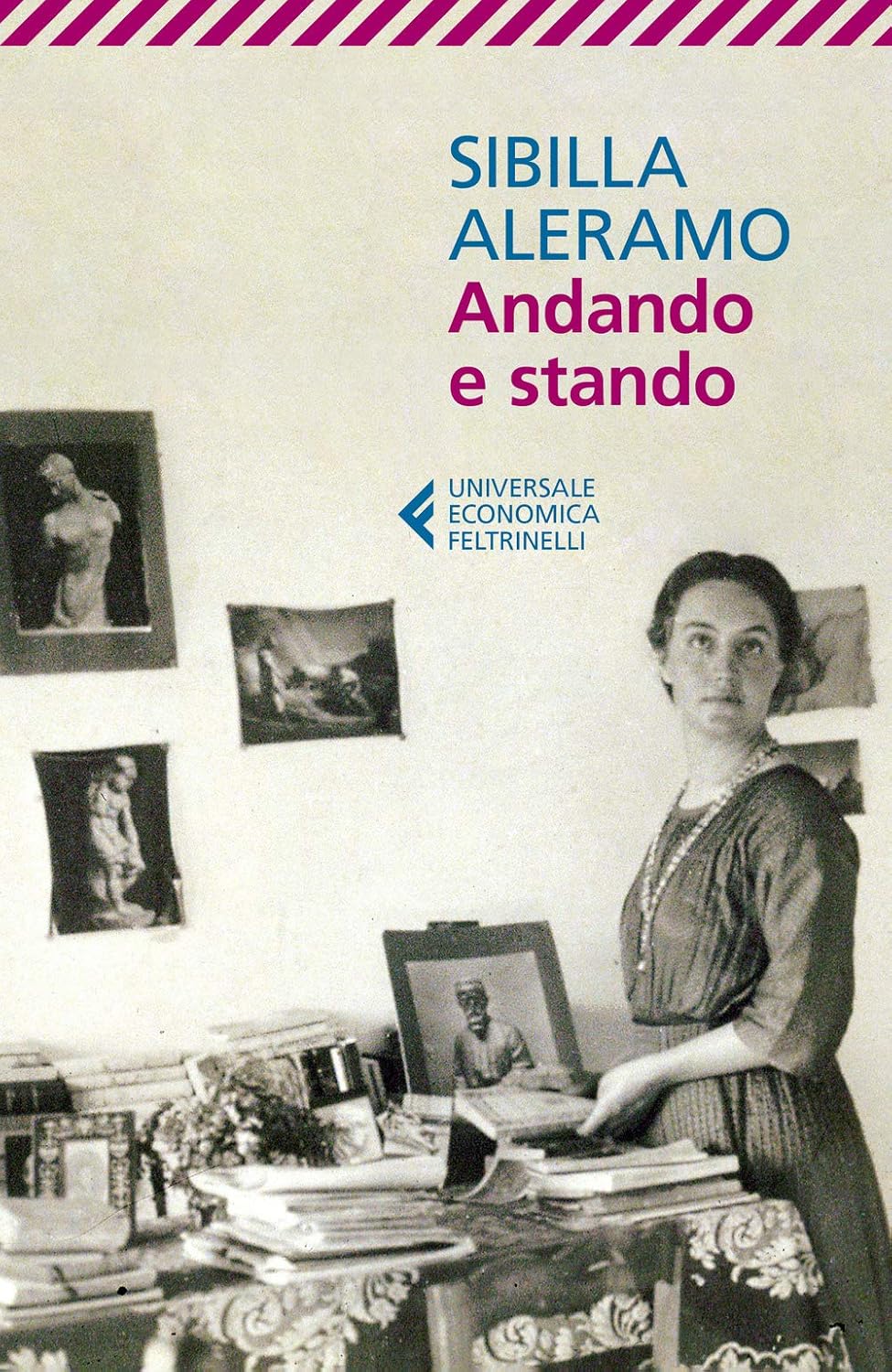






Commento all'articolo