Americana – Libri, autori e storie dell’America contemporanea – Luca Briasco
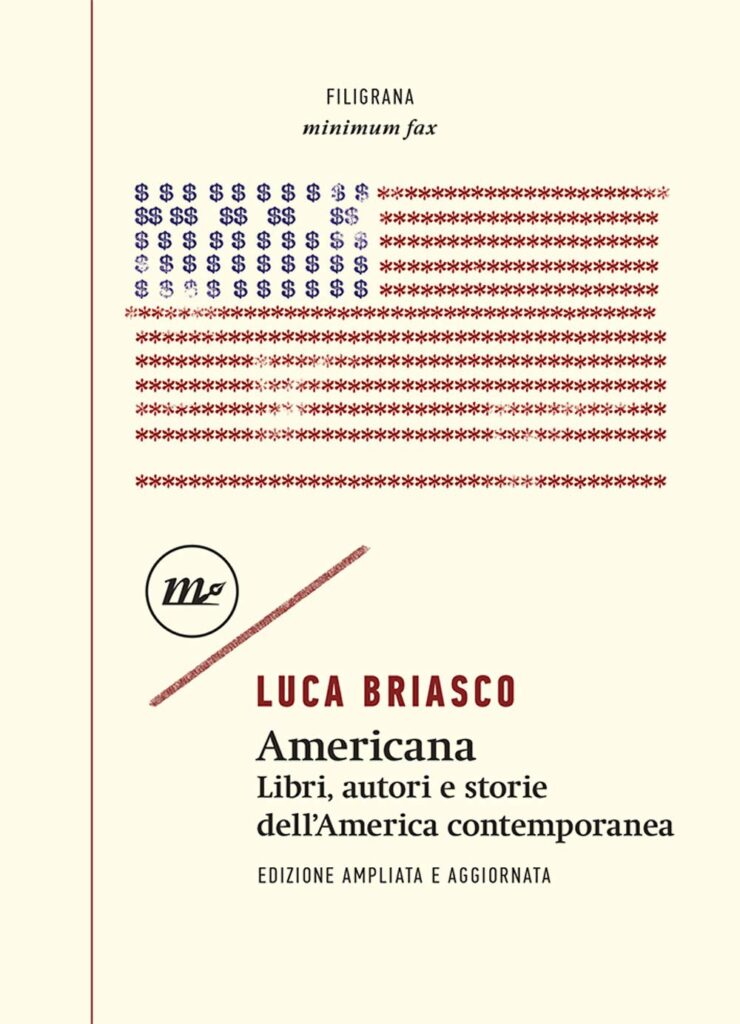
SINTESI DEL LIBRO:
Nato nel 1930 a Cambridge, nel Maryland, John Barth ha superato
gli ottantacinque anni, e continua instancabilmente a scrivere
racconti e romanzi, indifferente a una canonizzazione critica ormai
consolidata che ne ha fatto il campione indiscusso della narrativa
postmoderna e gli ha riservato un posto d’onore nelle storie e nelle
antologie letterarie. In Italia, dopo aver goduto di una certa popolarità
tra il 1968 e il 1976, con la pubblicazione dei suoi primi quattro
romanzi e della sua prima raccolta di racconti, era caduto nel
dimenticatoio, insieme a molti dei suoi compagni di avventura, da
Donald Barthelme a William H. Gass. È tornato con prepotenza
all’attenzione dei lettori grazie a minimum fax che, dopo aver
riproposto i due libri con i quali aveva esordito negli anni Cinquanta
(L’opera galleggiante, ristampato nella collana I Quindici, e La fine
della strada), pubblica, con il titolo La vita è un’altra storia, una
silloge dei suoi migliori racconti, scelti dall’autore appositamente per
l’edizione italiana e corredati da una prefazione firmata dallo stesso
Barth e da apparati critici sintetici quanto efficaci.
La fama di Barth come maestro del postmoderno rimane
effettivamente legata, in ampia misura, alla sua produzione breve.
Se infatti romanzi come Il coltivatore del Maryland mostravano già
quella propensione al pastiche e alla libera reinvenzione di una
tradizione letteraria che Barth condivide con autori assimilabili alla
sua stessa scuola, da Thomas Pynchon a Robert Coover, sono i
racconti, e in particolare le due raccolte pubblicate nel 1968 e nel
1972, La casa dell’allegria e Chimera, a segnare il punto di svolta
della sua carriera. Insieme al dittico di saggi La letteratura
dell’esaurimento e La letteratura della pienezza, i racconti scritti a
cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta inaugurano la stagione
della cosiddetta metafiction, ossia di quella narrativa nella quale la
riflessione sull’atto del narrare e sulle sue possibilità e biforcazioni, il
rifiuto della narrazione lineare, l’invenzione di una nuova tradizione
letteraria, nella quale Beckett, Borges e Nabokov subentrano alla
triade modernista Proust-Joyce-Mann, creano un nuovo paesaggio e
una nuova modalità di racconto.
Esaurimento e pienezza sono rispettivamente il punto di
partenza e il traguardo finale, nei racconti di Barth come in quelli di
Barthelme, o nel memorabile La babysitter di Coover; o ancora nelle
Cosmicomiche, nel Castello dei destini incrociati e in Se una notte
d’inverno un viaggiatore di Calvino, salutati in Italia come miracoli
creativi, e che molto devono invece a modelli americani non sempre
dichiarati. In estrema sintesi, l’esaurimento progressivo delle forme
narrative e la sostanziale impossibilità di inventarne di nuove diventa
un’occasione a suo modo unica e preziosa, perché apre lo spazio al
gioco dell’intelligenza, alla libera combinazione di stili e moduli, a
una fusione esaltante di narrazione, digressione, pausa riflessiva.
Più ancora che a una pienezza ormai impossibile, il termine
replenishment utilizzato da Barth allude a una nuova arte
combinatoria, alla costruzione di labirinti e case stregate nelle quali
la malinconia della fine si trasforma progressivamente nel trionfo di
un’inventiva tutta al quadrato, nell’apoteosi della citazione e della
rielaborazione.
Un progetto narrativo, quello di Barth, che parte in realtà dagli
anni Cinquanta, e che ha stentato non poco ad affermarsi in un
contesto nel quale a dettare legge erano il realismo esistenzialista
dei Mailer e dei Bellow, o il simbolismo di matrice modernista e
faulkneriana di Ralph Ellison. Prova ne sia la vicenda editoriale del
suo primo romanzo, L’opera galleggiante, che pur nel quadro di
un’ambientazione sostanzialmente realistica – il resoconto di una
giornata del 1937 nella quale il protagonista, Todd Andrews,
avvocato di successo, decide di suicidarsi ma finisce per cambiare
idea – cominciava a praticare quell’arte digressiva e quella disinvolta
mescolanza di stili che costituisce una cifra del postmoderno, e che
sarebbe stata portata a ben altri livelli di invenzione e di
intellettualistica raffinatezza nelle opere degli anni Sessanta.
Ebbene, all’atto della prima pubblicazione, l’editore impose a Barth
una serie di interventi, tesi soprattutto a espungere alcune delle parti
più sperimentali del libro – tra cui un lungo brano su due colonne
parallele, nel quale il racconto si spezzava tra una prospettiva di
rigorosa osservanza realista e una autoriflessiva e metanarrativa – e
a modificare il finale; solo nel 1967, quando il postmoderno, e in
buona parte per meriti dello stesso Barth, infaticabile propugnatore,
organizzatore e divulgatore della nuova fiction, aveva ormai
acquisito una posizione dominante nel dibattito culturale americano,
L’opera galleggiante poté essere riproposta nella sua versione
originaria.
Se le vicende del primo romanzo di Barth ci aiutano a
comprendere quanto la nuova visione della narrativa e del suo
compito, già molto chiara all’autore prima che la teorizzasse nel
modo più compiuto, faticasse a emergere in un contesto non ancora
maturo, una rilettura a distanza di anni dei primi racconti scelti da
Barth − uno su tutti: «Perso nella casa stregata», tratto dalla sua
prima raccolta − può essere invece un’occasione per verificare la
«tenuta» della narrativa postmoderna, a distanza di quarant’anni, e il
suo influsso innegabile su molti dei migliori scrittori delle ultime
generazioni, da David Foster Wallace a Jonathan Safran Foer, che
sembrano avere assorbito la lezione dei maestri al punto da recarne
le tracce nel proprio DNA. D’altro canto, la lettura di un’antologia che
abbraccia quarant’anni di produzione narrativa induce ad altre
riflessioni, meno ovvie e altrettanto significative. Dietro i prodigiosi
giochi metanarrativi di Barth si staglia infatti una situazione di
partenza che si ripete pressoché identica con il trascorrere dei
decenni. Protagonisti delle sue storie sono i baby-boomers, ossia
quella generazione, nata grosso modo tra il 1945 e il 1960, che, per
usare le parole dello stesso Barth nel bellissimo «Avanti con la
storia», «è, nel complesso, la prima di questo secolo che non supera
quella precedente in statura o salute generale», cosicché «coloro
che ne fanno parte − anche se con parecchie eccezioni −
conseguono, o hanno la sensazione di conseguire, livelli inferiori di
benessere materiale, e forse perfino spirituale». Anche qui, allora, è
legittimo parlare di esaurimento: solo che a esaurirsi sarebbe la
spinta competitiva, anche e prima di tutto generazionale, che ha fatto
da carburante a una nazione e al modello economico adottato
dall’intero Occidente. Le subentra un benessere statico, una felicità
che lascia in bocca un sapore amaro, il desiderio di trovare
comunque spazi dove recuperare il sogno di una creatività e di una
pienezza: si apre la via alla scrittura postmoderna, con i suoi infiniti
strati e livelli capaci di riprodurre in via indiretta la fatica di vivere, ma
anche di sublimarla in un cocktail di intelligenza e fantasia. Le coppie
felici ma immobili di tutti questi racconti, i docenti universitari, le
donne divorziate e i figli annoiati appartengono, in fondo, allo stesso
patrimonio umano e sociale frequentato e saccheggiato dai primi
esponenti del minimalismo; alla diagnosi puntuale e al feroce
mimetismo di maestri come Ann Beattie e Grace Paley, Barth
contrappone le infinite biforcazioni e digressioni, le pause, il moto
erratico del pensiero e del racconto. E se a tratti rischia un eccesso
di compiacimento, i prodigi di invenzione che dissemina nelle sue
storie sanno scavalcare i limiti temporali di una pura diagnosi
sociale, conservando, anche a distanza di anni, una invidiabile
freschezza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :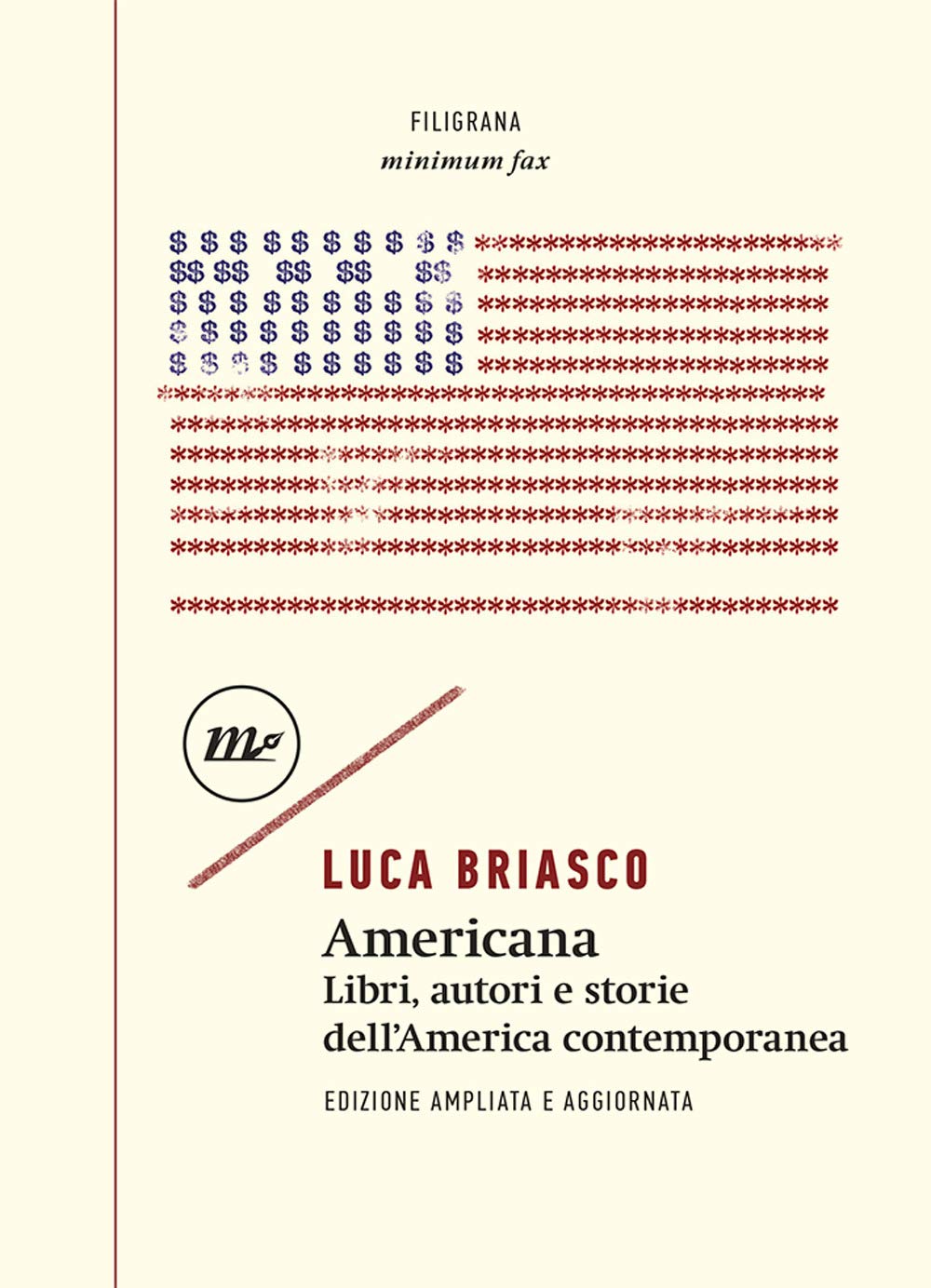






Commento all'articolo