Agostino d’Ippona – Peter Brown
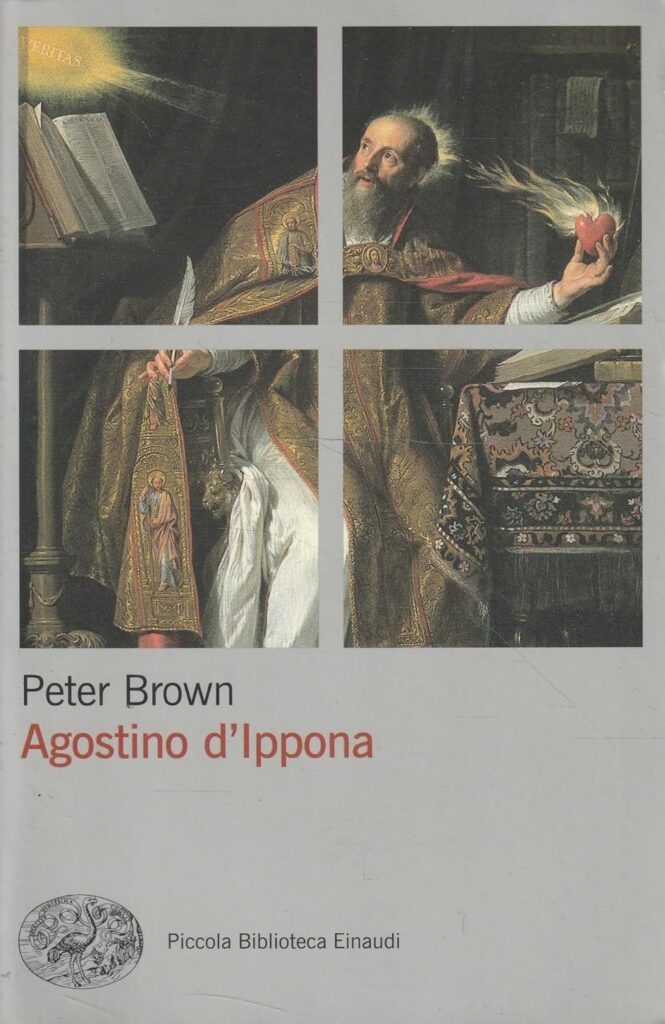
SINTESI DEL LIBRO:
La città di Tagaste (l’odierna Souk-Ahras, in Algeria) esisteva da
trecento anni, quando, nel 354, vi nacque Agostino. Città che aveva,
come i numerosi centri disseminati dai romani nell’Africa
settentrionale, un alto concetto della propria dignità, essa si definiva
«l’illustrissimo» consiglio di Tagaste2.
Un «miracolo economico» aveva trasformato sin dal primo secolo
avanti Cristo l’entroterra dell’Africa settentrionale3. Mai piú la
prosperità si sarebbe estesa tanto concretamente su una superficie
cosí vasta. Nel terzo secolo dopo Cristo le pianure e le valli
dell’altipiano dell’antica Numidia, dove Agostino nacque, erano
coltivate a cereali, attraversate in tutti i sensi da strade e cosparse di
centri abitati. Anche piú a sud, oltre le montagne dell’Aurès, una
catena di fortezze proteggeva la linea di demarcazione tra la zona
coltivata e quella incolta, proprio sull’orlo del Sahara. In quell’epoca
di benessere gli abitanti di Thysdrus, l’attuale El-Djem, avevano
edificato in mezzo all’aperta pianura un anfiteatro che aveva quasi le
dimensioni del Colosseo di Roma. Ma il piú caratteristico documento
di questi anni di prosperità proviene da un’iscrizione di Timgad, una
città molto a sud di Tagaste, situata su quelli che ora sono i desolati
altipiani dell’Algeria meridionale: «La caccia, i bagni, il gioco e il riso:
questa è la vita che fa per me»4.
Nel quarto secolo l’originaria espansione aveva subito una fatale
battuta d’arresto: l’edilizia languiva, i vecchi monumenti pubblici
cominciavano a cadere in rovina; agglomerati di baracche, caotici
come i labirinti dei bazaar di una città araba, si accalcavano intorno
alle strade a scacchiera delle vecchie città romane. La ricchezza
dell’Africa aveva abbandonato i suoi centri originari. Foreste di ulivi
ricoprivano, ora, le colline della Numidia meridionale. In Africa
Agostino poteva lavorare tutta la notte grazie all’abbondanza di olio
grezzo africano con cui poteva alimentare il suo lume: comodità,
questa, di cui avvertirà la mancanza durante il suo soggiorno in
Italia 5. L’olio proveniva da povera gente, da villaggi privi della boria
delle città romane. Questi robusti coltivatori, diffidenti del mondo
esterno, abituati a vivere in comunità ermeticamente chiuse, le cui
usanze erano di poco mutate dai tempi preistorici, erano diventati gli
arbitri della prosperità africana: «Qui giace Dione, uomo devoto;
visse ottant’anni e piantò quattromila alberi»6.
Tagaste, la città di Agostino, era appollaiata su un altipiano ai
margini di questa nuova Africa. Amministrata da Cartagine, aveva
fatto però parte dell’antico regno di Numidia. Quando pensiamo
all’Africa, è all’Africa di Cartagine e della costa mediterranea che
siamo soliti pensare; Agostino invece crebbe a duecento miglia dal
mare e a settecento metri di altitudine, separato dal Mediterraneo da
estese foreste di pini e alte valli di grano e di ulivi. Da bambino
poteva soltanto immaginare il mare guardando dentro un bicchiere
d’acqua7.
Era un mondo di agricoltori. Una città era un simbolo di civiltà,
non era un’unità distinta dalla campagna. Nonostante tutto il loro
orgoglio, queste piccole «Rome» potevano avere tutt’al piú qualche
migliaio di abitanti, che non vivevano sulla terra, proprio come oggi
gli abitanti di un pueblo spagnolo o di una città dell’Italia meridionale.
Era in campagna che coloro che potevano permetterselo
ricercavano i piaceri della vita. Possiamo vedere sui mosaici le
grandi case di campagna dei romani d’Africa: ville a due piani,
circondate da maneggi, da piscine e da boschetti ornamentali di
cipressi. I loro proprietari vi sono raffigurati nelle ampie toghe del
tempo, mentre cacciano a cavallo e ricevono l’omaggio di ossequiosi
contadini. Questi uomini erano i patroni, i «protettori» della loro
comunità, sia in città che in campagna. Quando uno di loro
passeggiava nel foro con il suo largo seguito, era prudente per il
povero alzarsi e inchinarsi profondamente8.
Anche la povertà era intimamente legata alla terra: la miseria
delle «schiene curve», prossima alla morte per inedia, una brutalità
non dissimile da quella della Russia zarista. Dieci anni prima della
nascita di Agostino, la Numidia meridionale era stata teatro di una
rivolta di contadini, permeata – è significativo – di una forma
battagliera di cristianesimo. Membro ragguardevole di una città
romana, Agostino era al riparo da questa miseria. Infatti, come
maestro e piú tardi come vescovo, faceva parte di quell’esigua
categoria di uomini che avevano contatto diretto con la terra: poteva
permettersi addirittura di parlare con nostalgia del giardinaggio, di
considerare l’agricoltura «un salubre esercizio»9. Negli ultimi anni,
inchiodato alla sua scrivania, non gli rimaneva altro che rifugiarsi nei
lontani ricordi di lunghe giornate trascorse vagando per questa
campagna a caccia di uccelli10.
Per poter essere membro effettivo di una città romana, Agostino
doveva essere un uomo libero e civile: non era necessario che fosse
ricco. Il padre, Patrizio, era un uomo povero, un tenuis municeps, un
cittadino di scarsi mezzi11; Agostino crescerà in un mondo irto di
difficoltà e di rivalità, tra una piccola nobiltà terriera orgogliosa e
impoverita. Per i suoi membri una delle sole vie al successo era
l’educazione classica; e Agostino per poco non perse anche questa.
Sulla sua infanzia graverà l’ombra dei sacrifici fatti dal padre per
dargli questa educazione indispensabile: Patrizio e la sua famiglia
erano costretti a vestirsi miseramente12; con difficoltà riusciva a
racimolare denaro. Durante un anno disastroso Agostino fu costretto
a rinunciare ai suoi studi nella piacevole «città universitaria» di
Madaura (o Madauros, l’odierna Mdaourouch) e a inselvatichirsi
vagabondando nella rozza Tagaste13. Meno fortunati furono i suoi
cugini: rimasti privi di un’adeguata educazione14, dovettero affrontare
la povertà e la noia di un angusto mondo di piccoli proprietari
illetterati.
Patrizio, comunque, forse grazie a vincoli di parentela, poté
rivendicare la protezione di un’alta personalità locale, Romaniano15.
Romaniano si recava spesso in Italia per difendere la sua proprietà
alla corte imperiale. Ritornava a Tagaste per far mostra della sua
potenza, organizzando spettacoli di bestie feroci e offrendo la sua
protezione a giovani come Agostino. I suoi concittadini gli
indirizzavano discorsi e innalzavano statue in suo onore;
dall’imperatore poteva aspettarsi onori e uffici nell’amministrazione16.
Nel mondo assai fluttuante del quarto secolo, fortuna e talento
potevano colmare l’abisso che separava un Patrizio da un
Romaniano. Nel 385 Agostino sarà professore di retorica a Milano;
avrà raggiunto una posizione tale da poter accarezzare la
prospettiva di un matrimonio con una ricca ereditiera e quella di un
governatorato in provincia17. Poté allora aver pensato, come un altro
fortunato africano del suo tempo: «Sono cresciuto in campagna,
figlio di un padre povero e privo di istruzione; grazie allo studio
incessante delle buone lettere, mi è ora possibile condurre la vita dei
nobili»18.
Uomini come Patrizio e Romaniano, infatti, non si consideravano
a torto «romani». È molto improbabile che Agostino si esprimesse
altrimenti che in latino. L’incommensurabile abisso qualitativo che
divide
la
civiltà
dalla
sua assenza separava la cultura
esclusivamente latina, in cui Agostino era stato educato con tanto
successo, da qualsiasi tradizione indigena preesistente. Ciò che non
era romano in Africa, non poteva essere concepito da un tal uomo
se non in termini romani. Agostino adopererà il termine «punico» per
descrivere i dialetti indigeni, i soli in cui la maggior parte dei
contadini sapessero esprimersi e che molti abitanti delle città
parlavano accanto al latino. Ciò non perché quegli uomini parlassero
la lingua degli antichi cartaginesi, ma piuttosto perché Agostino, per
la sua cultura, applicava istintivamente questo termine tradizionale e
indeterminato a qualsiasi idioma dell’Africa settentrionale diverso dal
latino19.
Tuttavia, anche l’africano completamente latinizzato del quarto
secolo era pur sempre in qualche misura uno straniero. L’opinione
fuori dell’Africa era unanime: gli africani non erano in grado di
avvalersi di quanto l’Africa offriva loro20.
la
Nel secondo e terzo secolo, nei giorni della loro spavalda
prosperità,
cultura
romana aveva preso un indirizzo
significativamente diverso nelle loro mani. Sono uomini che ci
sorprendono per il loro gusto «barocco» piú che classico21: l’africano
dotato, ad esempio, si dilettava del puro gioco di parole, dei bisticci,
delle rime e degli indovinelli. Agostino, divenuto vescovo, riscuoterà
un’ammirazione enorme dai suoi fedeli per la superba abilità nello
sfoggiare fuochi d’artificio verbali22. Un uomo siffatto aveva bisogno
della controversia, prosperava nell’apologia. Mirava a colpire i suoi
compagni con giri di frase eccentrici, con vivaci ed astruse metafore.
Questo fuoco tipicamente africano arderà ancora vigorosamente
nell’ormai settantenne Agostino: uno dei suoi oppositori sembrava
avergli accordato un punto, solo per uscire d’imbarazzo, ed egli:
«Ecco, perfino il vostro inchiostro sembra sia arrossito»23. I mosaici
commissionati da questi uomini erano luminosi, pieni di particolari
della vita quotidiana osservati minuziosamente, un po’ grotteschi24.
Uomini come questi erano in grado di scrivere romanzi: un occhio
infallibile nel cogliere il particolare e il picaresco, interesse verso i
moti del cuore hanno fatto sí che i due unici libri della letteratura
latina che l’uomo moderno possa agevolmente porre accanto alla
narrativa odierna – l’Asino d’oro di Apuleio e... le Confessioni di
Agostino – siano stati scritti da africani. Agostino era stato
incoraggiato a versare nobili lacrime sulla storia di Didone e Enea
(parentesi tipicamente africana nella vita dell’integerrimo fondatore di
Roma25); e sarà un poeta africano a rettificare le omissioni di Virgilio,
scrivendo le lettere d’amore della regina abbandonata26.
I grandi scrittori africani furono tuttavia rapide meteore. L’africano
medio era piú noto come avvocato. Agostino sarebbe potuto
diventarlo: «È una gran cosa possedere un’eloquenza efficacissima,
avere clienti sospesi ad ogni parola del ben tornito discorso del loro
patrono, che appuntano le loro speranze sulle sue labbra...»27.
Come i litigiosi signori di campagna dell’epoca elisabettiana, in Africa
il «buon agricoltore» doveva essere anche «esperto di diritto»28; e,
come tra gli elisabettiani, un legalismo arido e feroce, un
appassionato dedicarsi al maneggio degli affari pubblici attraverso
l’argomentare nei tribunali, era un efficace compenso per molti alla
fantasia e alla sensibilità che erano, invece, appannaggio di pochi.
Esattamente nello stesso periodo, i capi della Chiesa cristiana in
Africa avevano introdotto nelle loro controversie questo legalismo
sviluppatosi cosí vigorosamente. Una cultura giuridica testarda e
inesorabile aveva proliferato nel nuovo ambiente clericale. Per un
vescovo italiano che lo conosceva bene e che detestava
profondamente la sua teologia, Agostino non era altro che l’ultimo
esponente di un tipo fin troppo conosciuto, il poenus orator, il giurista
africano29.
Agostino decise, tuttavia, che avrebbe preferito diventare maestro
di scuola. Anche in ciò gli africani avevano dimostrato una loro
caratteristica predilezione. Avevano un vero e proprio culto
dell’educazione: uomini rozzi coprivano le loro tombe di iscrizioni in
brutti versi; il nipote di un soldato mauro si vantava di essere ora «un
maestro di lettere romane»; un altro si qualificava «il Cicerone» della
sua piccola città. In Africa l’istruzione romana aveva rappresentato
una posizione per una moltitudine di gente modesta, creando
un’atmosfera ostile al talento genuino. In Aquitania e in Alto Egitto il
quarto ed il quinto secolo erano stati contrassegnati da improvvise
«esplosioni» di genio letterario30. In Africa invece la polvere
dell’erudizione si era pesantemente depositata su innumerevoli testi
classici, scritti da maestri africani31. Questi uomini sapevano
pronunciare correttamente homo32; l’uno scriveva un libro sulle
Nozze di Mercurio e della Filologia; l’altro dimostrava la propria
superiorità su Agostino rimproverandolo di scrivere «donatista»
invece di «donatiano», come scriveva l’uomo istruito33. Le
sovrabbondanti energie del secondo e del terzo secolo avevano in
certo qual modo subito una battuta d’arresto: l’Africa del quarto
secolo era diventata un ricco e stagnante acquitrino34.
A Tagaste almeno, nella prima giovinezza questi figli di ostinati e
impoveriti piccoli proprietari terrieri si stringevano l’uno all’altro nella
comune ricerca di un’ascesa. Dietro la biografia individuale di
Agostino possiamo scorgere questa «biografia collettiva» – i destini
di un ragguardevole gruppo di giovani decisi a sfuggire l’inerzia di
una piccola città africana. Molti di questi amici avrebbero conservato
stretti legami per tutta la vita; la combriccola di seri studenti sarebbe
diventata, nella mezza età, un gruppo formidabile di vescovi che
avrebbe controllato le sorti della Chiesa cattolica in Africa.
Dulcissimus concivis, carissimo amico e concittadino35: questa frase
adoperata dal vescovo Agostino introdurrà l’antico linguaggio della
vita pubblica romana nel nuovo mondo della gerarchia cattolica.
Questi vecchi schemi, tuttavia, non riuscivano piú a soddisfare gli
uomini della generazione di Agostino. Il ricco proprietario terriero, lo
studente avventuroso, il vescovo causidico sentivano ancora il
bisogno di «imbarcarsi» di tanto in tanto verso l’Italia: il navigare è
un tema costante nell’opera di Agostino36. Non vi avrebbero però
trovato una cosí facile soddisfazione delle proprie ambizioni. Tutti i
giovani ambiziosi di Tagaste torneranno a trascorrere il resto della
vita in un ambiente del tutto provinciale, come vescovi di piccole città
africane. Gli imperatori non avevano bisogno dei servizi di questi
meridionali: dovevano difendere una frontiera settentrionale
minacciata; la loro corte si spostava con gli eserciti tra la Gallia,
l’Italia settentrionale e le province danubiane. L’Africa, per loro, non
rappresentava altro che una fonte sicura di imposte, il granaio
pesantemente sfruttato di Roma. Gli uomini di Tagaste, Romaniano
e la sua piccola frotta di clienti, si trovarono ad essere degli
indesiderati: come gli anglo-irlandesi della fine del diciottesimo
secolo, questi rappresentanti di una società altamente civilizzata e
prospera si videro condannati ad assistere alla riduzione del loro
paese al rango di mera «colonia», amministrata da stranieri
d’oltremare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :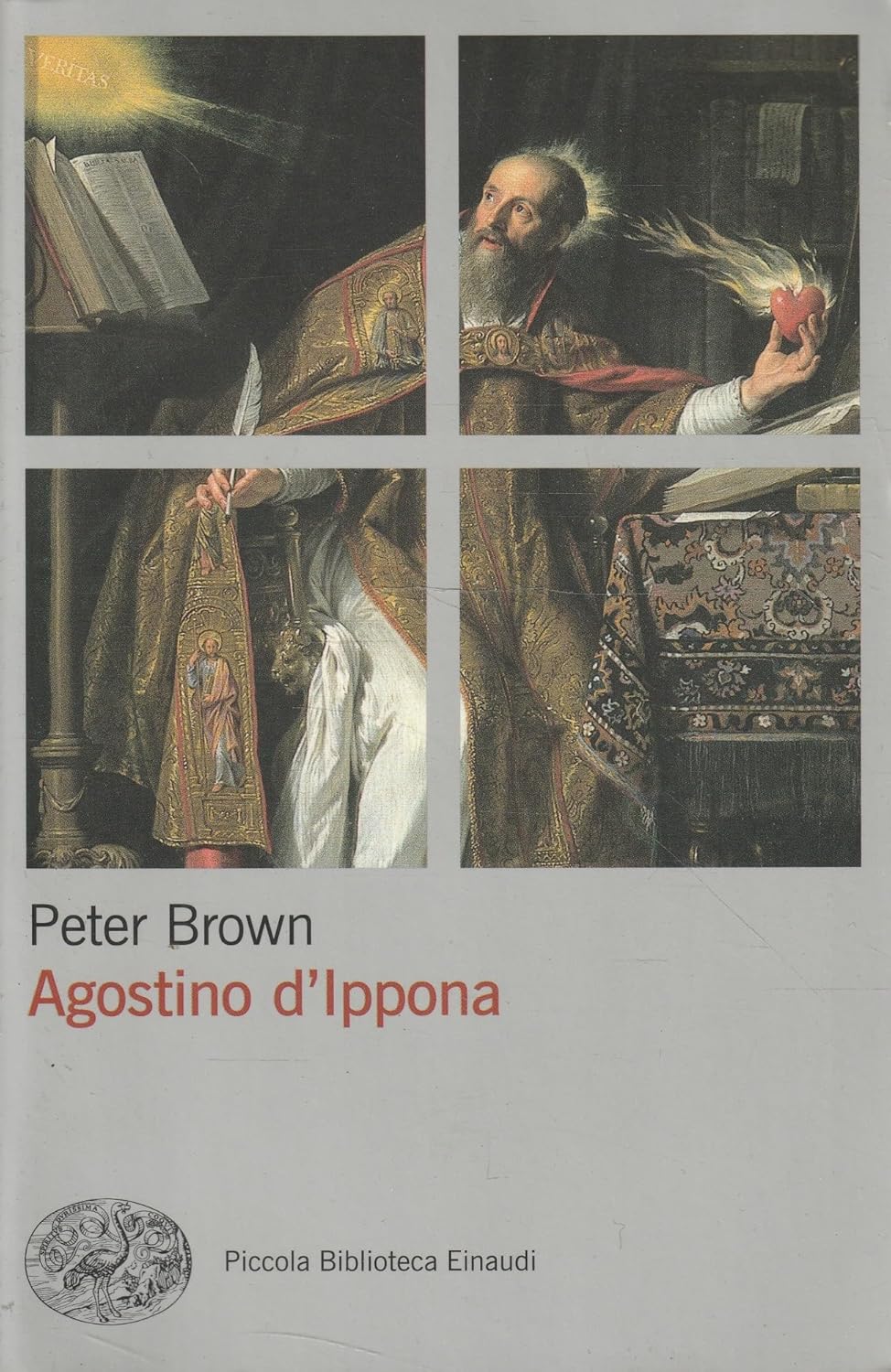






Commento all'articolo