Yoga per adolescenti – Semplici esercizi per crescere in armonia – Lorena Valentina Pajalunga
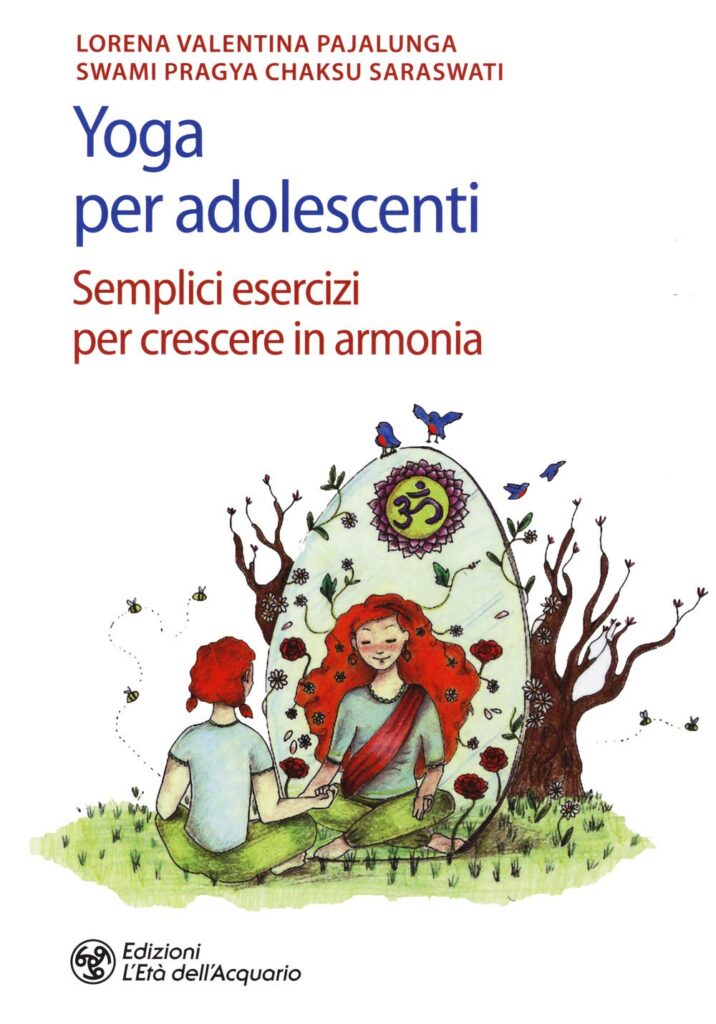
SINTESI DEL LIBRO:
Da un errore all’altro
Nella società tradizionale del secolo scorso un ragazzo cresceva
imparando molto presto a rinunciare ai propri desideri e ai propri
sogni. La famiglia e la società, infatti, erano sessuofobiche e
autoritarie. Erano, quindi, contro il desiderio e contro il soggetto. Il
bambino cresceva immerso nella cultura della paura e della colpa
per le minacce degli educatori e per la presenza in lui di un desiderio
sessuale e aggressivo colpevolizzato, ma sempre presente nella sua
mente. D’altra parte, il vantaggio per la sua crescita era che in
adolescenza non ci voleva molto tempo per fare i conti con la realtà:
abituato com’era fin da piccolo a rinunciare ai propri desideri, ai
propri sogni e illusioni, l’adolescente cresceva in fretta e si abituava
molto rapidamente a entrare in un ruolo adulto responsabile. Tale
ruolo adulto, tuttavia, il più delle volte era stato scelto da altri e non
da lui. Anche chi poteva permettersi il lusso di scegliere il proprio
progetto futuro era in realtà poco consapevole di sé: nessuno, infatti,
insegnava ai ragazzi a scoprire chi fossero veramente, con una
piena consapevolezza dei propri desideri e dei propri valori; in
questo modo era difficile per un adolescente capire con chiarezza
quale fosse la sua vocazione e il suo vero Sé. La scelta della propria
identità adulta, quindi, risultava il più delle volte sbagliata, era cioè
espressione di un falso sé o di una parte limitata di sé. In sostanza,
un giovane prendeva spesso decisioni sbagliate poiché era poco
consapevole e si svegliava inoltre troppo tardi per poter cambiare il
suo progetto di vita.
Oggi le cose non vanno molto meglio. Numerose ricerche
descrivono i giovani attuali come soggetti apparentemente poco
interessati alla realtà sociale: in tutte le ricerche più recenti essi
appaiono passivi, tristi, sfiduciati, ritirati narcisisticamente.
Molti
ragazzi,
specialmente
quelli
più
vulnerabili
psicologicamente, sono drammaticamente persi nel loro cammino di
crescita e sono impigliati in gravi e spesso bizzarre patologie, tipiche
della nuova cultura familiare e del nuovo contesto sociale
rappresentato dalle lusinghe ipnotiche e regressive della cultura dei
consumi e del divertimento a tutti i costi, altri ancora da una sua
versione ancora più pericolosa, rappresentata dalle malattie
psichiche, dalle droghe e dalle altre dipendenze patologiche. A fare
da cornice alla famiglia affettiva, c’è infatti un contesto sociale dove il
mercato dei consumi, i mass media e le nuove tecnologie
sostengono seduttivamente i giovani nelle loro pretese immaginarie
e onnipotenti, mentre le istituzioni che dovrebbero fare da argine a
questa deriva narcisistica, la scuola e le istituzioni politiche prima di
tutto, appaiono deboli e poco capaci di offrire ai giovani un progetto
credibile.
La nuova famiglia affettiva, nata sulle ceneri del vecchio modello
repressivo, ha rifiutato l’autoritarismo e, al suo posto, ha preferito
scegliere il dialogo e la negoziazione. I nuovi genitori attuali si fanno
ubbidire «per amore», suscitando così molto spesso nei figli
sentimenti di vergogna e inadeguatezza, quando essi pensano di
non essere all’altezza delle aspettative dei genitori. La nuova
famiglia affettiva ha bisogno di tenere bassissimo il conflitto per
esorcizzare il fantasma dell’autoritarismo e per garantirsi il dialogo,
lo scambio affettivo e l’accomunamento al suo interno. A tal fine i
nuovi genitori hanno elaborato delle regole di basso profilo, più
orientate a governare la comunicazione e lo scambio affettivo,
piuttosto che a mettere in contatto il proprio figlio con i grandi valori
sociali, con le tradizioni e con la cultura. In questo modo essa ha
trascurato altri valori più utili per l’emancipazione dei figli e per il loro
inserimento nel mondo. La nuova famiglia affettiva, in effetti, fa
crescere figli «sregolati», cioè poco ispirati da un mondo di regole
interiorizzate e poco capaci di orientarsi nella realtà. Questo,
dunque, mette spesso in contrasto la famiglia con la scuola che è
invece il mondo delle regole.
Alle soglie dell’età adulta, in sostanza, arrivano ragazzi meno
inibiti di un tempo, ma poco capaci di inserirsi nella realtà. Figli
ambiziosi e pieni di sogni, ma troppo vulnerabili, troppo impreziositi
narcisisticamente, più in contatto con le proprie fantasie grandiose
che con la capacità di trasformare i propri sogni in progetti reali.
È verso la fine dell’adolescenza, dunque, che si consuma
definitivamente il fallimento della famiglia affettiva: con questo
modello i genitori s’illudevano di far crescere figli più liberi e felici, in
realtà i nuovi adolescenti sono meno liberi e felici di un tempo,
poiché condizionati dalla nostalgia della propria infanzia privilegiata
e dalla propria fragilità narcisistica. Gli adolescenti di un tempo, più
inibiti, ma anche più capaci di affrontare la vita adulta, dunque,
hanno lasciato il posto ad adolescenti depressi e fragili. L’angoscia di
castrazione è stata sostituita dalla paura dell’abbandono e dal timore
della mortificazione narcisista.
Il contributo dello yoga e della psicanalisi alla pedagogia
Yoga e psicanalisi sono due discipline che, al di là delle ovvie
differenze, presentano molte affinità: utilizzando lo strumento della
consapevolezza e dell’ascolto, propongono un percorso che è di
conoscenza e di trasformazione al tempo stesso.
Hanno come obiettivo la liberazione dalla sofferenza, che
riescono a mitigare e a sconfiggere attraverso la dispersione
dell’ignoranza, intesa come ostacolo alla conoscenza della propria
vera natura: lo yoga utilizza la pratica, fisica e mentale, la psicanalisi
la parola, ma l’esperienza è la stessa, il conoscerci meglio per
favorire la scoperta del proprio sé. Entrambe le discipline,
sostenendo il processo del cambiamento, si propongono di favorire
la nascita di un «uomo nuovo»: dapprima, attraverso lo scioglimento
delle tensioni più forti, si favorisce una condizione di equilibrio e di
maggiore benessere; poi inizia il lavoro di ricerca interiore che ha
come fine la rinascita, un modo nuovo di stare al mondo. I due
passaggi fondamentali di questo processo, condivisi dallo yoga e
dalla psicanalisi, sono il primo il recupero della presenza mentale,
basata su una piena consapevolezza, e il secondo l’integrazione e
l’armonizzazione tra quelle parti del sé che operano in modo scisso
e conflittuale all’interno della mente.
Sia lo yoga che la psicanalisi si servono della figura del maestro,
guru o analista, come colui che è passato attraverso le stesse
difficoltà ed è stato a sua volta allievo-discepolo. In entrambi i
percorsi si utilizza uno spazio protetto, quasi sacro, che sembra
segnare la differenza con la realtà ordinaria. Uno spazio nel quale ci
si esercita al sicuro, per poi sperimentarsi nel mondo esterno. Infine
è indispensabile il sentire, il mettersi in gioco completamente. Serve
a poco l’avere letto gli antichi testi dello yoga o l’opera omnia di
Freud! È importante invece essere disposti alla pratica umile e
attenta, il lasciarsi andare all’esperienza personale e coinvolgente su
piani diversi. La mente viene utilizzata in modo particolare, cercando
di mettere da parte la razionalità in favore dell’immaginazione e
dell’intuito, al fine di ampliare gli stati di coscienza e raggiungere
quindi una razionalità più completa e autentica.
Sono proprio queste affinità e somiglianze che consentono alle
due discipline la possibilità di integrarsi e di potenziarsi a vicenda. La
psicanalisi da sola a volte si limita a riportare le persone in uno stato
di equilibrio un po’ precario, adatto a fronteggiare le richieste della
società e non si occupa di condurre a un benessere più autentico e
profondo, collegato a un’esigenza di spiritualità. Lo yoga d’altra parte
non si interessa direttamente della salute psicologica del praticante e
non sempre situazioni nevrotiche e psicotiche di una certa gravità si
risolvono attraverso la pratica spirituale. Di qui l’importanza di
completare e integrare.
Queste due discipline, dunque, forniscono alla pedagogia
importanti indicazioni per un approccio educativo attento alla realtà
di chi cresce (la sua corporeità, il rapporto coi compiti della crescita,
l’aumento della consapevolezza).
Vediamo in particolare quali sono i compiti evolutivi su cui questo
approccio integrato è più utile.
Chi cresce deve innanzitutto crearsi un’immagine del nuovo
corpo che sia integrabile nell’immagine di sé. Perché questo
avvenga è necessario che vi sia l’elaborazione del lutto per la perdita
del corpo infantile, onnipotente e completo, con la conseguente
accettazione dell’idea della morte e della complementarietà. Il corpo
adulto infatti si caratterizza per la sua mortalità e per la necessità di
completarsi nell’incontro con l’altro. Ogni individuo, inoltre, è
chiamato alla costruzione di un sistema di valori autonomo e
individuale. Mentre nell’infanzia non gli era richiesto di assumere una
posizione critica rispetto ai modelli familiari, i cambiamenti intellettivi,
l’apertura verso il mondo esterno e la prospettiva verso il futuro
richiedono,
specialmente
in
prossimità
dell’adolescenza,
l’assunzione di una posizione autonoma. Questo lavoro di sintesi di
un sistema di valori personale e indipendente, che guiderà l’agire
futuro, è fatto a partire dal confronto con adulti esterni al sistema
familiare, con i coetanei e attraverso l’appartenenza a culture e
subculture giovanili. L’adolescenza, infine, comporta anche
l’assunzione di un ruolo sociale riconosciuto.
La riuscita positiva o negativa della realizzazione di questi
compiti ha importanti ripercussioni sulla modalità che un giovane ha
di stare all’interno dei vari ambiti in cui è inserito, da quello familiare
a quello scolastico.
Un percorso guidato di consapevolezza e di ascolto ci permette
di entrare gradualmente nel nostro mondo interno, a volte trascurato,
a volte semplicemente sconosciuto. Le tecniche dello yoga ci
consentono molto rapidamente di abbassare il livello di tensione
psicofisica e di raggiungere una condizione di equilibrio e di
tranquillità; l’energia vitale che in questo processo viene liberata
diventa disponibile per il lavoro di ricerca interiore. Attraverso la
condivisione e la parola, lo yoga indica alla pedagogia l’importanza
di entrare in contatto con parti di noi nascoste o soffocate. La ricerca
del vero Sé, della nostra essenza più autentica, può così avere
luogo, nel pieno rispetto della sensibilità individuale e di ogni storia
personale. Diventa così possibile scoprire che molto di quello che
tanto ci coinvolge, e a volte travolge, non è poi così importante… i
nostri desideri e i nostri bisogni sono altra cosa. Per essere più
sereni e più felici può essere sufficiente rinunciare a un eccessivo
controllo su di noi e su tutto ciò che ci circonda, per favorire
l’accettazione e il lasciare andare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :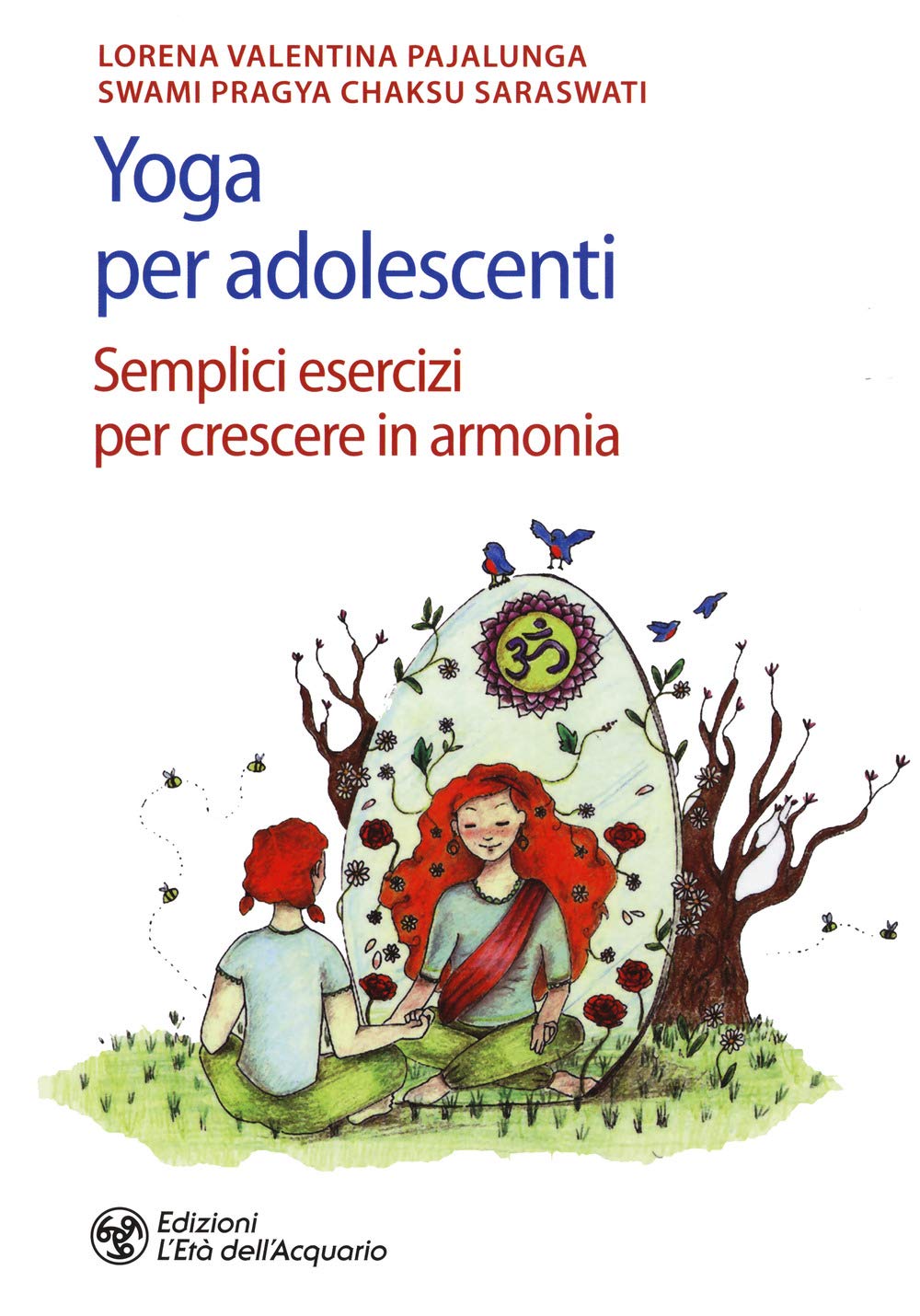






Commento all'articolo