Vite minuscole – Pierre Michon
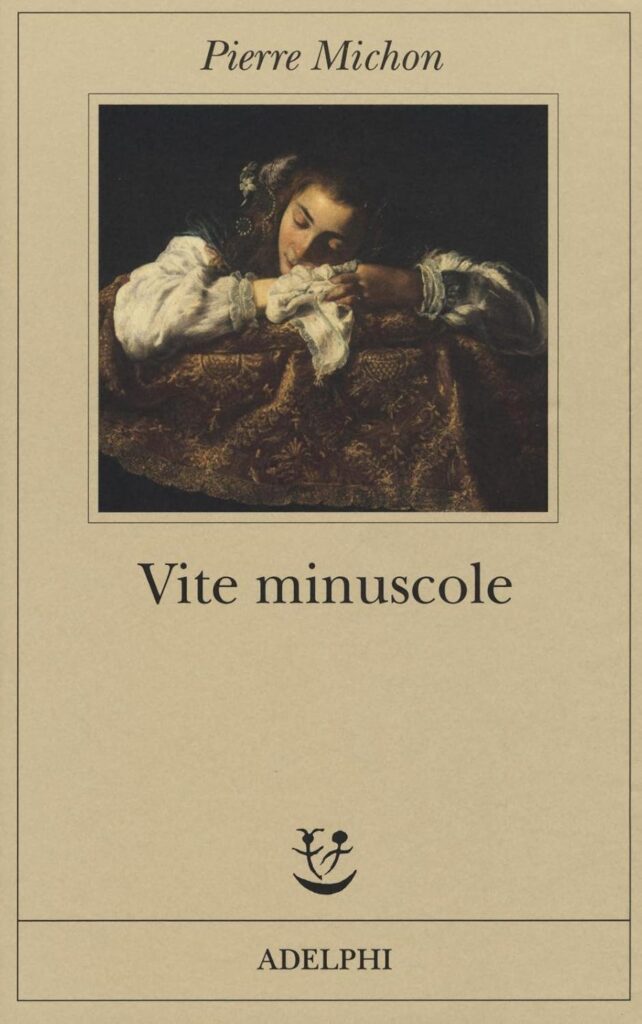
SINTESI DEL LIBRO:
Inoltriamoci nella genesi delle mie pretese.
C’è forse tra i miei antenati un bel capitano, un giovane guardiamarina
insolente o un negriero selvaggiamente taciturno? Uno zio, a oriente di Suez,
regredito alla barbarie con il suo casco di sughero, i jodhpurs fino ai piedi e
l’amarezza sulle labbra, personaggio stereotipato che volentieri si accollano i
rami cadetti, i poeti apostati, tutti quei disonorati carichi di onore, di ombra e
di memoria che sono la perla nera degli alberi genealogici? Un qualsiasi avo
coloniale o marinaio?
La provincia di cui parlo non ha coste, spiagge né scogliere; nessun ebbro
navigante di Saint-Malo, nessun altero provenzale vi ha mai udito il richiamo
del mare quando i venti di ponente lo riversano sui castagni, purificato dal
sale nel suo lungo cammino. Eppure, due uomini che conobbero quei
castagni, che lì sotto probabilmente si ripararono da un acquazzone, forse
amarono e comunque sognarono, sono poi andati sotto alberi assai diversi a
lavorare e a soffrire, a non realizzare il loro sogno, forse ad amare ancora, o
semplicemente a morire. Di uno dei due mi hanno parlato; dell’altro, mi
sembra, conservo il ricordo.
Un giorno, durante l’estate del 1947, mia madre sta passando con me in
braccio sotto il grande ippocastano di Les Cards, nel punto in cui
all’improvviso si vede sbucare la strada comunale, fino a lì nascosta dal muro
della porcilaia, dai nocciòli, dalle ombre; il tempo è bello, mia madre indossa
presumibilmente un vestito leggero, io farfuglio qualcosa; lungo la strada, un
uomo che lei non conosce è preceduto dalla propria ombra; lui si ferma;
guarda; è commosso; mia madre ha un lieve tremito, l’insolito, al culmine,
prolunga la sua nota nel fresco brusio del giorno. Finalmente l’uomo fa un
passo, si presenta. Era André Dufourneau.
In seguito, disse che gli era sembrato di riconoscere in me la bimba che
mia madre era, ugualmente infans e ancora inerme, al momento della sua
partenza. Trent’anni, e lo stesso albero che era lo stesso, lo stesso bambino
che era un altro.
Tanto tempo prima, i genitori di mia nonna avevano chiesto al brefotrofio
di affidare loro un orfano che li aiutasse nei lavori della fattoria, come si
usava a quell’epoca, quando ancora non era stato messo a punto il
compiacente e astuto inganno che, con la scusa di proteggere il figlio, porge
ai genitori uno specchio lusinghiero, edulcorato, voluttuario; allora bastava
che il piccolo mangiasse, avesse un tetto e imparasse a contatto con i ragazzi
più grandi i pochi gesti necessari a quel sopravvivere che per lui sarebbe stato
un vivere; quanto al resto, si riteneva che la tenera età supplisse alla
tenerezza, ovviasse al freddo, alla fatica e al duro lavoro che le focacce di
grano saraceno, l’incanto delle sere, l’aria buona come il pane contribuivano
a mitigare.
Gli mandarono André Dufourneau. Mi piace pensare che arrivasse una sera
di ottobre o di dicembre, inzuppato di pioggia o con le orecchie arrossate dal
gelo pungente; per la prima volta i suoi piedi calcarono quella strada che non
avrebbero calcato più; guardò l’albero, la stalla, il modo in cui l’orizzonte di
qui si stagliava contro il cielo, la porta; guardò i volti nuovi nella luce della
lampada, sorpresi o emozionati, sorridenti o incuranti; pensò qualcosa che
non sapremo mai. Si sedette e mangiò la minestra. Restò dieci anni.
Mia nonna, che si è sposata nel 1910, era ancora ragazza. Si affezionò al
bambino, colmandolo certamente di quella delicata gentilezza che ho avuto
modo di conoscere e grazie alla quale attenuò la rude bonarietà degli uomini
che il piccolo accompagnava nei campi. André Dufourneau non conosceva la
scuola, né mai la conobbe. Lei gli insegnò a leggere, a scrivere. (Mi
immagino una sera d’inverno; una giovane contadina vestita di nero fa
cigolare l’anta della credenza, ne estrae un quadernetto appoggiato in alto in
alto, «il quaderno di André», si siede accanto al bambino che si è lavato le
mani. Tra le chiacchiere in dialetto una voce si affina, si innalza di tono, si
sforza con più ricche sonorità di adattare la lingua alle parole più preziose.
Lui ascolta e ripete, dapprima intimidito, poi conciliante. Non sa ancora che a
quelli del suo ceto o della sua specie, nati più vicino alla terra e più lesti nello
sprofondarvi di nuovo, la Bella Lingua non dà la grandezza, ma la nostalgia e
il desiderio della grandezza. Smette di appartenere all’attimo, il sale delle ore
si discioglie, e nell’agonia del passato che sempre incomincia, sorge il
domani e subito si mette a correre. Il vento sferza la finestra con un ramo
spoglio di glicine; lo sguardo spaurito del piccolo vaga su una carta
geografica). Non era privo di intelligenza, forse dicevano che «imparava in
fretta»; e, con il buon senso lucido e intimorito dei contadini di una volta che
riconducevano le gerarchie intellettuali a quelle sociali, per giustificare
qualità così incongrue in un bambino della sua condizione i miei bisnonni si
inventarono, sulla scorta di vaghi indizi, una storia più rispondente a ciò che
consideravano il vero: Dufourneau divenne il figlio naturale di un signorotto
del luogo, e tutto tornò nell’ordine delle cose.
Nessuno sa più se fu reso edotto di questa ascendenza fantasmatica,
scaturita dall’incrollabile realismo sociale degli umili. Ma tant’è: se sì, ne
andò fiero e si propose di riconquistare ciò di cui, senza mai averlo
posseduto, era stato defraudato dalla condizione di bastardo; in caso
contrario, una forma di vanità si impadronì di quel contadino orfano, allevato
forse con un vago senso di rispetto, sicuramente con riguardi inconsueti, che
gli sembrarono tanto più meritati in quanto ne ignorava la causa.
Mia nonna si sposò; aveva solo dieci anni più di lui, e forse l’adolescente
che Dufourneau era divenuto ne patì. Ma mio nonno, devo dire, era allegro,
ospitale, buon diavolo e mediocre contadino; quanto al ragazzo, mi pare di
aver sentito da mia nonna che fosse simpatico. Probabilmente i due giovani si
vollero bene, il lieto vincitore del momento con i suoi baffi biondicci, e
l’altro, l’imberbe, il taciturno, il segretamente chiamato che aspettava la sua
ora; l’eletto dalla donna, con la sua impazienza, e l’eletto da un destino più
grande della donna, con la sua calma contratta; quello che scherzava e quello
che aspettava che la vita gli permettesse di scherzare; l’uomo di terra e
l’uomo di ferro, a non contare le rispettive forze. Li vedo andare a caccia; lo
sbuffo ritmico dei loro respiri, dopo un po’, svanisce inghiottito dalla nebbia,
le loro sagome sfumano al limitare del bosco; li sento affilare le falci, in piedi
nell’alba primaverile, poi iniziano a camminare e l’erba si piega, e il suo
profumo si fa più intenso con la luce, più pungente con il sole; so che si
fermano quando suona mezzogiorno. Conosco gli alberi alla cui ombra
mangiano e parlano, sento le loro voci ma non le capisco.
Poi nacque una bambina, scoppiò la guerra, mio nonno partì. Passarono
quattro anni, durante i quali Dufourneau divenne un uomo fatto; prese in
braccio la bambina; corse ad avvertire Élise che il postino stava imboccando
la strada della fattoria per portare una delle lettere, puntuali e diligenti, di
Félix; giunta sera, al lume della lampada, pensò alle lontane province dove il
tumulto delle battaglie radeva al suolo villaggi cui assegnava nomi gloriosi,
dove c’erano vincitori e vinti, generali e soldati, cavalli morti e città
inespugnabili. Nel 1918 Félix ritornò con alcune armi tedesche, una pipa di
schiuma, qualche ruga e un vocabolario più ricco di quando era partito.
Dufourneau fece appena in tempo ad ascoltarlo: lo chiamavano al servizio
militare.
Vide una città; vide le mogli degli ufficiali salire in carrozza scoprendo le
caviglie; udì giovani uomini che con i baffi sfioravano l’orecchio a deliziose
creature fatte di risa e di seta: era la lingua che aveva imparato da Elise, ma
pareva un’altra talmente i suoi nativi ne conoscevano le piste, gli echi, le
astuzie. Capì di essere un contadino. Non sapremo mai quanto soffrì, in quali
circostanze si rese ridicolo, il nome del caffè dove si ubriacò.
Volle studiare, compatibilmente con le costrizioni della vita di soldato, e
sembra che ci riuscisse, perché era un bravo giovane, con delle qualità,
diceva mia nonna. Si imbatté in manuali di aritmetica, di geografia; li ripose
nel suo zaino che sapeva di tabacco e di ragazzo povero; li sfogliò e conobbe
lo sconforto di chi non capisce, la ribellione che va oltre e, al termine di una
tenebrosa trasformazione alchemica, il puro diamante di orgoglio con cui
l’intelletto rischiara, per il tempo di un respiro, la mente sempre buia. Fu un
uomo, un libro, o più poeticamente un manifesto di propaganda della fanteria
coloniale a rivelargli l’Africa? Quale gradasso di provincia, quale romanzetto
impantanato nelle sabbie mobili o sperduto in una foresta su fiumi
interminabili, quale incisione del «Magasin pittoresque», in cui lucidi
cappelli a cilindro passavano trionfalmente tra lucide facce, non meno nere e
prodigiose, fece balenare ai suoi occhi l’oscuro continente? La sua vocazione
fu quel paese dove i patti infantili che si stringono con se stessi potevano
ancora sperare, all’epoca, di ottenere brillanti rivincite purché si accettasse di
affidarsi al dio altero e sbrigativo del «tutto o nulla»; era laggiù che Lui
giocava agli aliossi, spazzava via i birilli indigeni e sventrava le foreste sotto
la palla di piombo di un sole immenso, scommetteva e perdeva cento teste di
ambiziosi ricoperte di mosche sui bastioni d’argilla delle cittadelle sahariane,
tirava fuori dalla manica, a effetto, un tris di re bianchi, e mettendosi in tasca
i Suoi dadi truccati di ebano e avorio, avvolti in pelle di bufalo, si dileguava
nelle savane in pantaloni rossi e casco bianco, mentre mille bambini si
perdevano lungo la sua scia.
La sua vocazione fu l’Africa. E per un attimo oso pensare, sapendo che
non fu così, che ad attrarlo là non fosse tanto la volgare lusinga della fortuna
da accumulare quanto una resa incondizionata tra le mani dell’intransitiva
Fortuna; che fosse troppo orfano, irrimediabilmente rozzo e senza nascita per
fare sue quelle devote scempiaggini che sono la scalata sociale, il noviziato
che si supera con la forza del carattere, il successo che si conquista solo
grazie al merito; che partisse come un ubriaco bestemmia, emigrasse come un
ubriaco ruzzola a terra. Oso pensarlo. Ma parlando di lui parlo di me; e non
posso disconoscere più a lungo quello che fu, suppongo, il motivo essenziale
della sua partenza: la certezza che laggiù un contadino diventava un Bianco, e
fosse anche l’ultimo dei figli malnati, deformi e ripudiati della lingua madre,
era più vicino alla sua sottana di un Peul o di un Baulé; l’avrebbe pronunciata
ad alta voce e lei si sarebbe riconosciuta in lui, l’avrebbe sposata «dalle parti
dei giardini di palme, presso un popolo mitissimo» ridotto a una stirpe di
schiavi su cui fondare quelle nozze; lei gli avrebbe conferito, insieme a tutti
gli altri poteri, l’unico che conti: quello che strozza ogni voce in gola quando
si leva la voce del Buon Parlatore.
Terminato il servizio militare Dufourneau tornò a Les Cards — forse era
dicembre, forse c’era la neve, alta sui muri del forno, e mio nonno, che stava
sgombrando la strada con il badile, lo vide arrivare da lontano, alzò la testa
sorridendo, canticchiando tra sé finché lui gli fu davanti — e comunicò la sua
decisione di andare via, oltremare, come si diceva allora, nel repentino
azzurro e nella lontananza irreparabile: fare il salto nel colore e nella
violenza, lasciare il passato al di qua dell’oceano. La meta dichiarata era la
Costa d’Avorio; non meno manifesta l’avidità: quante volte ho sentito mia
nonna ricordare l’alterigia con la quale Dufourneau avrebbe affermato che
«laggiù sarebbe diventato ricco, o sarebbe morto», e oggi immagino —
mentre rievoco il quadro che la mia sognante nonna aveva disegnato soltanto
per sé, risistemando i dati della sua memoria secondo linee più nobili e
senz’altro più appassionanti rispetto a una realtà modesta la cui grettezza, se
ammessa, l’avrebbe ferita, quadro che probabilmente perdurò in lei fino alla
morte e si abbellì di colori tanto più preziosi quanto più la scena originale,
con il tempo e i ritocchi apportati dal ricordo, stava svanendo —, immagino
una composizione alla maniera di Greuze, una sorta di «partenza del figlio
avido» intento a recitare il proprio dramma nella grande cucina di campagna
che il fumo scurisce come una velatura, e dove, in un forte afflato di
emozione che scompiglia gli scialli delle donne e innalza le mani di uomini
rozzi in un muto gesticolare, André Dufourneau, fieramente piantato contro
una madia, il polpaccio tornito nelle mollettiere attillate e bianche come calze
del Settecento, protende con enfasi un palmo aperto verso la finestra
traboccante di un impasto blu oltremare. Ma io, da bambino, mi raffiguravo
quella partenza in modo assai diverso. «Tornerò ricco, o morirò laggiù»: ho
già detto che mia nonna aveva riesumato mille volte dalle rovine del tempo
questa frase, peraltro indegna di essere ricordata, aveva dispiegato daccapo il
suo breve vessillo sonoro, sempre nuovo, sempre di ieri; ero io a
chiederglielo, però, io a voler riascoltare questo ritornello della gente che
parte: la bandiera che tali parole facevano sventolare ai miei occhi, esplicita
come il simbolo con le tibie incrociate dei Fratelli della Costa, annunciava
l’inevitabile secondo termine della morte e la brama fittizia di ricchezze che
alla morte opponiamo soltanto per accoglierla meglio, l’eterno futuro, il
trionfo dei destini che affrettiamo mentre ci ribelliamo a loro. Provavo allora
lo stesso brivido che mi turbava alla lettura delle poesie dense di echi e di
massacri, delle prose abbaglianti. Lo sapevo: mi trovavo di fronte a qualcosa
di simile. E forse quelle parole, proferite non senza compiacimento da una
persona desiderosa di sottolineare la gravità dell’ora, ma troppo poco istruita
per saperla accentuare facendo finta di minimizzarla con un motto di spirito,
e quindi costretta, per dimostrarne l'eccezionalità, ad attingere a un repertorio
che riteneva nobile, erano per questo «letterarie», d’accordo; ma c’era molto
di più: c’era la formulazione ridondante, essenziale, vagamente comica — e
tra le prime volte nella mia vita, se ben ricordo — di uno di quei destini che
furono le sirene della mia infanzia, e al cui canto alla fine mi abbandonai
senza riserve appena raggiunta l’età della ragione; quelle parole erano per me
un’Annunciazione, e come un’Annunziata trepidavo senza coglierne appieno
il senso; il mio futuro si incarnava e io non lo riconoscevo; non sapevo che la
scrittura era un continente più tenebroso, più ammaliante e deludente
dell’Africa, lo scrittore una specie bramosa di perdersi ancor più
dell’esploratore; e che, sebbene esplorasse la memoria e le memoriose
biblioteche anziché dune e foreste, tornarne carico di parole come altri di oro
oppure morirvi più povero di prima — morirne — era l’alternativa offerta
anche allo scribacchino.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :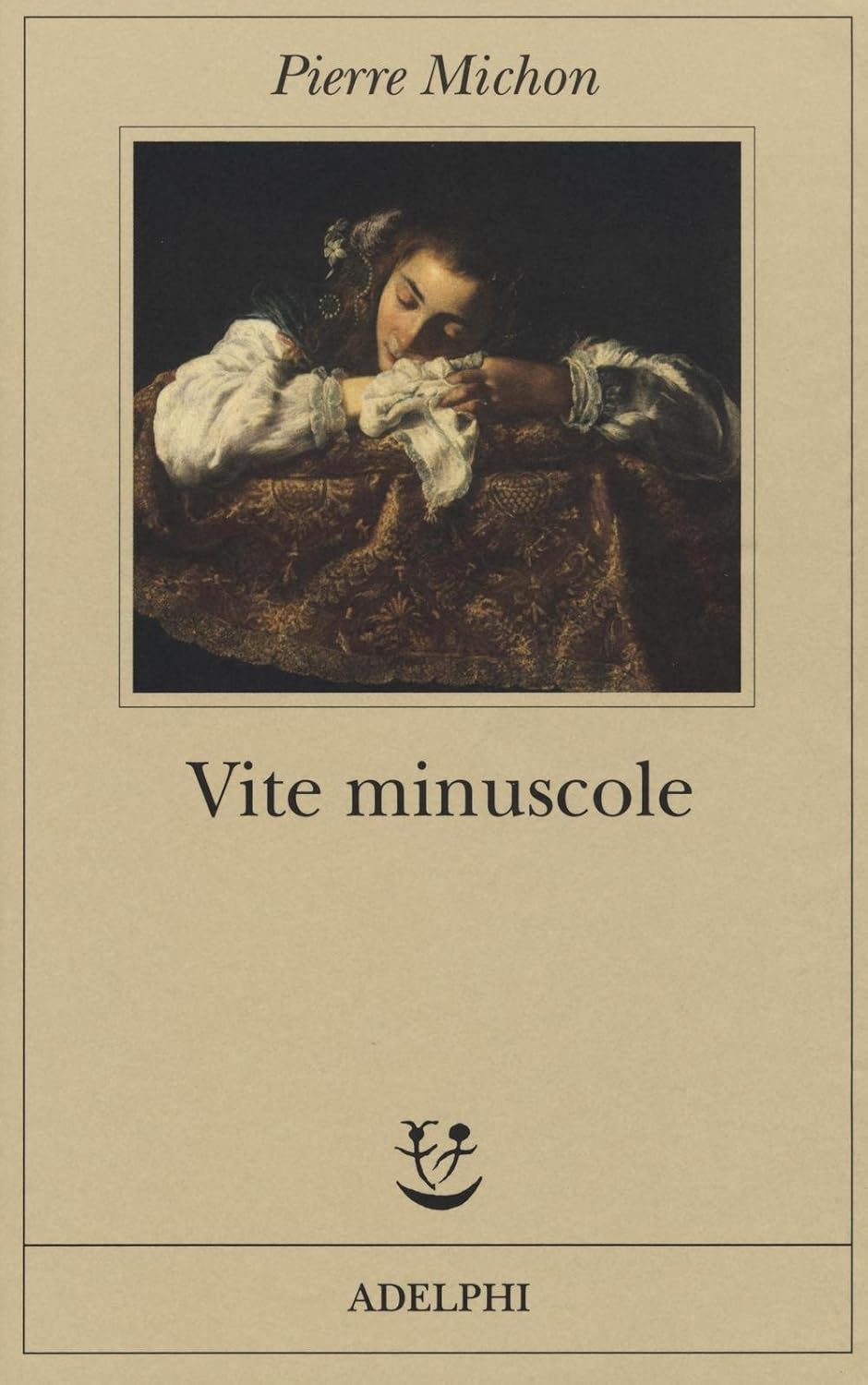






Commento all'articolo