Una levatrice a New York – Kate Manning
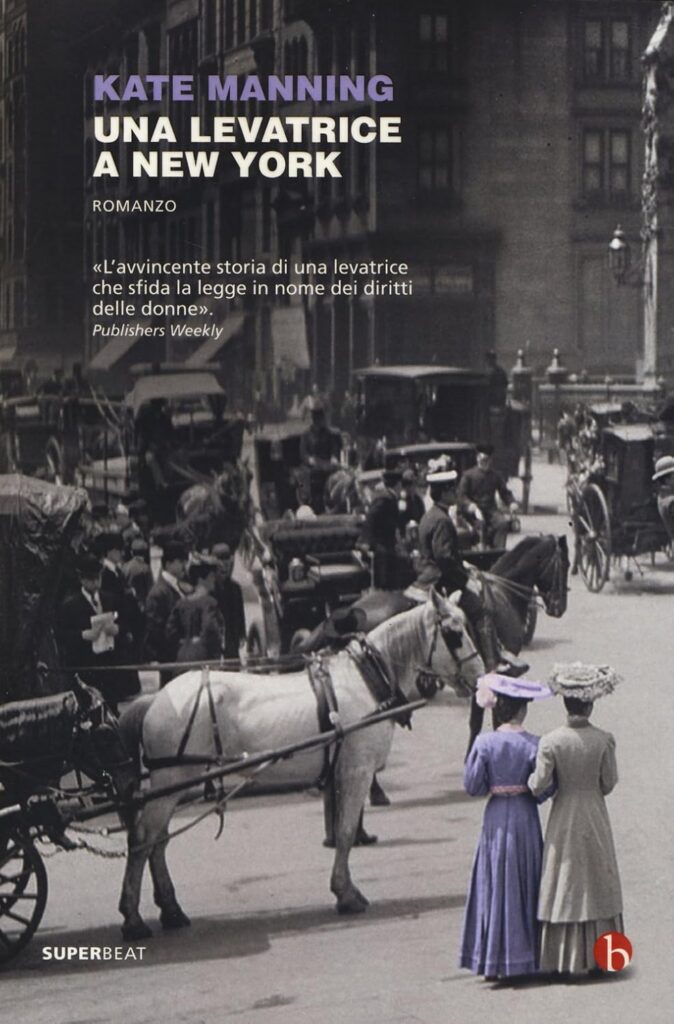
SINTESI DEL LIBRO:
Nell’anno 1860, quando le Grandi Pianure occidentali d’America erano
dimora dei bisonti nomadi, il duro accioolato della cià di New York era
il domicilio, unico e privo di teo, di trentacinquemila bambini. Così
odiosamente numerosi, noi mocciosi venivamo cacciati di casa o smarriti
dai nostri genitori, eravamo orfani di tui e due o di uno soltanto, scappati
di casa, prole miserabile d’irlandesi e di tedeschi, di italiani e di russi, servi
e schiavi, Maddalene e canaglie, una massa di lerci miserabili che sbarcava
speranzosa e sventurata sulla Baery senza possedere altro che muscoli e
denti, e la fame nella pancia. I nostri Padri e le nostre Madri produssero
lavoro, sudore e malaie, e bambini che sarebbe stato meglio non fossero
mai nati. Neonati ancora insanguinati, avvolti in carta di giornale, piccoli
come gocce di rugiada su foglie di cavolo, venivano abbandonati sulle
gradinate delle chiese e nelle corsie dei negozi di tessuti. Alcuni di noi non
superavano i due anni, camminavano a malapena e avevano il cranio
ancora tenero, quando venivano geati Senza Amici sul lastricato di
Broadway, ragazzini cenciosi che si nutrivano grazie a elemosine e
furtarelli. Molti di loro non avevano mai conosciuto le scarpe. Le ragazze
iniziavano da giovani a vendersi e i ragazzi si davano alla violenza. La
metà dei bambini scaricati agli ospizi per trovatelli moriva prima di
arrivare a un anno di età. Gli altri cosiddei ragazzi di strada erano
fortunati se vivevano fino a venti.
Io, mia sorella Dutch e mio fratello Joe eravamo quasi sempre tra
quella folla di miserabili, ma grazie alla nostra fame uno sconosciuto
incontrato per caso ci allontanò da quel sentiero, scambiando il nostro fato
incerto con un altro ugualmente incerto.
Il giorno in questione non avevo più di dodici anni, il naso all’insù,
indumenti laceri, stivalei allacciati e pieni di buchi che mi facevano male
in punta, capelli neri che per vanità mi piaceva raccogliere indietro, anche
se non avevo neppure un nastro; e gli occhi di mio padre, color del Mare
d’Irlanda, diceva sempre lui, azzurri come le onde. Ero alta due teste più di
uno sgabello da bar, le gambe erano due bastoni, le costole una scala. Non
ero una bellezza come Dutch, però riuscivo a cavarmela con quello che
avevo. E el Giorno noi tre ricevemmo una proposta del tuo nuova, che
arrivò e si presentò così.
Salve, viandanti!
Eravamo sulla soglia della boega del fornaio. Se ci si stava abbastanza
a lungo, forse si riusciva a rimediare un panino vecchio, o magari qualche
culo
di pagnoa. Non eravamo schizzinosi. Mangiavamo le briciole geate
agli uccelli. Eravamo peggio degli uccelli, disperati come rai. el giorno
la fragranza del pane infornato era una vera tortura, e poi le paste e le
torte e quegli éclairs al cioccolato, era come avere il profumo dei sogni
soo il naso, che faceva venire l’acquolina in bocca. Noi Muldoon non
mangiavamo dal giorno prima. Era febbraio o forse marzo, ma non
importa la data, eravamo congelati, senza guanti, senza cappello, noi
ragazze senza lana soo le gonne, soltanto le mutande piene di pulci.
Tenevamo caldo il piccolo Joe fra le braccia, pesante come mezzo bariloo
di birra. Dutch aveva la mia sciarpa, che le avevo dato perché aveva tanto
freddo. Era avvolta intorno alla mia testa e anche alla sua, e ce ne stavamo
là ferme, come quel vitello a due teste che avevo visto una volta a Madison
Square. Due teste, quaro gambe, un corpo. Due teste sono meglio di una,
eppure noi bambine avremmo dovuto essere più sveglie quel giorno, e
capire cosa stava per accadere.
Un cliente si fermò sulla soglia, un tipo alto e grasso, con i rotoli di
ciccia del collo fuori dal colleo della giacca, come una sciarpa di carne.
«Signore…?» implorò Dutch con quei suoi occhi azzurri, due gioielli
nel suo viso, sfavillanti di malinconia.
Il Signor Collo Ciccio rispose: «Tornate a casa dalla mamma».
Dutch replicò: «Non abbiamo nessuna mamma».
«Sì, sì, sì» ribaé lui. «L’ho già sentita. Adesso andate via».
«Per favore, signore» intervenni io. «Non l’abbiamo. È la verità».
(Anche se non era proprio esao.) «Soltanto un panino o una focaccia».
Il tipo insistee: «Ve lo ripeto, andate via». Era un miserabile
scarafaggio dagli stivali costosi, ma non fu lui a rovinarci, bensì la
gentilezza di sconosciuti.
Così cominciammo a piangere in silenzio, io e Dutch, perché non
mangiavamo dal mezzodì del giorno prima, là, in piedi per tua la maina,
con il dolore dei morsi della fame allo stomaco. La sciarpa intorno alle
nostre teste si era congelata insieme alle lacrime e al moccio.
Poco dopo arrivò un altro cliente, molto elegante. Aveva il pizzo e un
ciuffo di capelli sperduto in mezzo alla testa calva, lo vedemmo quando si
tolse il cappello, come se avesse una boe per la raccolta dell’acqua
piovana sopra il capo.
Lo salutammo con gli occhi bagnati di lacrime.
«Salve, signore…»
«Salve, viandanti».
Si abbassò subito a scrutarci come se fossimo interessanti e chiese con
voce d’angelo: «Ma perché, poveri bambini, perché state qui fuori al
freddo? Non piangete, dolci innocenti. Entrate a scaldarvi».
«Nossignore» risposi. «Non ci è permesso. Ci dicono subito di andare
via e ci prendono a calci».
«È oltraggioso» disse lui. «Morirete congelati».
Ci tolse il piccolo Joe per prenderlo in braccio e ci guidò dentro la
boega calda e fragrante. Avevamo la bocca che praticamente sanguinava
per la fame. Si sarebbe potuta mangiare l’aria di quella boega, così densa
di profumo di pane e di calore da forarci le guance.
«Fuori, fuori, fuori, fuori!» gridò la vecchia fornaia appena ci vide,
tua la ciccia che tremava di furore. «Fuori! Ve l’avevo deo!»
«Tre di quei panini bianchi e tè al lae per questi bambini» ordinò il
Gentiluomo, prima di sbaere le monete lustre sul bancone.
Anche se ci fissava con un cipiglio fosco e fumante d’ira, la miserabile
proprietaria inghioì la bile alla vista del rame del Gentiluomo e ci portò il
tè, che ci scoò la lingua senza rovinare neanche un po’ la morbida
mollica del pane e la sua dorata crosta croccante. Non aveva senso una
donna tanto dura con un pane tanto morbido. Ci sentivamo svenire, ma
cercammo di non divorarlo come bestie. Il Gentiluomo ci guardò mangiare
come se fossimo uno speacolo gratuito.
«Ecco, bambini, adesso va bene» disse poi con voce guurale.
Dutch gli geò le braccia al collo. «Oh, grazie, gentile Signore!»
esclamò. La sua dolcezza fu una ricompensa per lui, lo si capì dal suo
sorriso. Anche con la faccia sporca, Dutch era una bella bambina. Nessuno
poteva resistere alle sue lusinghe e al suo fascino, e lei lo sapeva bene,
anche se aveva soltanto see anni.
ando avemmo mangiato tuo il pane, lui chiese: «Avete ancora
fame?»
Un momento, lasciatemi ricordare bene il suo modo di esprimersi, il
tono. Lo disse in una bella maniera forbita: «Avete ancora appetito,
giovani e allegri viandanti?»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :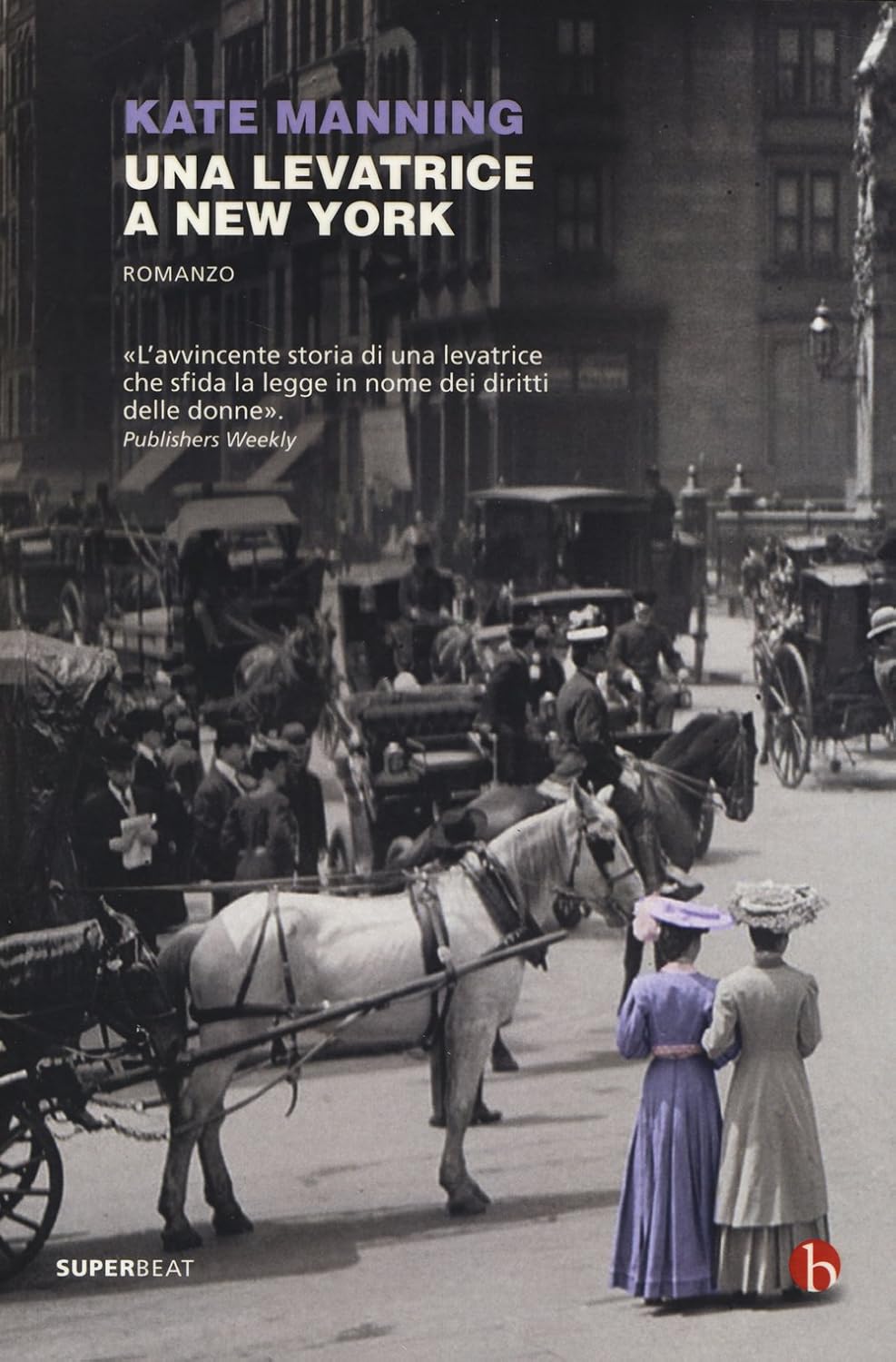






Commento all'articolo