Una fortuna cosmica- La vita nell’universo- coincidenza o progetto divino – Paul Davies
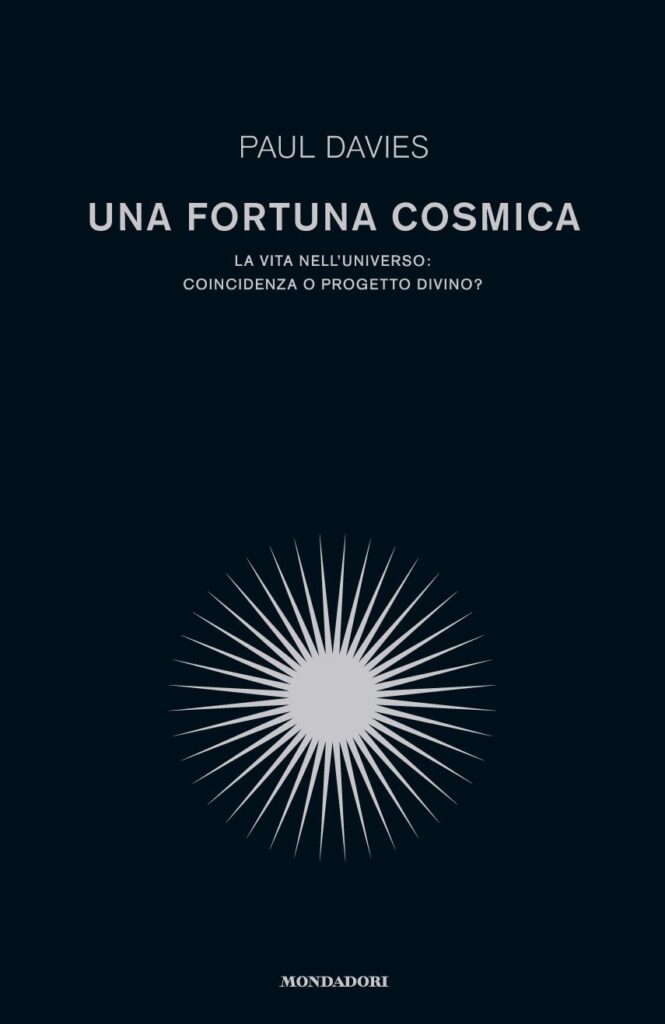
SINTESI DEL LIBRO:
Per millenni gli esseri umani hanno contemplato il mondo che li
circondava e si sono posti i grandi interrogativi dell’esistenza: Perché siamo
qui? Come ha avuto origine l’universo? Come finirà? Come è congegnato il
mondo? Perché è così com’è? Durante tutta la storia umana documentata, i
nostri simili hanno cercato le risposte nella religione e nella filosofia o
hanno concluso che erano questioni fuori dell’umana comprensione. Oggi
però molti di questi grandi interrogativi rientrano nell’ambito della scienza,
e alcuni scienziati sostengono di essere forse prossimi a fornire delle
risposte.
La fiducia degli scienziati che le risposte siano alla loro portata ha trovato
sostegno in due sviluppi di grande importanza. Il primo è l’enorme
progresso compiuto in cosmologia, cioè nello studio della macrostruttura
dell’universo e della sua evoluzione. Osservazioni condotte mediante
satelliti, mediante il telescopio spaziale Hubble e mediante complessi ed
evoluti strumenti posti a terra hanno concorso a trasformare la nostra
concezione dell’universo e del posto che l’umanità occupa al suo interno. Il
secondo sviluppo è la progressiva comprensione del mondo microscopico
all’interno dell’atomo, oggetto della disciplina nota come fisica delle
particelle ad alta energia. La ricerca in questo campo è condotta
prevalentemente con l’aiuto di gigantesche macchine acceleratrici di
particelle, del tipo di quelle che si trovano al Fermilab presso Chicago e al
laboratorio del CERN alle porte di Ginevra. L’interazione tra queste due
discipline – la scienza del molto grande e quella del molto piccolo – fornisce
stimolanti indizi del fatto che profondi e finora insospettati legami
connettano il microcosmo con il macrocosmo. I cosmologi amano affermare
che il big bang, che diede origine all’universo miliardi di anni fa, è stato il
massimo esperimento di fisica delle particelle mai compiuto. Questi
progressi spettacolari lasciano intravedere una sintesi molto più ampia:
nientedimeno che una descrizione completa e unitaria della natura, una
teoria del tutto in cui un resoconto impeccabile dell’intero mondo fisico sia
racchiuso in un unico schema esplicativo.
L’universo è propizio alla vita
Uno dei fatti più significativi – si può dire il più significativo – a proposito
dell’universo è la circostanza che noi ne facciamo parte. Dovrei dire fin dal
principio che moltissimi scienziati e filosofi sono in completo disaccordo
con questa affermazione, cioè pensano che né la vita né la coscienza siano,
sia pur remotamente, importanti nel grande disegno cosmico della realtà. La
mia posizione invece è quella di prendere sul serio la vita e la mente (ossia la
coscienza), per ragioni che spiegherò a tempo debito. A prima vista, la vita
sembra estranea all’argomento della cosmologia. Certo, la superficie della
Terra è stata modificata dalla vita, ma nella grandiosa vastità del cosmo il
nostro pianeta non è che un puntino infinitesimale. C’è un senso meno
diretto, però, in cui l’esistenza della vita nell’universo è un fatto cosmologico
importante. Perché la vita compaia e poi evolva in esseri coscienti come noi,
devono essere soddisfatte certe condizioni. Tra i molti prerequisiti necessari
per la vita – quanto meno per la vita come noi la conosciamo – c’è una
buona quantità dei vari elementi chimici richiesti per la formazione di
biomassa. Il carbonio è l’elemento chiave, ma anche l’ossigeno, l’idrogeno,
l’azoto, lo zolfo e il fosforo sono essenziali. L’acqua liquida è un altro
ingrediente indispensabile. La vita richiede inoltre una fonte di energia e un
ambiente stabile, che nel nostro caso sono assicurati dal Sole. Perché la vita
evolva oltre il livello dei semplici microbi, questo scenario favorevole alla
vita deve rimanere tale per un tempo molto lungo: ci sono voluti miliardi di
anni perché la vita sulla Terra raggiungesse lo stadio dell’intelligenza.
Su scala più vasta, l’universo deve essere sufficientemente vecchio e freddo
da permettere una chimica complessa. Deve essere abbastanza ordinato da
consentire la libera formazione di galassie e stelle. Tra le particelle materiali
devono agire i tipi di forza idonei a rendere stabili atomi, molecole
complesse, pianeti e stelle. Praticamente, se una qualsiasi delle caratteristiche
fondamentali dell’universo, dalle proprietà degli atomi alla distribuzione
delle galassie, fosse differente, la vita sarebbe con ogni probabilità
impossibile.
1Ora, si dà il caso che, perché siano soddisfatti questi vari
requisiti, le leggi fondamentali della fisica che regolano l’universo debbano
conformarsi a certe rigorose condizioni, in effetti talmente restrittive che un
universo propizio alla vita sembra un trucco, una specie di «intrigo» (put-up
job), per usare la colorita definizione del cosmologo britannico Fred Hoyle
(1915-2001). Sembrava a Hoyle che un superintelletto avesse «trafficato» con
le leggi della fisica.
2 L’impressione era giusta. Stando alle apparenze,
l’universo sembra davvero progettato da un creatore intelligente allo scopo
di generare esseri coscienti. L’universo, per molti interessanti aspetti, sembra
«proprio giusto» per la vita. Nessuna spiegazione scientifica dell’universo
può essere considerata completa se non rende conto di questa apparenza di
progetto intelligente.
Fino a poco tempo fa il «fattore Riccioli d’oro» era quasi completamente
ignorato dagli scienziati. Ora la situazione sta cambiando rapidamente.
Come vedremo nei prossimi capitoli, la scienza sta finalmente affrontando
l’enigma della ragione per cui l’universo è così stranamente adatto alla vita.
Per darne una spiegazione occorre comprendere come l’universo ha avuto
inizio e si è evoluto nella sua forma attuale, e sapere di che materia è fatto e
come è modellato e strutturato dalle diverse forze fondamentali. Soprattutto
occorre esplorare la natura stessa delle leggi fisiche.
Il codice cosmico
Durante tutta la storia, i più importanti pensatori sono sempre stati
convinti che il mondo di tutti i giorni che osserviamo mediante i sensi
rappresenti soltanto la manifestazione superficiale di una realtà nascosta più
profonda, dove si dovrebbero cercare le risposte ai grandi interrogativi
dell’esistenza. Questa convinzione è stata così forte che intere società ne
sono state plasmate. I cercatori di verità hanno praticato complessi
cerimoniali e riti, si sono serviti di droghe e meditazione per raggiungere
stati analoghi alla trance e hanno consultato sciamani, mistici e sacerdoti nel
tentativo di sollevare il velo che copre un mondo oscuro sottostante a quello
che percepiamo. La parola «occulto» in origine significava «conoscenza di
verità nascoste», e la ricerca di una via d’accesso al dominio occulto è stata
una grande preoccupazione di tutte le culture, dall’alchera o tempo del
sogno degli aborigeni australiani al mito di Adamo ed Eva che assaggiano il
frutto proibito dell’albero della conoscenza.
L’avvento dell’argomentazione razionale e della logica non dissipò affatto
l’idea seducente di una realtà nascosta. Platone paragonò il mondo delle
apparenze a un teatro delle ombre proiettato sulla parete di una caverna. I
seguaci di Pitagora erano convinti che i numeri possedessero un significato
esoterico. Anche la Bibbia è zeppa di numerologia: valgano come esempi le
frequenti apparizioni del 7 e del 40, o l’associazione del numero 666 con
Satana. Il potere dei numeri condusse alla credenza che certi interi, certe
forme geometriche e certe formule fossero capaci di evocare il contatto con
un piano soprannaturale, e che oscuri codici noti solo agli iniziati potessero
rivelare
segreti cosmici capitali.
3 Residui dell’antica numerologia
sopravvivono anche oggi: alcune persone superstiziose credono ancora che
numeri come 8 e 13 siano fortunati o sfortunati.
Tentativi di ottenere informazioni utili sul mondo mediante magia,
esoterismo e codici matematici segreti in generale non portarono a nulla.
Ma circa 350 anni fa il massimo mago che mai sia vissuto, Isaac Newton,
scoprì finalmente la chiave dell’universo: un codice cosmico destinato a
dischiudere le porte della conoscenza. Newton fu mistico, teologo e
alchimista, ma nonostante le sue propensioni esoteriche fece più di
chiunque altro per trasformare l’età della magia nell’età della scienza.
Insieme a un piccolo numero di altri luminari, tra i quali Niccolò
Copernico, Giovanni Keplero e Galileo Galilei, diede vita alla moderna era
scientifica. La parola «scienza» deriva dal latino scientia, che significava
semplicemente «conoscenza». In origine era soltanto uno dei tanti metodi
arcani usati per spingere l’indagine oltre le limitazioni dei nostri sensi nella
speranza di avere accesso a una realtà invisibile. La particolare specie di
«magia» impiegata dai primi scienziati faceva ricorso a procedimenti insoliti
e specializzati, come la manipolazione di simboli matematici su pezzi di
carta e lo sforzo di indurre la materia a comportarsi in modi inconsueti.
Oggi diamo per scontate queste pratiche e le chiamiamo, rispettivamente,
teoria scientifica ed esperimento. Il metodo di indagine scientifico non è più
considerato come un ramo della magia, come l’oscuro passatempo di una
casta sacerdotale chiusa e privilegiata. Ma la familiarità genera scarsa
considerazione, e al giorno d’oggi l’importanza del procedimento scientifico
viene spesso sottovalutata. In particolare le persone sembrano ben poco
sorprese del fatto che la scienza effettivamente funzioni e che noi siamo
realmente in possesso della chiave dell’universo. Gli antichi avevano ragione:
sotto la complessità che la natura mostra in superficie c’è un testo nascosto,
scritto in un elusivo codice matematico. Questo codice cosmico
4contiene le
leggi segrete secondo le quali funziona l’universo. Newton, Galileo e gli altri
scienziati delle origini trattavano le loro indagini come una ricerca di
carattere religioso. Svelando le strutture intessute nei processi naturali, essi
pensavano di intravedere davvero la mente di Dio.
5Gli scienziati moderni in
generale non sono religiosi, eppure ammettono ancora che alla base dei
processi naturali vi sia un copione intelligibile, perché credere altrimenti
significherebbe minare alla radice la motivazione stessa del fare ricerca, che
è quella di scoprire qualcosa di significativo sul mondo, che non sappiamo
già.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :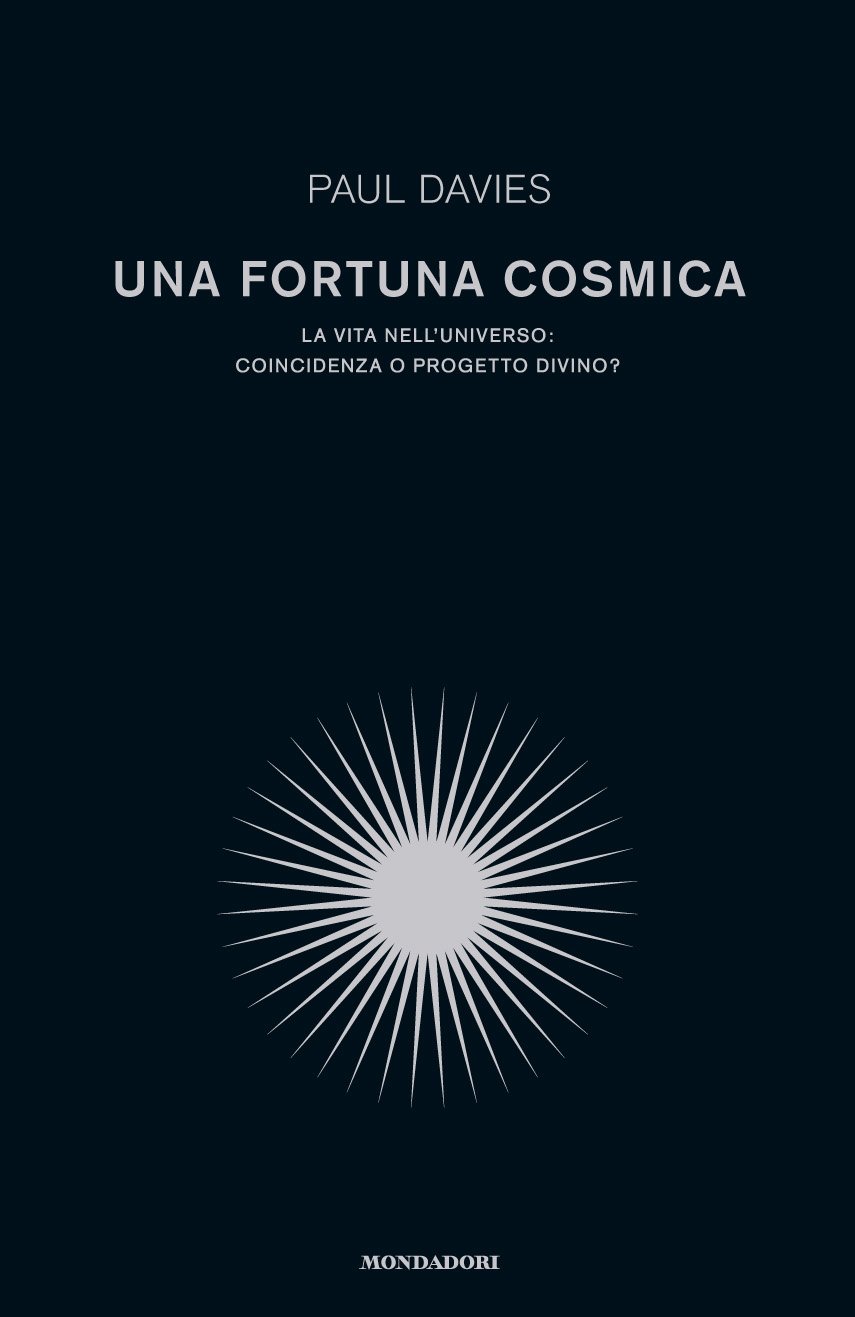




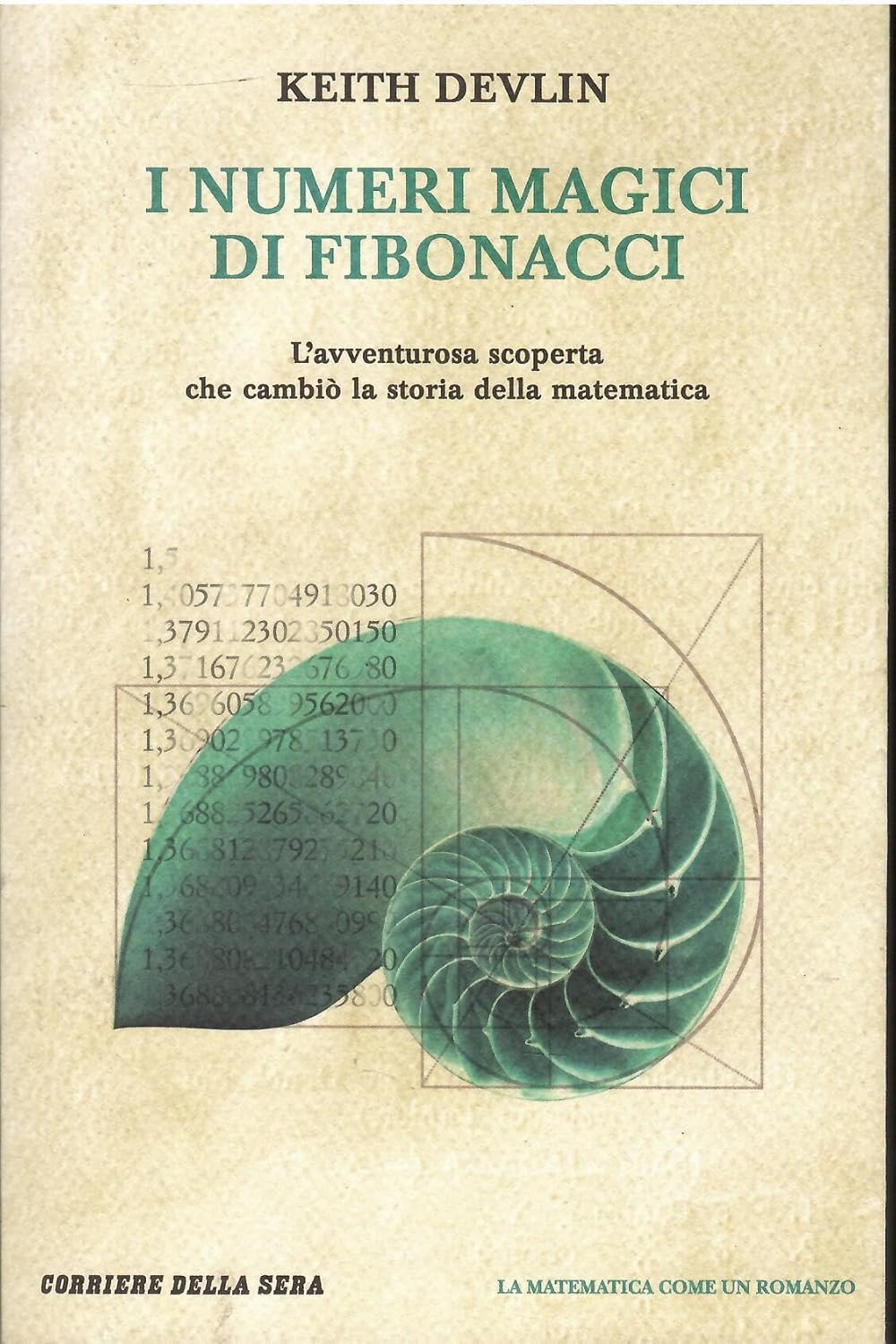
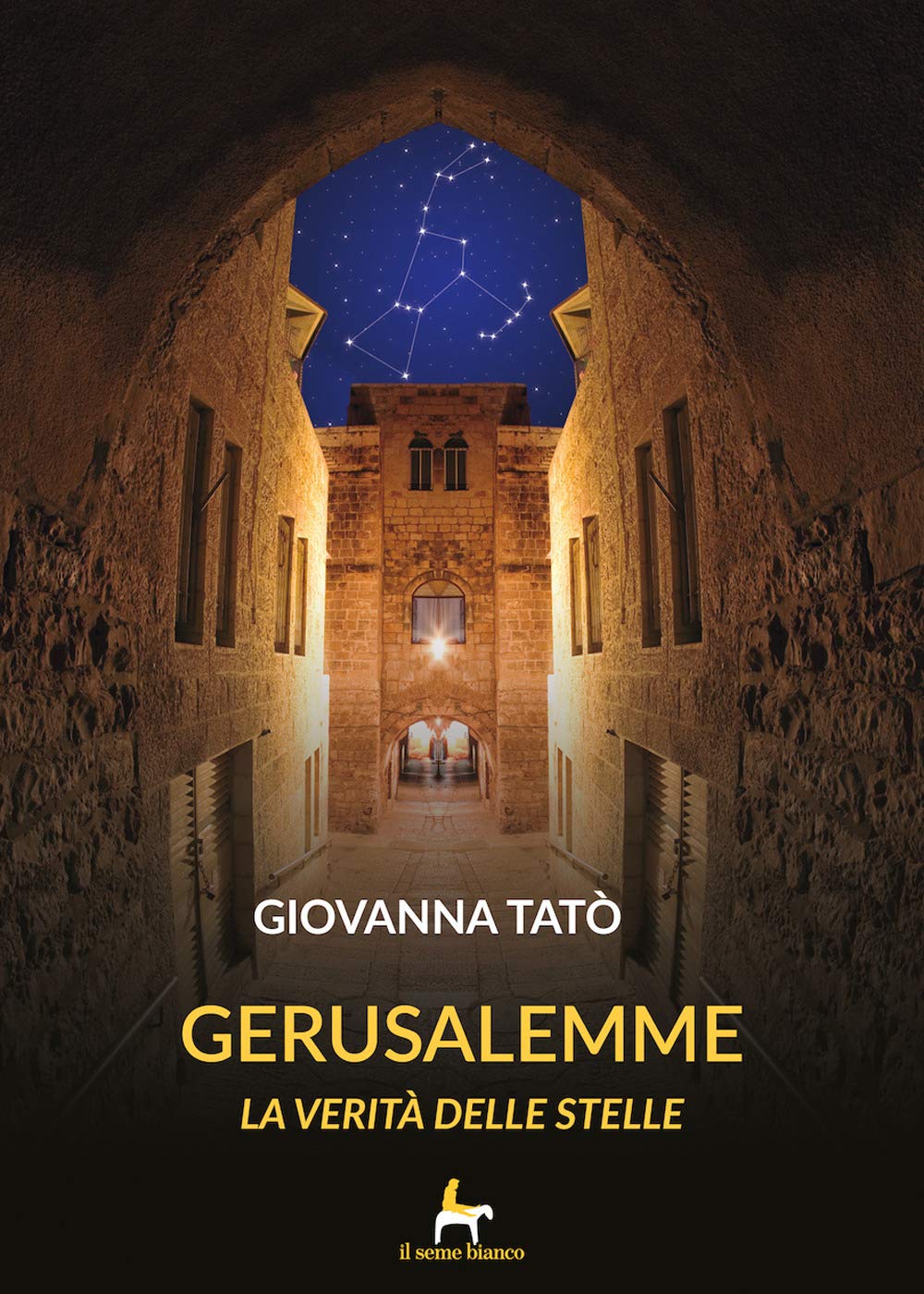
Commento all'articolo