Tutto Camilleri – Gianni Bonina
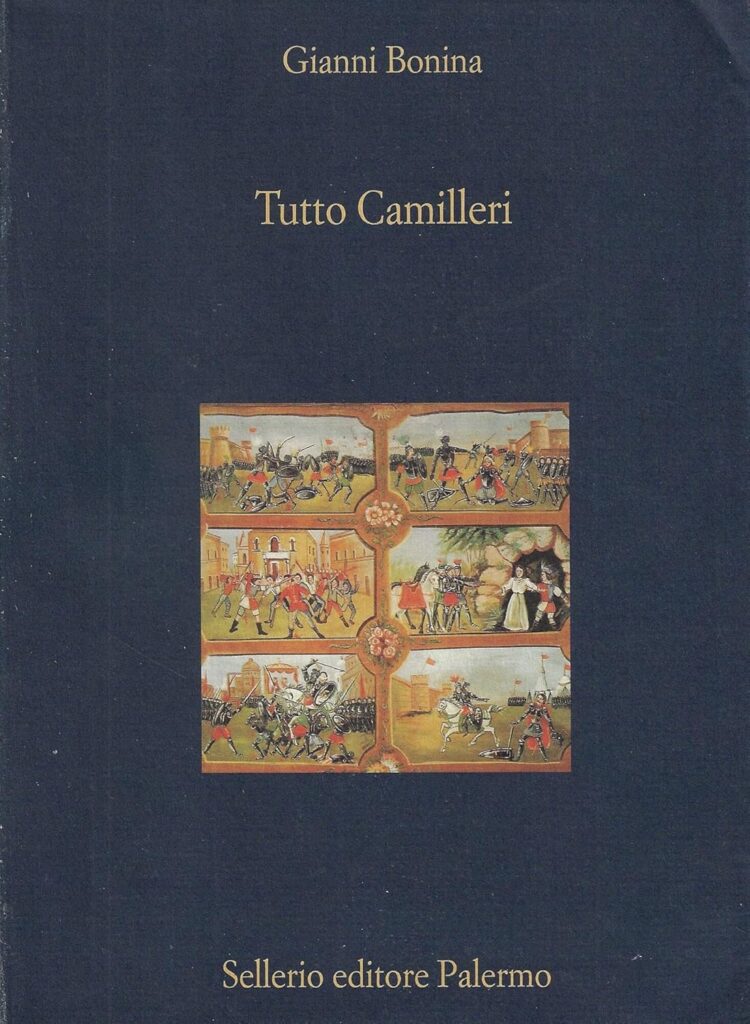
SINTESI DEL LIBRO:
Pubblicato nel 1978 ma scritto dieci anni prima, quando Camilleri è
poco più che quarantenne, Il corso delle cose è un acrilico che
addensa in una base di massa temi, motivi e modelli futuri: a
cominciare dal luogo di ambientazione che arieggia un paese nel
quale spira un’aria di famiglia, un paese facilmente riscontrabile in
una Porto Empedocle che non è ancora Vigàta, dove anche i
personaggi si prestano come cartoni preparatori di figure appena in
embrione eppure già intuite in una sinopia tenuta entro una scala
minima.
Il maresciallo dei carabinieri Corbo (il cui nome ripete quello del
padre di un compagno d’infanzia di Camilleri che era maresciallo) è
un avatar di Montalbano, talché don Pietro, il capomafia, può dire di
lui quanto ben varrà per l’altro: «È una volpe, uno sbirro vero, che
una cosa dice e un’altra ne pensa». Ci sono tutti gli elementi
costitutivi del nascente planisfero camilleriano: non solo un
linguaggio che seppure non faccia ancora man bassa dell’argot
agrigentino a esso va fieramente in prestito quando il termine
provinciale, non trovando nella lingua nazionale un pari corrispettivo
semantico, risulta più espressivo, ma anche un metodo narrativo che
concentra l’intero intreccio nell’arco massimo di due giorni: con la
differenza però che mentre in tutte le indagini di Montalbano l’autore
si identificherà nel protagonista con il quale procederà a braccetto,
qui invece il narratore è onnisciente mancando in realtà un vero
artefice della vicenda. Che non è neppure il maresciallo Corbo,
come non lo è Vito. Protagonista è semmai, come vedremo, il paese
sicché il romanzo integra un découpage non soltanto della serie di
Montalbano ma anche dei cosiddetti romanzi civili.
Ma in crisalide troviamo anche certe presenze ricorsive quali il
personaggio torinese gonfio e tronfio, il gioco di maschere dietro il
quale si nascondono non solo identità ma anche intenzioni, il gurgite
della gelosia come propellente all’infiammazione dei sensi, la
commedia delle parti e degli equivoci, la vocazione a «tragediare» e
volgere il dramma in berlina, la legge intesa come sciasciano
«ingranaggio» di «storie che non finiscono mai», il credo in regole
antiche e condivise, prima fra tutte l’onore, crisma della coscienza
mafiosa entro il cui spirito può invalere un’etica alternativa («Quelle
non erano cose da ricorrere alla legge, erano cose troppo grosse,
cose da sbrogliarsi mettendo in mezzo gli amici»); e ancora la
prevalenza del falso, la spinta a costituire prove a favore di
motivazioni più sociali e di costume che non politiche e civili.
C’è insomma già in nuce una sensibilità antinomistica che si
affermerà con forza nel carattere giusnaturalista di Montalbano e che
qui traluce di riflesso senz’altro da Sciascia. Sul cui Il giorno della
civetta proprio Il corso delle cose è ricalcato ad unguem fino a
essere un suo antigrafo mentale. Al primo, agito sul duplice caso di
un uomo ucciso e di un altro scomparso, fanno da contrappunto nel
secondo uno scenario allestito su un delitto e una minaccia di morte:
entro dunque un gioco di doppi che sembrano incrociarsi la strada.
L’incipit muove nello stesso segno: in Sciascia un omicidio e in
Camilleri la scoperta di un cadavere cui segue un interrogatorio che
in
entrambi i casi riguarda un testimone reticente. Nel titolo
sciasciano la prima figura istituzionale a comparire sulla scena è un
maresciallo dei carabinieri (proprio come in quello camilleriano) che
sottopone il testimone a interrogatorio e che di fronte allo stato di
omertà opposto dalla gente impreca: «E che, non viaggiava nessuno
oggi?». È lo stesso stato di omertà che Camilleri registra quando
vengono esplosi due colpi intimidatori contro Vito, il venditore di polli:
«Il maresciallo Corbo si taliava attorno domandandosi per quale
misterioso motivo macari i cani, in quella benedetta terra, dopo uno
sparo notturno, invece di secondare il loro naturale istinto e mettersi
ad abbaiare, si acquattassero per ore in silenzio per ricomparire poi
a luce fatta, in apparenza indifferenti come i cristiani».
E mentre il maresciallo di Sciascia dice all’autista testimone del
delitto «Se non vuoi che te ne faccia ricordare in camera di sicurezza
devi dirmi subito chi c’era sull’autobus», quello di Camilleri vince la
reticenza del contadino che ha ritrovato il cadavere trattenendolo
proprio in camera di sicurezza con metodi che sembrano fatti per
piacere a Montalbano. È convinto, da buon maresciallo che conosce
il
paese, che il contadino è informato dei fatti tanto da potergli
intimare: «Mi devi dire le cose che non so, con comodo quanto ti
viene in mente», perché non può il contadino non sapere, così come
non può non sapere l’autista torchiato dal maresciallo di Sciascia:
«Da tre anni ti vedo ogni sera al caffè Italia: il paese lo conosci
meglio di me».
Sia l’uno che l’altro maresciallo sembrano uscire dallo stesso calco:
Corbo mostra un’avversione nei confronti del capitano della Finanza
Bartolini (rimuginando fra sé epiteti irriverenti e impronunciabili) che
non è meno evidente di quella che il maresciallo sciasciano nutre nei
confronti del capitano Bellodi, l’uno e l’altro essendo due ufficiali
molto sicuri e determinati, provenienti non a caso dal continente, uno
da Torino e l’altro da Parma. Suppergiù alla stessa altezza della
trama appare poi un «innominato», un capomafia che è «vestito di
nero» sia in Sciascia quanto in Camilleri e che parla con un
interlocutore a un bar. In entrambi i testi agisce poi la falsa (ma più
credibile e benaccetta) pista della gelosia: Colasberna viene ucciso,
secondo una lettera anonima, per una questione di donne così come
Vito si pensa venga minacciato per avere avuto una donna d’altri. E
in entrambi i romanzi la loquacità dei siciliani viene posta come
viatico di esorcizzazione dell’omertà: Bellodi attribuisce alle lettere
anonime un’importanza che è pari a quella posta dal maresciallo
Corbo ai gesti: «I siciliani che hanno fama di non parlare in realtà
parlano, a mezza voce, cifrati, ma parlano, basta saperli
interpretare».
Sia qui che là la voce del paese è la più ascoltata e sincera, talché
è proprio il paese – nei suoi impenetrabili riti collettivi, nel
perseguimento dei suoi interessi pubblici, nelle sue congiunzioni
sotterranee entro una filosofia comunitaria che risponde a un fine
sociale di premunizione – ad assurgere ad artefice del destino
comune, muraglia di Semiramide al di qua della quale cambiano
leggi e costumi. Anche il finale de Il corso delle cose, aperto a una
interpretazione plurivalente, com’è nella cifra di Sciascia, richiama
da vicino il romanzo che (come si è detto già) ha portato in
letteratura il tema della mafia aggiornando in chiave moderna le
logiche de I vecchi e i giovani di Pirandello. Camilleri ha voluto
rivisitare dal canto suo lo stesso argomento depurandolo del grumo
di irredimibilità che pesa sulla sorte della Sicilia in cambio di una
composizione dell’ordine interno volta dal lato di Pirandello, nel
senso di una versione che faccia aggio sulla verità, una modalità che
vedremo ricorrere molte volte e di cui è il bar la sede deliberante.
Pirandelliano allora questo primo Camilleri che alza però
continuamente la testa da Porto Empedocle fino a Racalmuto. Chi è
infatti «Peppi monacu» se non un fratello di Ciampa? Accettato il
tradimento della ex moglie, Peppi continua ad avere con lei rapporti
carnali entrando in casa dalla finestra come un amante e può così
dire a Vito – e a tutti quelli che vanno da Giovannina entrando dalla
porta – che è lui a mettere le corna a loro e non loro a lui. Vito
preferisce credere che sia «Peppi monacu» a minacciarlo perché
non accetta una verità che implica una minaccia più grande e cupa,
«come un malato di tumore si vuole persuadere che soffre solo di un
raffreddore», ma quando deve fare i conti con la realtà reagisce in
maniera scomposta: muore quando è proprio sul punto di essere
fatto
salvo. Non accetta la composizione della vertenza,
l’aggiustamento trovato alle cose grazie agli amici, e si appella a un
sentimento di giustizia che non può avere dimora: «Vito è uno
scecco gessaro, che fa la stessa strada avanti e indietro per
trent’anni senza mai alzare la testa». Un sentimento di giustizia che
stinge in un altro di amicizia, perché nella rivelazione dell’amico
Masino, che pure ha inteso salvarlo proprio in segno di amicizia, non
vede la mano tesa ma quella armata, il tradimento, in ragione del
quale reagisce distruggendo il mondo: uccidendo e uccidendosi.
A perderlo è proprio il rifiuto di vedere il mondo com’è. E cosa fa
dopo aver ricevuto gli spari di minaccia? Se ne va al molo a
passeggiare, come farà Montalbano. Che prenderà il suo posto in
quel luogo «dove non si dà nell’occhio» e dove Corbo sa di trovare
Vito, così come il boss don Simone de Il casellante andrà a trovare
Nino Zarcuto. Non diversamente si comporterà il delegato Puglisi de
Il birraio di Preston, definito «scecco gessaro» anche lui perché va
dritto per la strada e ama andare al molo a riflettere, come
Montalbano di cui è il vero padre putativo, o il nonno come dirà
Camilleri in La testa ci fa dire.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :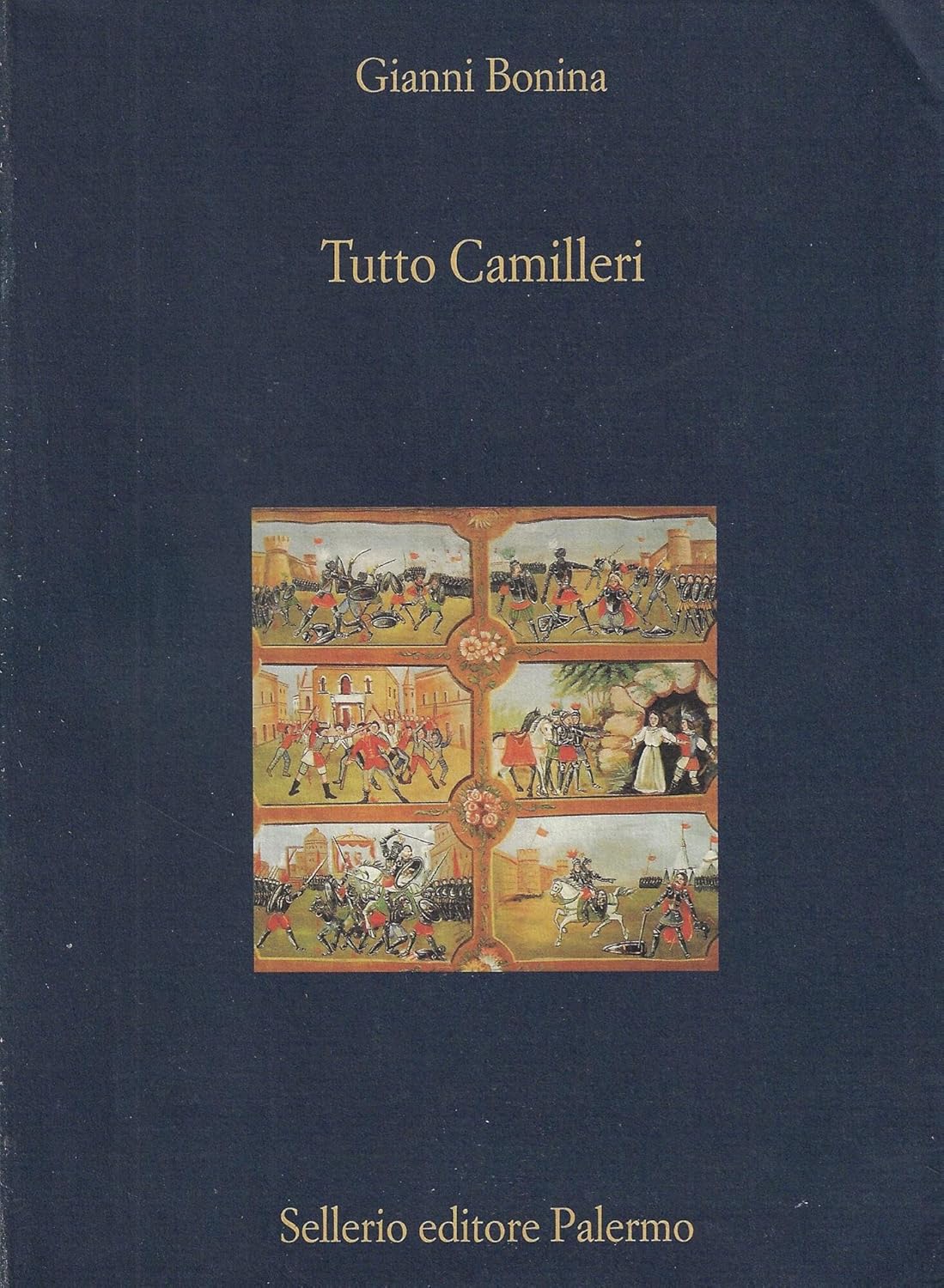






Commento all'articolo