Think like – Pensa da matematico – Comprendere numeri, forme e modelli a partire dalla vita quotidiana – Anne Rooney
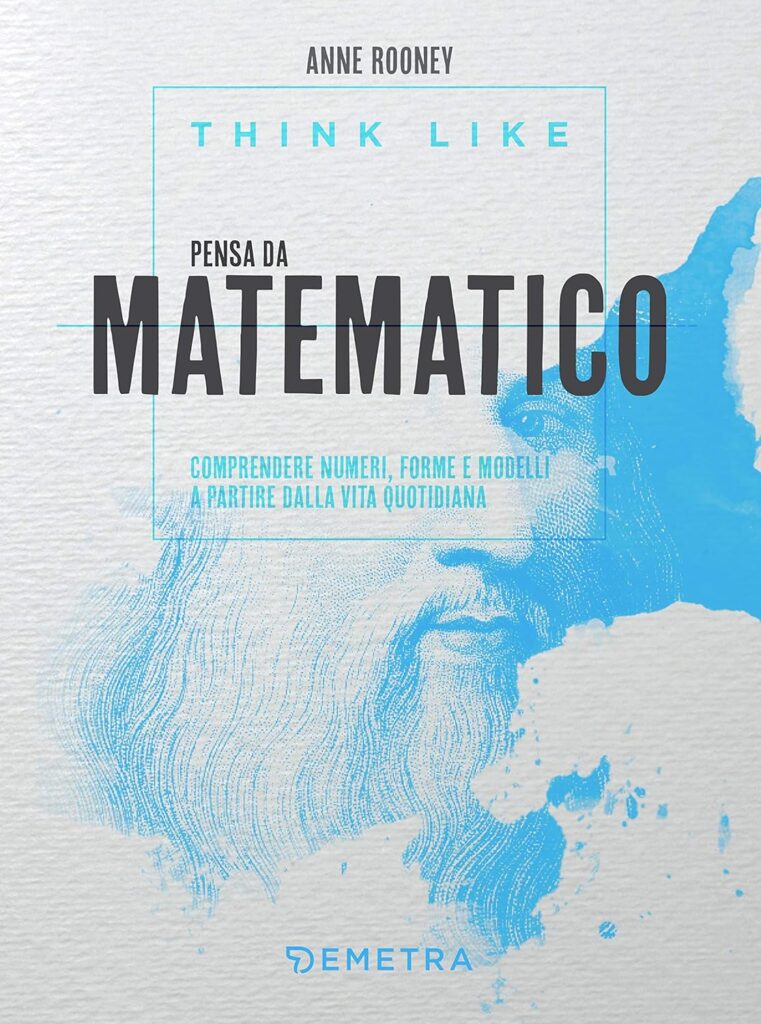
SINTESI DEL LIBRO:
CON LA RAGIONE O CON GLI OCCHI?
Per lavorare con dati e teoremi esistono due tecniche
profondamente diverse, e altrettanto accade con i concetti
matematici. Un metodo parte dalla riflessione e dalla logica, l’altro
muove dall’osservazione.
Prima con la mente: la deduzione è il processo razionale di
carattere logico che si serve di asserzioni generali date per valide
(postulati, assiomi…) per produrre previsioni su singoli eventi.
Valga come esempio l’enunciato secondo cui tutti i figli hanno (o
hanno avuto) i genitori e il fatto che Sofia è una figlia, da cui
inferiamo che Sofia deve avere (o avere avuto) dei genitori.
Finché le premesse di partenza sono verificate e la logica
rispettata, la previsione sarà corretta.
Prima con gli occhi: l’induzione è il processo tramite il quale
ricaviamo leggi generali a partire da casi specifici. Se
osservassimo numerosi cigni e riscontrassimo che sono tutti
bianchi, potremmo ricavarne (come si usava un tempo) che tutti i
cigni devono essere bianchi. Ma questa non è una conclusione
rigorosa… significa solo che non abbiamo ancora visto un cigno
di colore diverso dal bianco (vedi
Capitolo 10).
QUELLI CHE RAGIONANO, QUELLI CHE OSSERVANO
Che adottino un approccio induttivo o deduttivo, non sempre i
matematici hanno ragione.
Nel complesso, comunque, la deduzione si è rivelata più
affidabile e la matematica pura ne ha fatto oggetto di venerazione fin
dalle origini, con il matematico greco Euclide di Alessandria.
BASTA GUARDARE?
I
nostri antenati credevano che il Sole orbitasse intorno alla Terra,
non il contrario. Ma come ci apparirebbe il movimento del Sole se
fosse davvero lui a ruotare intorno alla Terra? La risposta è:
esattamente uguale.
Il modello di universo ideato dall’astronomo greco Tolomeo (circa
90-168 d.C.) assumeva come reale il moto apparente del Sole, della
Luna e dei pianeti attraverso il cielo.
Modello del sistema Tolemaico: la Terra è fissa, immobile al centro dell’Universo,
pianeti, Luna e Sole ruotano attorno a essa.
Veniva dunque applicato il metodo induttivo, dal momento che
Tolomeo rilevava l’evidenza empirica (ciò che egli stesso osservava
direttamente) e costruiva un modello che vi si adattasse.
Più si riusciva a misurare con precisione le orbite planetarie, più
gli astronomi di epoca medievale e rinascimentale introducevano
elaborate correzioni alla struttura matematica del modello tolemaico
di universo geocentrico, così da adattarlo alle loro osservazioni.
Ogni volta che una nuova rilevazione richiedeva una modifica,
l’intero sistema si faceva sempre più terribilmente intricato.
EPPURE, RIFLETTENDOCI…
Una coerenza matematica cominciò a emergere solo nel 1543,
quando il matematico e astronomo polacco Niccolò Copernico
rovesciò il modello tolemaico, collocando il Sole al centro del
sistema solare. Neanche i suoi calcoli, tuttavia, erano totalmente
precisi.
Più tardi, lo scienziato inglese Isaac Newton (1642-1726)
perfezionò le tesi copernicane per produrre una descrizione dei moti
planetari matematicamente solida, che non aveva bisogno di tanti
aggiustamenti per reggere; le sue leggi sul moto dei pianeti
sarebbero state confermate dalla scoperta di corpi celesti ancora
ignoti quando Newton stesso era in vita, a riprova che tali leggi
avevano anticipato l’esistenza di alcuni pianeti prima che fosse
possibile osservarli direttamente.
UN PIANETA? MA DOVE LO VEDI?
Nel 1843-1846, i matematici Urbain Le Verrier e John Couch Adams, indipendentemente
l’uno dall’altro, ipotizzarono l’esistenza e la posizione di Nettuno. Vi arrivarono per via
matematica, dopo aver osservato le perturbazioni (irregolarità) nel moto orbitale del vicino
pianeta Urano. Nettuno fu poi osservato e identificato da Johann Gottfried Galle e
Heinrich d’Arrest nel 1846.
Eppure il modello è tuttora imperfetto e a oggi, con le attuali
conoscenze matematiche, non risulta ancora pienamente
compatibile con il moto dei pianeti più esterni.
C’è ancora parecchio da scoprire, sia nello spazio o in
astronomia sia nella matematica!
I PARADOSSI DI ZENONE
Da tempo siamo consapevoli della discrepanza fra il mondo
dell’esperienza quotidiana e il mondo disegnato dalla matematica e
dalla logica.
Il filosofo greco Zenone di Elea, vissuto tra il 490 e il 430 a.C.
circa, usò la logica per confutare la nozione di “movimento”. Il suo
paradosso della freccia afferma che in un qualsiasi dato istante la
freccia è ferma nella posizione occupata. Una volta scoccata la
freccia, cioè, potremmo scattarne milioni di istantanee in tutte le
posizioni occupate prima di colpire il bersaglio, riscontrando che in
ogni istante la freccia stessa è immobile. Ma allora quand’è che la
freccia è in movimento?
Un altro noto paradosso ha per protagonisti Achille e una
tartaruga. I due si cimentano in una gara di corsa, in cui la tartaruga
parte con una lunghezza di vantaggio rispetto all’avversario. Ma in
questo modo, il piè veloce non raggiungerà mai l’animale: nel tempo
richiesto ad Achille per coprire la distanza fino alla posizione
originaria della tartaruga, questa avanzerà di un certo tratto.
E questo accadrà in continuazione, e vedrà la tartaruga coprire
tratti sì sempre più corti man mano che Achille si avvicina, ma
comunque sufficienti perché l’eroe non possa mai raggiungerla.
Questo paradosso verte sulla continuità di tempo e distanza intesi
come un fluire ininterrotto di momenti o posizioni infinitesimali. Il
ragionamento possiede coerenza logica, ma non combacia con la
realtà di cui abbiamo esperienza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :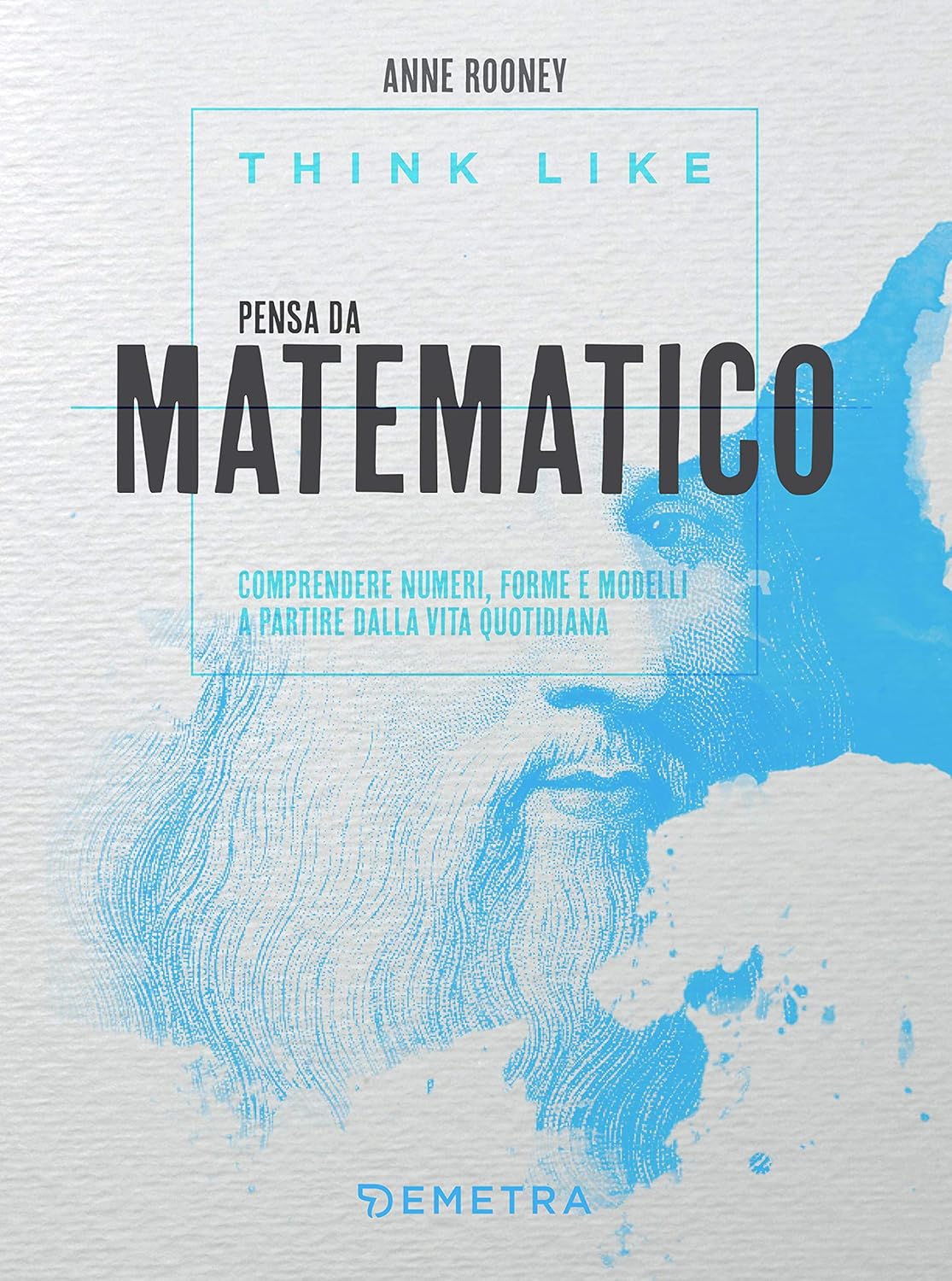




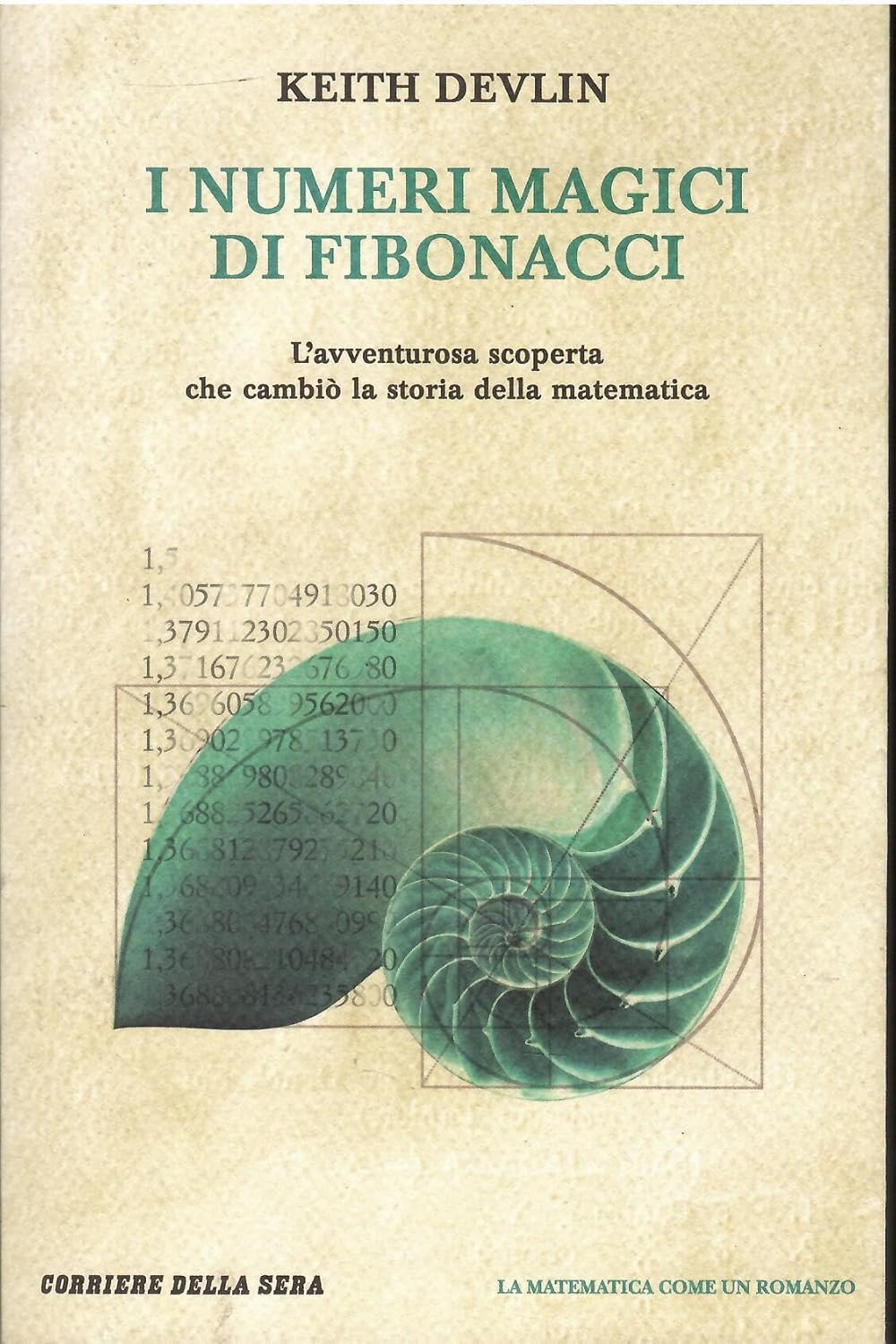

Commento all'articolo