Storia universale della svastica – Come un simbolo millenario è diventato emblema del male assoluto – Steven Heller
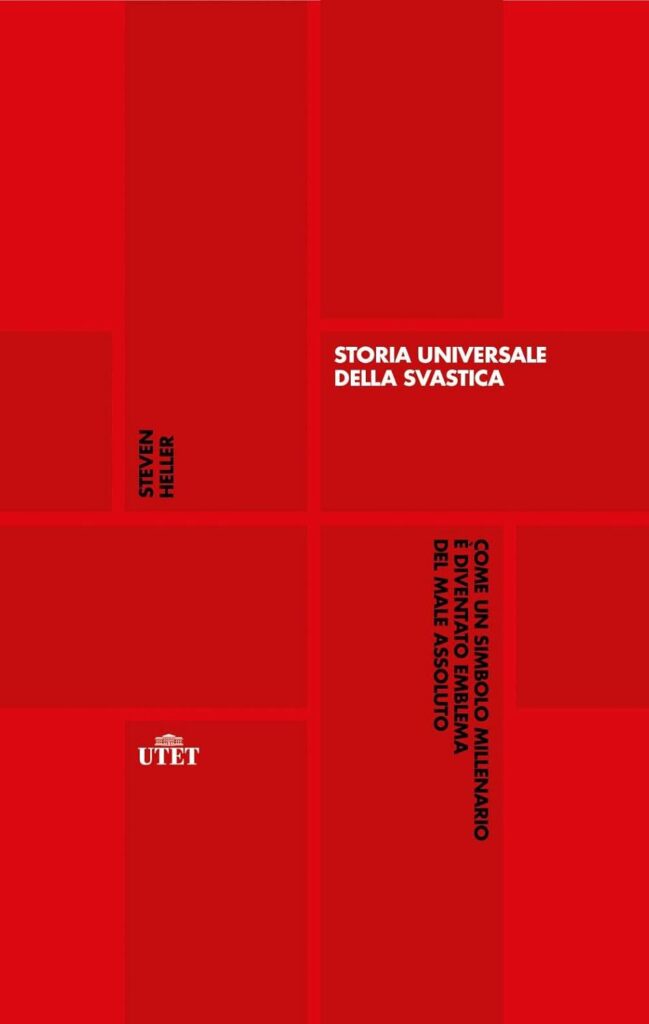
SINTESI DEL LIBRO:
La svastica esercita una speciale fascinazione sui grafici che – come
me, per esempio – passano tutto il tempo a lavorare con marchi e
loghi. Dopotutto, visivamente, si tratta di uno dei simboli più potenti
mai concepiti. Tralasciamo per un momento cosa l’ha infangata e
compariamola ad altri grandi simboli del passato e del presente:
nessun altro marchio, nemmeno varianti della croce o, per dire, il
“baffo” della Nike, è altrettanto potente a livello grafico. Come molti
simboli d’effetto, la geometrica purezza della svastica ne consente
l’intellegibilità in ogni formato e da ogni distanza, e quando viene
ruotata sul suo asse, il suo profilo squadrato sembra vorticare,
dando l’illusione del movimento. Come un’elica, le sue estremità
uncinate fendono qualsiasi superficie su cui appare. E con la stessa
violenza, se guardiamo al suo significato nel corso del XX secolo, si
conficcano dritte nel cuore.
La forma sublime della svastica coniugata alla sua funzione
malvagia ha stimolato un acceso dibattito rispetto alle sue origini e al
suo futuro. «Il fatto che ignobili fanatici abbiano messo la svastica
sulle loro bandiere di guerra non è una ragione sufficiente per
ignorarne il significato storico», ha scritto l’industrial designer Henry
Dreyfuss nel suo Symbol Sourcebook: An Authoritative Guide to
International Graphic Symbols. Molti altri si sono occupati della
metamorfosi retorica della svastica, da segno di buona fortuna a
emblema della Germania nazista, e in questa accezione tuttora
utilizzata da vari gruppi d’odio sparsi per il mondo. Ed è proprio
questa sua ambivalenza a renderla oggetto di vivaci dibattiti.
Oggigiorno, solo sentirne pronunciare il nome provoca repulsione,
se non vero e proprio terrore, in molte persone. Eppure è
universalmente risaputo che, per gran parte della sua lunga storia, la
svastica, lo Zelig dei simboli, sia stata relativamente benevola. Prima
della sua trasfigurazione, era usata come amuleto religioso,
talismano esoterico, elemento scientifico, simbolo corporativo,
strumento meteorologico, marchio commerciale, ornamento
architettonico, carattere tipografico, insegna militare.
«In prima istanza la svastica deve aver rappresentato la traiettoria
del sole nel cielo, che va da sinistra a destra», scrisse H.J.D. Astley
in The Swastika: A Study (pubblicato su “The Quest”, 1925).
Simboleggiava inoltre la luce, o il dio della luce, il fulmine forcuto, la
pioggia, l’acqua. Si crede sia il più antico simbolo ariano, e si è
radicata come icona giainista raffigurante la vita animale, umana e
celeste.
Rappresenta inoltre Brahma, Vishnu e Shiva
rispettivamente il Creatore, il Preservatore e il Distruttore. Appare
nelle orme del Buddha incise sulla dura roccia delle montagne
dell’India. Era l’emblema di Giove Tonante per i latini e di Thor tra gli
scandinavi. Si dice abbia avuto una correlazione con il simbolo del
loto in Egitto e in Persia. Appare nella necropoli di Koban, nel
Caucaso. Ha avuto una valenza fallica, ma è stata anche
riconosciuta come rappresentativa del principio generativo
dell’umanità, diventando il simbolo del femminile. La sua presenza
su monumenti dedicati alle dee Artemide, Era, Demetra, Astarte e
alla caldea Nana, la divinità più importante di Hissarlik (la località
dove furono trovate le vestigia dell’antica Troia), sembrerebbe dare
credito al fatto che fosse un segno di fertilità.
Le sue radici affondano nella preistoria e affiorano nel corso
dell’antichità. Nel 1874 Heinrich Schliemann scoprì alcune svastiche
decorative durante i suoi scavi archeologici sul sito della Troia
omerica, rilevando poi motivi simili anche a Micene, Babilonia, in
Tibet, in Grecia, tra gli ashanti sulla Costa d’Oro africana, a Gaza, in
Lapponia, Paraguay e Asia Minore. Ugualmente, sono state ritrovate
svastiche dipinte o incise su ceramiche etrusche, vasellame cipriota,
monete corinzie. Schliemann confermò la descrizione presente in
Ezechiele 9, 4: la svastica assomigliava all’antica lettera ebraica tāw
(), il segno della vita, che veniva disegnata per scopi rituali sulla
fronte dei credenti (ecco la ragione per cui il famoso omicida Charles
Manson aveva una svastica tatuata in fronte). Nella Gallia di età
romana, un elemento decorativo simile alla svastica detto “fusaiola”
impreziosiva piedistalli e altari di pietra. In Inghilterra e in Scozia, era
nota come fylfot, “molti piedi”, ed era la materializzazione della
buona sorte e di esordi propizi. Una grossa svastica ornava il
pavimento di un’antica sinagoga in Israele. Nel XIX secolo, sono
state ritrovate alcune svastiche di rame negli insediamenti nativi
americani di Hopewell Mound nella contea di Ross, Ohio, e di Toco
Mound nella contea di Monroe, Tennessee.
La svastica è stata utilizzata anche da organizzazioni di natura
secolare. Durante il XIX secolo fu un simbolo massonico, e Madame
Blavatsky la adottò come sigillo del suo movimento teosofico. Negli
anni venti fu adottata in quanto simbolo di pace dalla commissione
della Società delle Nazioni a Vilnius, in Lituania; negli anni trenta era
un elemento grafico dei vessilli militari di Estonia, Finlandia (dove la
chiamavano “croce della libertà”) e Lettonia. Lo stato secessionista
degli indios Cuna a Panama insediò la Repubblica di Tule con una
bandiera su cui campeggiava una svastica girata in senso antiorario.
È stata usata anche nel commercio, su loghi di beni di consumo e di
servizi. E malgrado parecchi di questi marchi fossero regolarmente
soggetti alle norme del diritto d’autore e a registrazioni catastali,
nessuno ebbe mai un effettivo copyright sulla svastica in sé, che
continua a rimanere a disposizione di chiunque la rivendichi.
La svastica offriva ad Artzybasheff l’opportunità di attaccare Hitler e i suoi
tirapiedi, 1942.
Considerati i fasti del suo passato, la svastica sarebbe potuta
rimanere uno dei simboli più duraturi e diffusi nel mondo. D’altra
parte, un simbolo grafico è tanto debole o tanto potente quanto lo è
ciò che rappresenta. E sebbene funzioni benissimo come supporto
mnemonico, in grado di evocare associazioni che generano un
riconoscimento istantaneo, trarrà la propria intensità, prima di tutto,
dalla qualità dell’oggetto o dell’idea a cui è legato. Come strumenti
per identificare un’azienda o un prodotto, per esempio, un marchio o
un logo non sono intrinsecamente né buoni né cattivi (tranne nel
caso in cui si rifanno a uno stereotipo malizioso o diffamatorio), ma è
il
loro utilizzo finale a determinare come vengono percepiti. A
prescindere dalle sue qualità esoteriche ed estetiche, alla base di un
buon marchio c’è sempre un prodotto o un servizio di eccellente
fattura. Al contrario, neppure un marchio acclamato e pluripremiato
potrà mai compensare una merce scadente o una pessima
reputazione.
Il fatto che per secoli la svastica non sia stata usata per fare del
male le conferisce un pedigree positivo. Ma per le sue origini incerte,
le funzioni variegate che ha ricoperto e il retaggio mistico, non c’è da
sorprendersi che abbia potuto essere fraintesa o reinterpretata, a
volte anche in maniera sinistra. Quando tra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo gli occultisti esoterici tedeschi se ne impossessarono
per farne il proprio significante segreto, il loro Sacro Graal
contenente i misteri dell’universo, la sorte della svastica cominciò a
vacillare. Fu in questo contesto che assurse a simbolo di un’antica
élite indoeuropea, di una razza ariana in possesso di una certa qual
forza naturale e di un’araldica recondita.
Se questi fossero rimasti semplicemente culti marginali della
società tedesca, chissà come sarebbe stata considerata la svastica
nel mondo occidentale dei nostri giorni. Ma la loro diffusa influenza
ebbe un profondo effetto su nazionalisti, monarchici e fascisti della
borghesia postbellica tedesca. Ancor prima della sconfitta della
Germania da parte degli Alleati durante la Grande guerra, la
superiorità ariana veniva promossa da gruppi paramilitari che
rivendicarono l’uso della svastica come simbolo. Già nel 1912, i
seguaci del Reichshammerbund (“Lega del Martello del Reich”) ne
fecero un loro emblema di battaglia. Dopo l’armistizio del 1918, le
truppe della famigerata Brigata Ehrhardt, appartenente ai Freikorps
e composta da paramilitari veterani dell’esercito intenzionati a
sbaragliare la neonata Repubblica di Weimar, durante le
schermaglie per strada esponevano la svastica. Per i nazisti, scrive
lo storico Nicholas Goodrick-Clarke in Le radici occulte del nazismo,
c’era tra le società segrete e il partito «una diretta linea di
discendenza simbologica rispetto alla forma della svastica».
Infine,
la
svastica e Hitler erano intercambiabili, come
esemplificato dal peana propagandistico della regista Leni
Riefenstahl in onore dell’impero nazista, Il trionfo della volontà. «Nel
film di Riefenstahl, quando Hitler è assente», scrive Malcolm Quinn
nel suo The Swastika: Constructing the Symbol, «il suo posto viene
preso dalla svastica, la quale, tanto quanto l’immagine del Führer,
incarna la corrispondenza tra identità personale e nazionale». La
svastica è stata un emblema nazista e nazionale così potente che a
settantacinque anni dalla caduta del Terzo Reich instilla ancora
paura e ripugnanza. Il suo retaggio è così duraturo e, pertanto, la
sua potenza metaforica così violenta, che il governo tedesco,
inizialmente obbedendo a una decisione degli Alleati alla fine della
seconda guerra mondiale, continua a vietarne ufficialmente qualsiasi
esposizione in pubblico. La svastica concentra una tale veemenza
nella sua forma che l’orrore è palpabile persino quando ci si trova di
fronte a quei loghi neofascisti contemporanei in cui viene riprodotta
solamente in modo parziale. A conti fatti, non è solo il vivido monito
di una storia luttuosa, bensì uno strumento (o perlomeno un
accessorio) di quella stessa depravazione.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :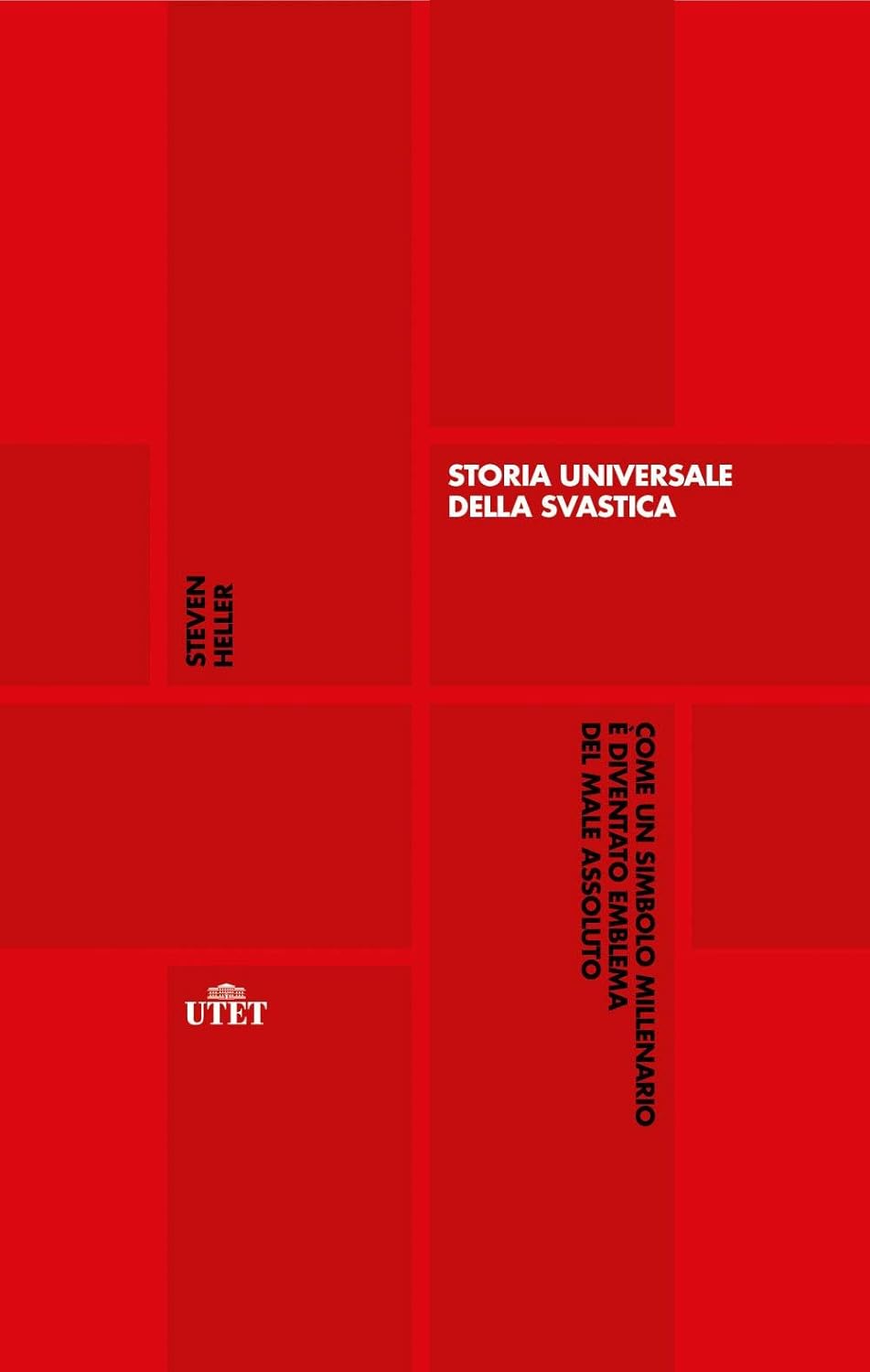






Commento all'articolo