Stare al mondo – Salvatore Natoli
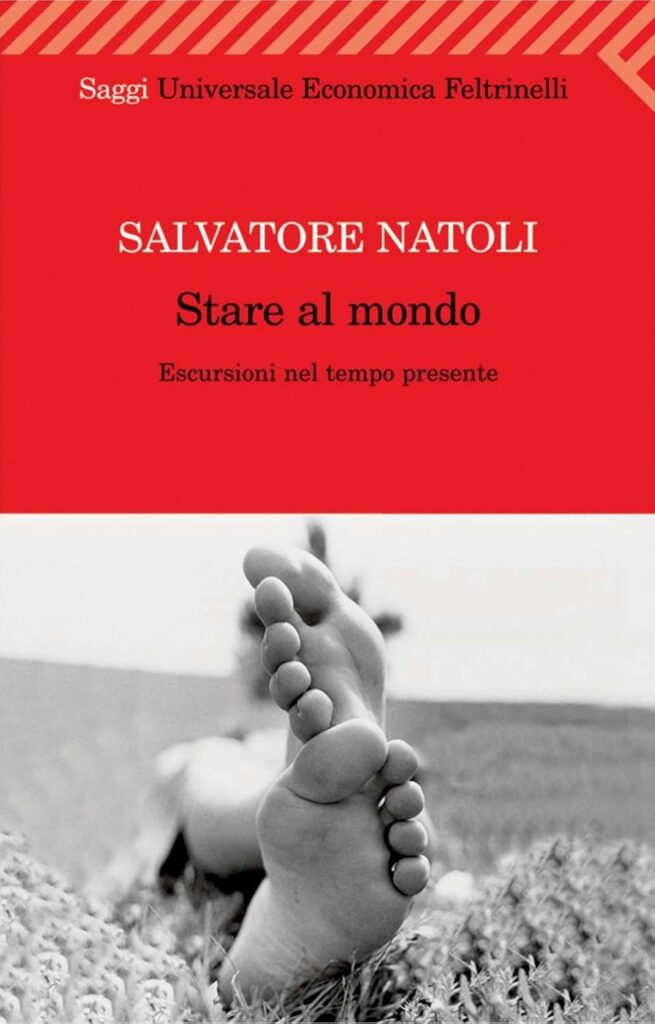
SINTESI DEL LIBRO:
Il secondo millennio si è chiuso in tutta normalità. La vita
ha proseguito senza turbamenti, salvo un po’ più di chiasso
alla fine: chiacchere moltissime, qualche falsa paura – le
ridicole preoccupazioni per il millennium bag – le numerose
frivole feste in attesa del nuovo millennio. Il giorno dopo
tutto come prima. Frattanto gli uomini dell’Occidente
avevano archiviato come se nulla fosse l’unico vero,
grande, evento della seconda metà del Novecento: la
dissoluzione dell’Unione Sovietica che si è disciolta come
neve al sole. Questo all’apparenza: in verità la dissoluzione
era da tempo in corso, generata non tanto – o non solo – da
fattori esterni, da pressioni politiche e militari, ma da
un’entropia interna al sistema, accelerata tra l’altro dalle
seduzioni sempre più filtranti e ammiccanti dell’Occidente
capitalistico. Ha vinto, dunque, l’America e non tanto come
realtà geografica, ma – lo hanno detto in molti – come
categoria storica, come “forma di vita” e, visto che la
parola corre, come civiltà. Buona o cattiva che sia.
La fine era, dunque, nell’aria, ma quando è giunta ha
comunque colto di sorpresa, probabilmente perché troppo
anticipata rispetto alle previsioni degli analisti e ai tempi
ordinari della politica. L’evento è stato, come si sa,
ampiamente celebrato, ma altrettanto frettolosamente
archiviato. E quel che è peggio, senza essere compreso.
D’altra parte capita spesso che l’inatteso, una volta
accaduto, assuma presto il carattere dell’ovvio. La cosa può
sembrare paradossale, ma viviamo in una società ove allo
shock subentra subito l’abitudine: gli eventi vengono
metabolizzati con i loro veleni e la liquidazione facile del
passato ci impedisce di affrontare con la dovuta serietà il
futuro. E, forse proprio per questo quel che potrebbe
essere previsto ci coglie all’improvviso. Ma era davvero
imprevedibile? O lo era del tutto? Oppure non è la
faciloneria con cui si liquida il passato che ci impedisce di
veder cosa matura al fondo delle cose.
Il
nuovo millennio, accolto nel modo frivolo che
sappiamo, si è viceversa annunciato in modo terribile: è
iniziato male, davvero male, come peggio non si poteva:
l’11 settembre 2001 le Torri gemelle di New York
investite da aerei civili resi armi micidiali e invincibili dalla
fede dei kamikaze – si sgretolano su se stesse, liquefatte
dal fuoco stesso che le incendia. Grande il numero dei
morti, inaccettabile. Morti e innocenti. E il Pentagono luogo
d’eccellenza per l’elaborazione delle strategie di difesa
viene colpito e insieme umiliato. L’atto è stato violento,
cruento, spietato – è un dato di fatto – ma è stato
soprattutto un gesto simbolico, terribile per quel che ha
voluto significare, per il suo secco messaggio: l’America
non è invincibile. Un messaggio agli americani per
terrorizzarli, agli occidentali tutti per avvertirli, alla propria
gente per incoraggiarli a combattere, mostrando loro che
l’America – il male assoluto – la si può battere, liquidare
per sempre. La ferita inferta è là visibile, dolente,
angosciosa e angosciante anche per i più indolenti. Tutti
siamo in pericolo.
L’atto certo è stato devastante, l’evento, come si usa dire
in questi casi, “tragico”. E tuttavia non meno di tanti altri
che poco visibili e misconosciuti accadono ogni giorno e da
tempo nelle più svariate parti del mondo: è un continuo
uccidersi e morire, una violenza diffusa e insieme endemica
che fa morti al pari di un’epidemia. Uno stillicidio, un
morire assiduo di guerra e di fame, ma ormai così scontato
da non fare più notizia. Le notizie dei telegiornali scorrono
come acqua. Chi le trattiene? Dieci morti là, tre dall’altra
parte, ma il numero è così sparuto che neppure lo si rileva.
Per automatismo, per moto inconscio tutto ciò viene
rubricato e acquisito nella serie dell’ordinario, quotidiano
morire. E poi è da aggiungere: 2000 morti per carestia,
migliaia e migliaia per Aids. Tutto ciò, però, non è morte in
diretta, non ha la visibilità mediatica delle torri che
crollano al limite tra il credibile e l’incredibile. La morte
anonima che circola per il mondo è marginale, di periferia,
non accade in un attimo, non ci coglie di sorpresa, con gli
effetti di un colpo di scena, uno spettacolo planetario – e
mai vi fu audience più ampia – al centro del teatro del
mondo e soprattutto in un luogo ove non si immaginava
potesse mai accadere: New York.
Eppure un evento così tragico si è mutato
immediatamente – e nell’informazione d’oggi direi
inevitabilmente – in finzione. È apparso in tutti i luoghi
della terra – quanto è piccola ormai – in modo reiterato,
ossessivo. E anche spregiudicato: le immagini sono
divenute meno inquietanti per eccesso di ripetizione, per
l’uso manipolatorio e compiaciuto che le ha impiegate
disinvoltamente come sfondo a commenti e dibattiti non
sempre adeguati alla gravità della circostanza. Le immagini
sono divenute innocue per “abitudine”, hanno trasformato
l’accadimento, unico e irrevocabile in stereotipo, ne hanno
dissolto l’orrore.
Ma non voglio qui ragionare sulla psicologia delle masse,
né indugiare più di tanto sugli effetti dei media nella
formazione dell’opinione pubblica: quel che mi preme
analizzare è, invece, la geopolitica contemporanea, i suoi
tratti distintivi, le sue mutazioni. In molti – direi quasi tutti– hanno detto che dopo l’11 settembre 2001 “il mondo non
è più lo stesso”. Sono d’accordo solo in parte e mi permetto
di precisare: non è vero che il mondo non è più lo stesso
dopo l’11 settembre, ma è più esatto rilevare che già da
molto tempo il mondo non è più lo stesso e questo – e solo
questo – ha reso possibile l’attentato dell’11 settembre. Ma
di questo chi se ne è accorto? Nei ragionamenti correnti
capita d’ordinario di invertire gli effetti con le cause, e ciò
per la semplice ragione che gli effetti sono spesso
deflagranti ed eclatanti, e le cause, in genere, sotterranee,
lente, nascoste. Complessivamente sto dalla parte degli
storici di lungo periodo che molto mi hanno insegnato sul
modo di leggere i fenomeni. Ragionando intorno alla fine
dell’Unione Sovietica ho già avuto modo di segnalare come
l’opinione pubblica archivi gli eventi con una velocità pari
all’intensità con cui è stata colpita. Dimentica o esorcizza?
Ci sarebbe da discutere. Intanto i processi da tempo attivi
nella società – e che hanno reso possibili quegli eventi che
improvvisi colpiscono – avanzano e cambiano la faccia del
mondo senza che i più se ne accorgano. L’attentato dell’11
settembre ha svegliato i dormienti, ha aperto gli occhi
anche ai più ciechi che di botto hanno gridato: ma come è
stato possibile? Se si fossero analizzati con maggiore
attenzione i mutamenti di fine secolo a partire dalla troppo
facile – e perciò sospetta – dissoluzione dell’Unione
Sovietica, si sarebbero capite molte più cose.
Alla luce dei movimenti profondi della nostra civiltà
l’attentato dell’11 settembre 2001 risulta meno improbabile
di quanto comunemente si crede e comunque meglio
comprensibile. Il bipolarismo tra Stati Uniti e Unione
Sovietica ha per mezzo secolo tenuto in equilibrio il mondo.
La fine dell’Unione Sovietica ha liberato forze scomposte,
devastanti in quanto troppo a lungo compresse,
risentimenti tribali pronti alla rivincita e alla vendetta,
disposti all’odio sociale, etnico. Le tensioni c’erano già
prima – forti e prepotenti – ma erano dominate dalla forza
degli stati socialisti, organismi potenti di controllo, ma
anche termini di riferimento ideale e di civiltà. L’Unione
Sovietica si è dissolta come organismo politico e sociale
anche perché è venuto meno il suo collante ideale: il
comunismo è divenuto parola vana, l’involucro volatile di
una macchina statale inceppata e violenta. E violenta non
per pura perversione o cattiveria, ma perché sempre più
greve e inefficiente. In ogni caso la divisione del mondo
aveva rappresentato per uomini e popoli un’opzione tra
valori, una scelta di civiltà. Oggi come allora la parola
torna: America significava “individualismo o libertà”;
l’Unione Sovietica, “socialismo o barbarie.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :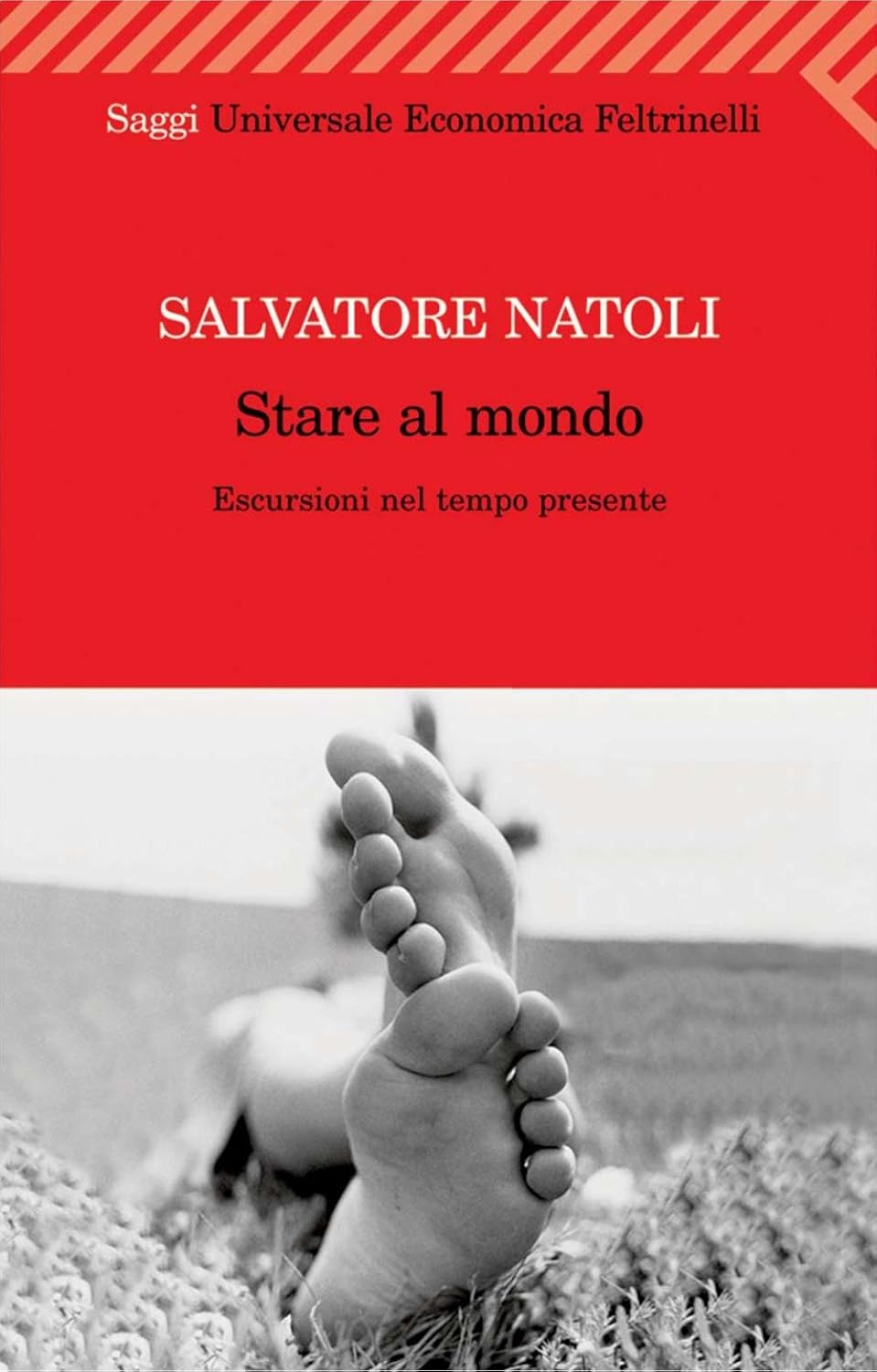






Commento all'articolo