Sovietistan – Un viaggio in Asia centrale- Erika Fatland
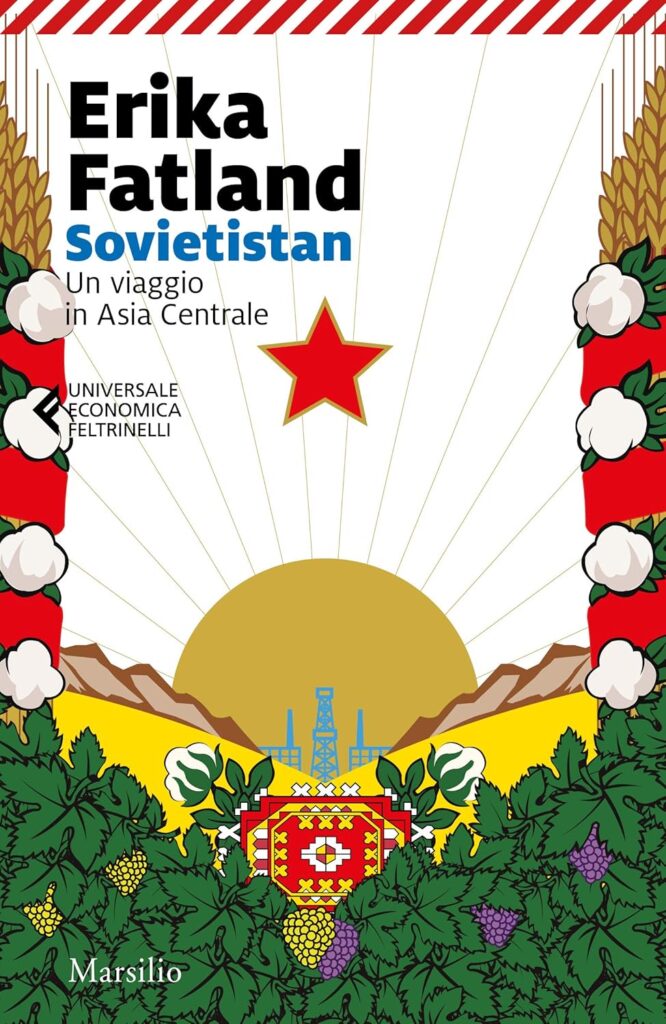
SINTESI DEL LIBRO:
Gate 504. Doveva esserci un errore. Tutte le altre uscite
iniziavano per duecento: 206. 211. 242. Avevo sbagliato terminal?
O, ancora peggio, avevo sbagliato aeroporto?
Oriente e Occidente si incontrano nell’aeroporto Atatürk di
Istanbul. I viaggiatori sono un beato miscuglio di pellegrini diretti
a La Mecca, di svedesi abbronzati con sacchetti del duty-free
stracolmi di Absolut Vodka, di uomini d’affari in abiti di serie,
nonché di sceicchi in bianco con le mogli in nero stracariche di
borse contenenti articoli esclusivi di design europeo. Nessuna
compagnia aerea del mondo conta tante destinazioni
internazionali come la Turkish Airlines, e chi deve raggiungere
strane capitali dai nomi esotici di solito deve mettere in conto uno
scalo in questo aeroporto. La Turkish Airlines vola a Chiscinev, a
Gibuti, a Ouagadougou e a Usinsk. E ad Ashgabat, che era la mia
destinazione.
In fondo a un lungo corridoio finalmente scorsi il numero
promesso. 504. Mentre mi dirigevo verso il gate, che più avanzavo
e più sembrava spostarsi in là, la folla si diradò pian piano. Alla
f
ine mi ritrovai da sola, ai margini del terminal, in un angolo
remoto dell’aeroporto Atatürk che pochi conoscono. Il corridoio
f
iniva in un’ampia scala. Scesi i gradini e misi piede in un mondo
di fazzoletti da testa sgargianti, berretti di montone marroni,
sandali e caffetani. Là ero io a dare nell’occhio con la mia giacca
quattro stagioni e le scarpe sportive.
Un uomo dai capelli bruni e gli occhi stretti si precipitò verso di
me. In mano teneva un pacco grande come un cuscino da divano
meticolosamente sigillato con nastro adesivo marrone. Potevo
portarlo per lui? Finsi di non capire il russo: Sorry, sorry, borbottai
tirando dritto. Che uomo era se non riusciva a portare il suo
bagaglio da solo? Un paio di donne di mezza età con indosso
vestiti di cotone lilla lunghi fino alla caviglia e grandi fazzoletti in
tinta avvolti intorno alla testa, presero le sue difese: mi aveva
forse chiesto troppo? Che cosa mi costava dargli una mano?
Scossi il capo. No, sorry, sorry, e allungai il passo. Non ero
assolutamente disposta ad aiutare un turkmeno sconosciuto con il
suo pacco sospetto. Tutti i miei campanelli d’allarme suonavano.
Riuscii a fare cinque, sei metri, poi fui fermata di nuovo. Una
donna sulla ventina, magra come un chiodo, in un vestito lungo
f
ino ai piedi, mi afferrò per un braccio. Potevo farle la cortesia di
aiutarla con un po’ del suo bagaglio? Solo un po’?
Net! risposi decisa divincolandomi.
Nella zona d’attesa vera e propria mi resi conto di come
stavano le cose: praticamente tutti i passeggeri avevano troppi
bagagli a mano, e all’ingresso del gate i dipendenti della
compagnia aerea aspettavano con bilance pesapersone e l’aria
severa. Non appena superato il varco, i passeggeri si strappavano
di dosso i pacchetti che avevano portato fissati con lo scotch sotto
i vestiti.
A quanto sembrava, sotto le lunghe sottane le donne erano
riuscite a nascondere di tutto. Ridacchiando si liberavano del
carico, senza curarsi più di tanto di farsi vedere dal personale di
bordo. Ormai erano passate.
Il mistero principale, però, non era ancora risolto: perché mai
avevano tutti tanto bagaglio a mano? Evidentemente una hostess
aveva notato la mia espressione perplessa, perché mi rivolse un
cenno d’intesa facendomi segno di avvicinarmi: «Sono donne
d’affari» spiegò. «Vanno a Istanbul almeno una volta al mese e
comprano articoli che poi rivendono con un margine di profitto al
bazar di Ashgabat. Quasi tutta la merce che si vende in
Turkmenistan è prodotta in Turchia.»
«E perché non la mettono nelle valigie?» chiesi. «Hanno paura
che i bagagli vadano perduti durante il viaggio?»
La hostess rise.
«Hanno anche le valigie, mi creda!»
L’imbarco fu complicato. I passeggeri che avevano troppo
bagaglio a mano, ed erano la maggioranza, dovettero sigillare le
borse di plastica da pochi soldi con il nastro adesivo e mandarle
come bagaglio normale. Dentro l’aereo regnava il caos. Le donne
occuparono i posti che preferivano provocando proteste sonore da
parte degli uomini in caffetani bianchi. Ogni volta che un
passeggero reclamava, altri venti, tra uomini e donne, si
intromettevano nella discussione.
«Se dovessero insorgere divergenze sui posti a sedere, siete
pregati di chiamare il personale di cabina» disse un’assistente di
volo dagli altoparlanti, ma a nessuno venne in mente di farlo.
Stretta com’ero tra caffetani e gonne di cotone, non potevo far
altro che seguire l’avanzata a singhiozzo nel corridoio. Una
hostess si fece largo nella fiumana di corpi volgendo gli occhi al
cielo.
Al mio posto, il 17F, trovai seduta un’imponente donna di mezza
età con indosso un vestito lilla.
«Ci deve essere un errore, questo è il mio posto» dissi allora in
russo.
«Non vorrà separare tre sorelle?» ribatté la donna indicando
con un cenno del capo le altre due matrone che occupavano i
sedili vicini. Si assomigliavano molto. E tutte e tre mi fissavano
con attenzione.
Tirai fuori la mia carta d’imbarco e indicai il numero guardando
il sedile. «Quello è il mio posto» spiegai.
«Non vorrà separare tre sorelle» ripeté lei.
«E dove mi dovrei sedere, allora? Come le ho detto, quello è il
mio posto.»
«Può sedersi là» disse allora indicando un sedile libero davanti
a noi. Appena aprii bocca per protestare di nuovo, lei mi fissò con
uno sguardo che diceva: «Non vorrà separare tre sorelle?»
«Non è accanto al finestrino» brontolai sedendomi obbediente
al posto che mi aveva indicato quella donna imponente. Non
volevo certo separare tre sorelle. E, soprattutto, non volevo
trovarmi seduta per quattro ore accanto a due di loro. Quando
arrivò il legittimo possessore del sedile a cui ero stata indirizzata,
gli dissi di rivolgersi alle tre sorelle dietro di me. L’uomo rinunciò
subito a qualsiasi tentativo di negoziazione e andò a cercarsi un
posto più avanti. Nel momento in cui l’aereo si avviava verso la
pista di decollo, quattro uomini sfrattati vagavano ancora per il
corridoio alla ricerca di un posto libero.
Di solito mi addormento non appena le ruote si staccano dalla
pista, ma questa volta non riuscii a chiudere occhio. Il mio vicino
puzzava di alcol vecchio e schioccava forte le labbra nel sonno. La
donna statuaria seduta accanto al finestrino premeva con
impazienza lo schermo che aveva davanti. Anche se non trovava
nulla di suo gradimento, non si arrendeva e continuava a pigiare
seccata.
Per ingannare il tempo sfogliai il piccolo e grazioso dizionario
di turkmeno che avevo portato con me. Per le lingue parlate negli
altri quattro paesi che avrei visitato, esistevano voluminosi corsi
fai-da-te completi di libri di testo, quaderni degli esercizi e DVD, e
in un attacco di presunzione avevo comprato tutto quanto. Ma per
la lingua turkmena avevo trovato solo quel modesto volumetto che
era per metà un dizionario, per metà un manuale di
sopravvivenza. La seconda parte era dedicata a espressioni utili,
quali: «Sei sposata?» «No, sono vedova.» «Non capisco, per
favore, parla più lentamente.» Un po’ alla volta l’autore
presentava al lettore situazioni e problemi che si sarebbero potuti
verificare durante un viaggio in quel paese: «Quante ore di ritardo
ha l’aereo?» «Funziona l’ascensore?» «Per favore, rallenti!» Il
paragrafo sugli alberghi era motivo di preoccupazione: «Il WC è
intasato.» «Manca l’acqua.» «È andata via la corrente.» «Non c’è
gas.» «È impossibile aprire/chiudere la finestra.» «L’aria
condizionata non funziona.» Da queste problematiche generali ma
innocue, l’autore passava poi ad affrontare una serie di possibili
situazioni critiche, da «Al ladro!» e «Chiamate un’ambulanza!», a
espressioni di pubblica utilità come «Non sono stato io!» e «Non
sapevo che non si potesse fare!» Verso la fine un breve ma
importante capitolo affrontava l’argomento «Checkpoint».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





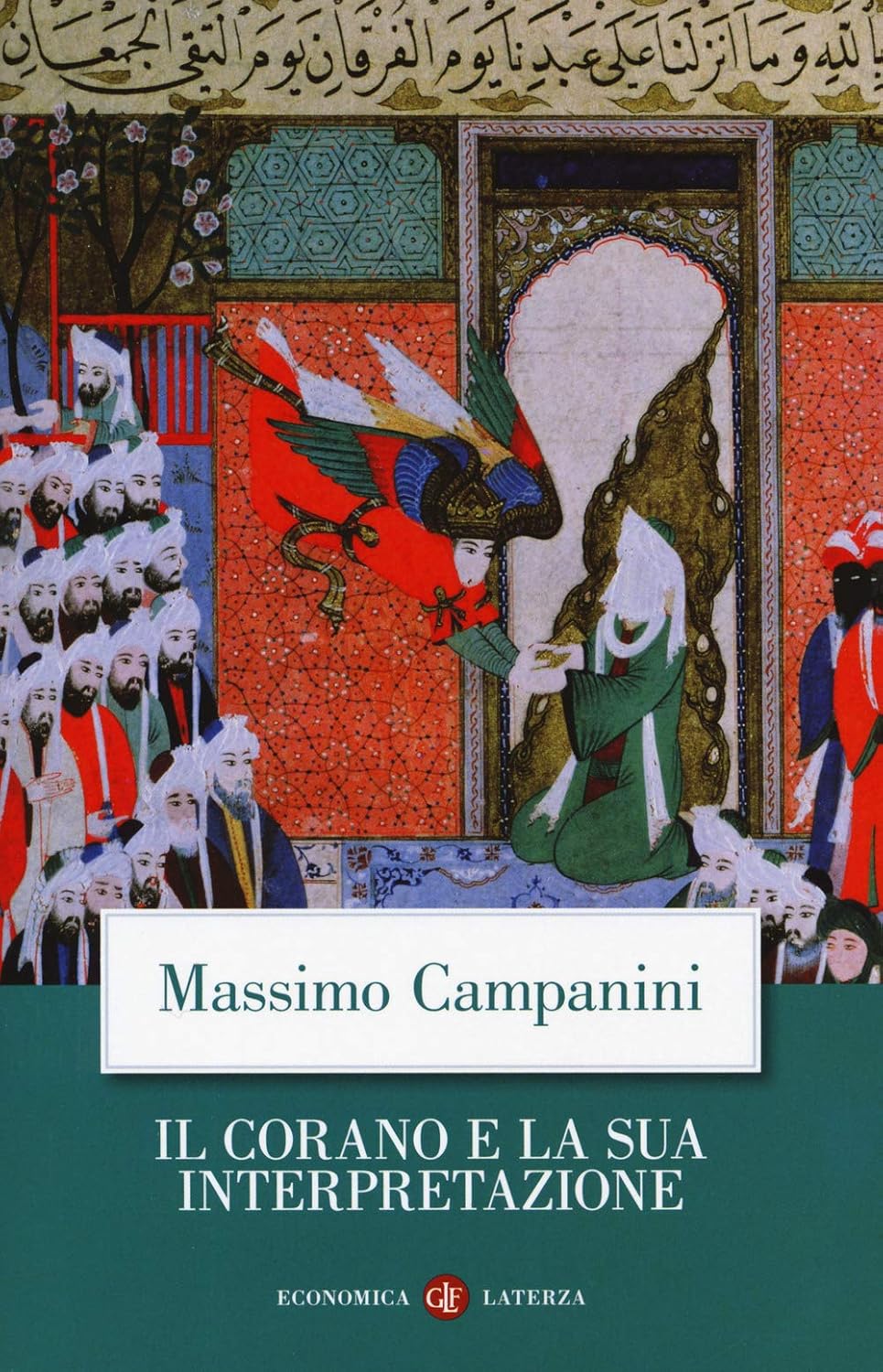
Commento all'articolo