Sherlock, Lupin & Io – Doppio finale – Irene Adler
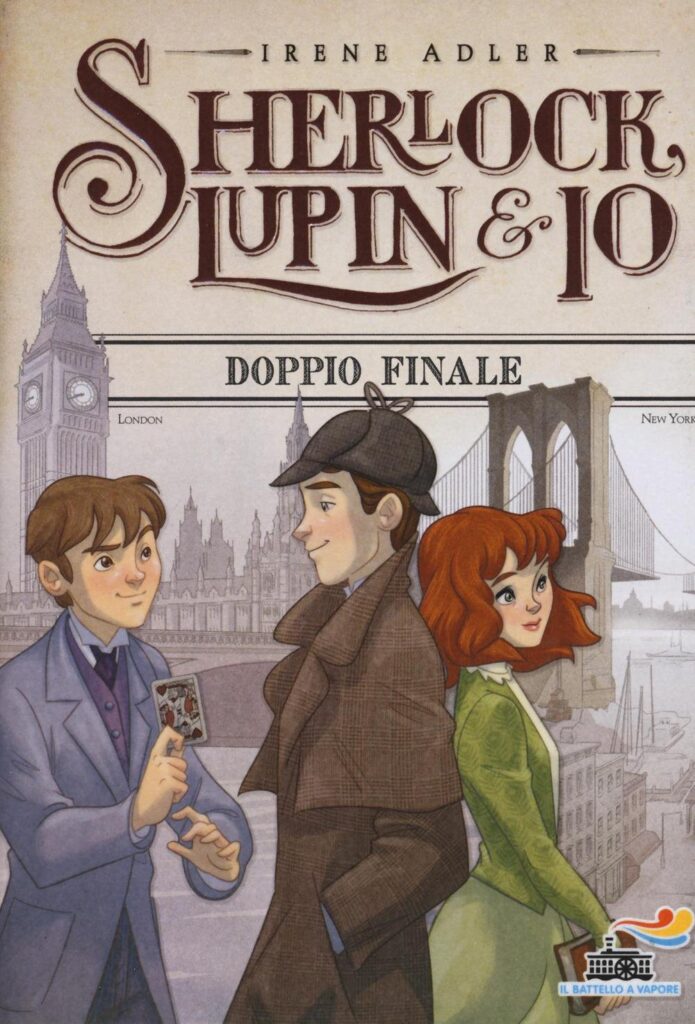
SINTESI DEL LIBRO:
I ricordi sono una cosa strana. A volte si rincorrono e si inanellano come le
strade in una passeggiata senza meta, alla fine della quale si scopre di essersi
diretti fin dall’inizio in un luogo amato. Se mi guardo indietro, ora che sono
ormai certa di avere lasciato più giorni alle mie spalle di quanti possa vederne
davanti a me, mi accorgo di una semplice e limpida verità.
Nella mia vita ho amato poche persone, ma molti luoghi.
Amare i luoghi non è semplice. Anche perché spesso vuole dire avere
lasciato quelli precedenti, e avere permesso che ci spezzassero il cuore. Un
luogo nuovo però è sempre un mistero da scoprire, una mappa di opportunità
da esplorare, un universo brulicante di vita e di storie. Molta gente attraversa
gli stessi luoghi giorno dopo giorno, o al contrario viaggia per il mondo
intero, sempre a testa bassa, senza vedere, senza guardarsi attorno davvero,
senza lasciarsi permeare e contaminare. Senza vivere davvero. Io no. Io posso
dire di avere vissuto molto, e di avere lasciato la mia ombra, il mio tocco, la
mia impronta ovunque andassi. Se c’è una cosa di cui posso essere fiera è di
avere sempre cercato di lasciare un segno, di farmi coinvolgere. Anche se
questo non è sempre stato un bene per le persone che la vita ha messo sulla
mia strada.
Perché con le persone è ancora più difficile e, come dicevo, non ne ho
amate molte. In pochi possono dire di avermi conosciuta davvero, e a volte il
segno che ho lasciato è stato più simile a un marchio, o a una cicatrice. I più
importanti, quelli che maggiormente mi hanno permesso di diventare chi
sono, già li conoscete, visto che il loro passaggio in questo mondo è ormai
leggenda. Ma mettere ancora una volta i loro nomi sulla carta, dopo quello
che è accaduto fra noi, mi causa sempre un brivido. Sherlock Holmes e
Arsène Lupin. Alcuni direbbero che è stato il destino a farci incontrare.
Il fatto è che io non credo al destino.
La verità è che esiste sempre una scelta, per quanto dolorosa, difficile,
folle o disperata. Le radici possono essere recise, i nomi buttati in mare, il
futuro cambiato. Basta volerlo, e prepararsi ad affrontarne le conseguenze.
Io lo so bene, credetemi. Sono nata principessa e sono cresciuta ribelle. Ho
avuto tre nomi, più una miriade di identità fittizie create nello spazio di un
battito di ciglia. Ho tradito i miei amici Sherlock e Arsène, abbandonandoli a
loro stessi e sapendo che se la sarebbero comunque cavata in qualche modo,
anche senza di me. Ho vissuto fra due continenti e mi sono fatta guidare
sempre da una sola bussola, dalla mia personale stella polare: il desiderio di
libertà.
Le mie sembreranno forse le farneticazioni sconnesse di una donna
eccentrica in vena di fare una passeggiata nel passato, ma il fatto è che questi
diari sono l’unica traccia di chi io sia veramente.
Maria.
Irene.
Agnès.
E ora farete la conoscenza di quest’ultima.– Agnès! Agnès! – esclamava spesso la nostra nuova cameriera, la signora
O’ Malley. E non sempre mi voltavo subito, soprattutto durante i primi tempi
a New York.
È comprensibile, dato che ancora facevo fatica a riconoscermi in quel
breve suono. L’avevo scelto io, a differenza di Maria, il nome datomi da mia
madre, e di Irene, l’identità sotto la quale ero stata cresciuta dai coniugi
Adler. La prima cosa che avevamo fatto io e mia madre Sophie, dopo essere
scappate con mille sotterfugi dal complotto politico che puntava a mettere
me, figlia segreta del principe Felix von Hartzenberg, sul trono di Boemia,
era stato cambiare nome. Sul ponte dell’Atlantic, la nave che ci avrebbe
portate verso la nostra nuova vita in America, un po’ ridendo e un po’
piangendo avevamo deciso che saremmo diventate Agnès e Pauline de
Givencourt. Grazie al preziosissimo aiuto del mio adorato padre adottivo
Leopoldo Adler, avevamo potuto prendere possesso di un cospicuo
patrimonio messo a nostra disposizione dai ribelli fedeli alla casata dei von
Hartzenberg. Certo, non era stato esattamente onesto da parte nostra usare i
loro soldi per mandare a monte il loro stesso piano, ma dopotutto avevano
cercato di imprigionarmi in un ruolo che non desideravo affatto. Dopotutto,
se si fossero fermati anche solo un istante a chiedere il mio parere invece di
trattarmi come una marionetta vestita da principessa, si sarebbero risparmiati
molti crucci. Leopoldo, che al contrario aveva sempre avuto molto a cuore la
mia opinione e la mia felicità, aveva fatto in modo che un banchiere
americano compiacente ci permettesse di accedere a quel piccolo tesoro.
Nulla di eccessivamente principesco, ma era sufficiente per vivere in modo
assai agiato, senza sfarzo ma con tutte le comodità. Nella nostra graziosa casa
al numero 14 di Gramercy Park, io e mia madre avevamo una carrozza e una
persona di servizio a tempo pieno, la già menzionata signora O’ Malley.
Durante le mie peripezie, soprattutto nell’ultimo anno, avevo un po’
trascurato la mia educazione, ma a New York Sophie, o forse dovrei dire
Pauline, mi aveva trovato un ottimo precettore. E avevo anche ripreso le
lezioni di canto, con estrema gioia e molto profitto.
New York mi era piaciuta subito, così viva e complessa, piena di fascino e
pericolo e grandi opportunità.– La Terra Promessa! Ve lo dico io, signorina! Non come quel postaccio
malefico da cui siete venuta via voi! Malefico! – esclamava spesso la signora
O’ Malley, facendosi poi il segno della croce. Era un’irlandese fiera e vivace,
con una chioma chiara e un po’ stopposa e la pelle diafana. Più che parlare, la
signora O’ Malley esclamava, declamava, sbottava e vociava. Ce l’aveva a
morte con gli inglesi e l’Inghilterra, e aveva subito riconosciuto il mio
accento come quello del nemico. Eppure, incontrandoci come esuli, scappate
da una situazione su cui eravamo state vaghe, ma di cui portavamo evidente il
peso nel cuore, ci eravamo subito piaciute. Certo, la signora O’ Malley non
somigliava per nulla alle cameriere alle quali ero abituata, ma i suoi modi
spicci mi parevano portare una ventata di freschezza tipica del nuovo mondo.
Mi stavo già innamorando di quel posto, con la sua sfacciataggine, i suoi
teatri di Union Square e quelle pazze rappresentazioni che erano le musical
comedy, così diverse dalla mia amata opera.– Siete ancora lì a cincischiare?! Vi ho lustrato le scarpe. E la carrozza…
la carrozza aspetta da così tanto che il cavallo dorme in piedi. In piedi, vi
dico! – sbraitò la signora O’ Malley in quel giorno che ricordo come fosse
ieri, comparendo sulla soglia della mia camera con la cuffia sulle ventitré e i
miei stivaletti in mano, lucenti e immacolati. Io stavo finendo di
abbottonarmi il vestito, e sebbene non vedessi l’ora di uscire, mi accorsi che
il tremito nervoso delle mie dita aveva finito per rallentare i preparativi.– Vado, vado! – risposi ritrovando il sorriso e agguantando gli stivaletti.
Con lei si finiva per ripetere tutto due volte…– E la vostra musica? – mi disse agitando con malagrazia una manciata dei
miei preziosi spartiti, che avevo lasciato incautamente sparpagliati sullo
scrittoio.– Non mi servono, oggi – risposi con un sogghigno da cospiratrice. – Sto
andando a un altro genere di appuntamento!
Le feci l’occhiolino, e la signora O’ Malley si segnò nuovamente.– Benedetta ragazza, che non sia quel tipo di appuntamento! – rispose
alludendo a un qualche coinvolgimento romantico, cosa secondo lei
estremamente sconveniente prima dei diciassette anni come minimo.
Ovviamente l’avevo fatto per stuzzicarla, e non era affatto quel tipo di
appuntamento. Ma devo ammettere che non c’era nulla in quel momento che
potesse farmi battere il cuore più di ciò che stavo per affrontare. Salutai mia
madre, che mi attendeva di sotto, con un bacio sulla guancia e un cenno di
muta rassicurazione, e uscii.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :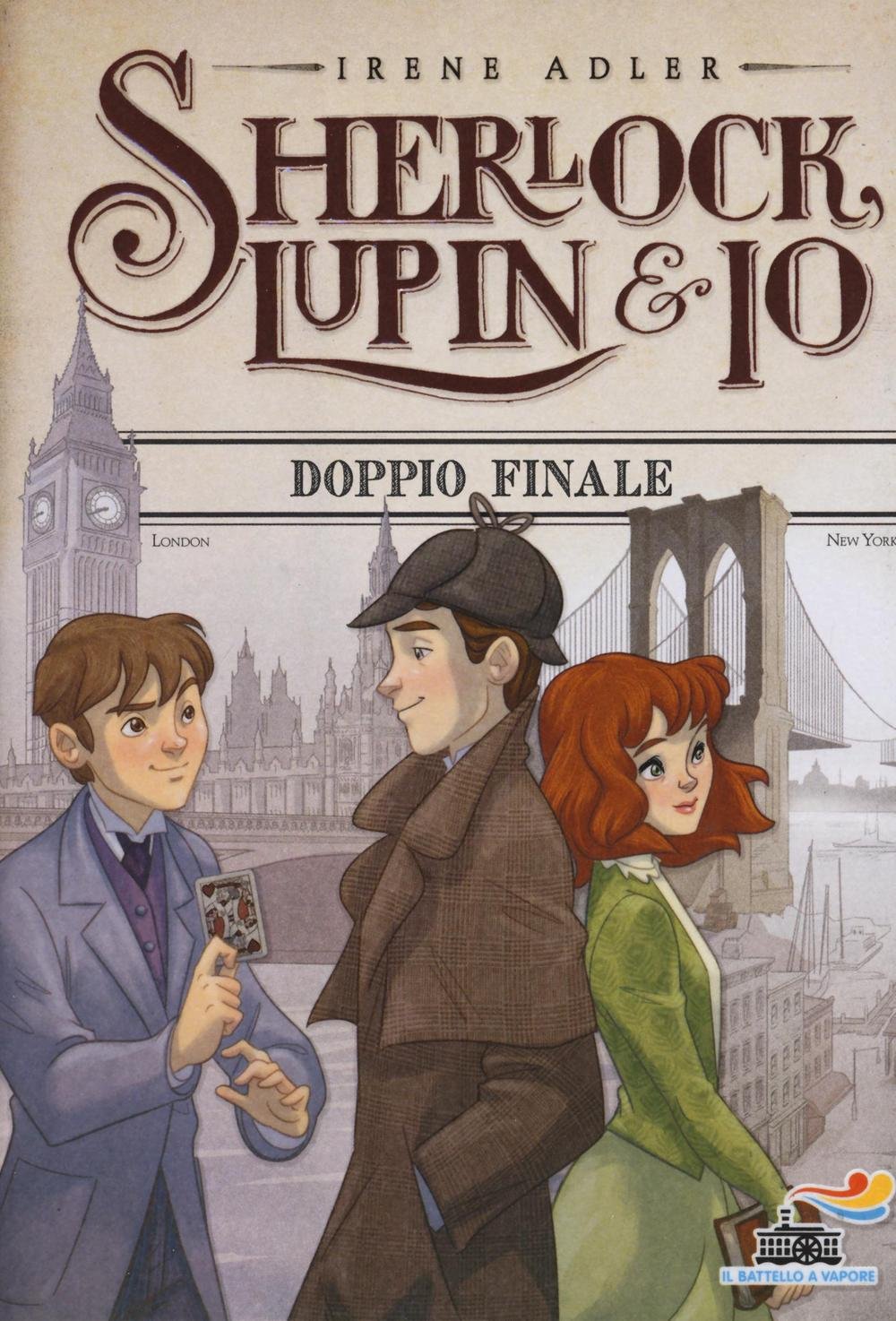






Commento all'articolo