Selfie – Sentirsi nello sguardo dell’altro – Giovanni Stanghellini
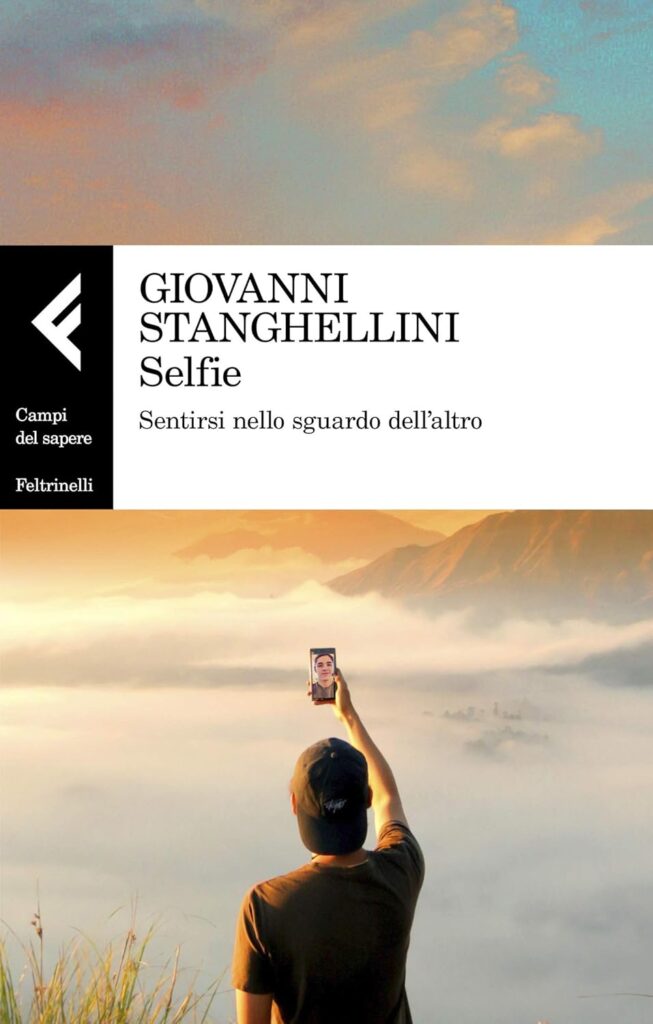
SINTESI DEL LIBRO:
Si parla di ciò che è assente. Per questo, forse, si fa un gran
parlare del corpo.
Le filosofie e le pratiche del corpo che annunciano la tarda
modernità si caratterizzano, sebbene in maniera contraddittoria, per
l’affermazione del primato del corpo. A partire dagli anni sessanta, la
cosiddetta “rivoluzione sessuale” e la body art, la liberazione del
corpo e i suoi slogan – “Il corpo è mio e lo gestisco io!” – colgono sul
nascere la genesi di questa assenza. Candidamente, a qualcuno
sarà venuto in mente di chiedersi: “E di chi può essere il mio corpo
se non mio? E a chi tocca gestirlo se non a me?”. Domanda
effettivamente ingenua, se si tiene conto della natura chiasmatica
del corpo (ma di questo ci occuperemo più avanti). Un bambino,
forse a causa del rapporto innocente con il suo corpo, avrà pensato
che le persone arrabbiate che scandivano quel motto si rivolgessero
a qualcuno che voleva prendersi il loro corpo. E forse non a torto:
“Giù le mani dal mio corpo!”, “Il corpo è mio e non altrui, non
dell’altro” è il significato più elementare di quella frase. Un significato
che punta il dito contro chi vuole espropriare il corpo altrui: il potere,
la Legge, la tradizione, gli adulti, il maschio ecc. Il discorso dell’altro,
la sua violenza, stia alla larga dal mio corpo.
Però, come non riconoscere che in quella frase, altrimenti così
legittima da sfiorare la banalità, risuonava un’eco sinistra: affermare
che il mio corpo è mio e non dell’altro non allude, forse, a un dubbio,
a un’incertezza? “Questo corpo è davvero il mio?” Non sarà, per
caso, che chi ritmava quello slogan si sentiva sfuggire di mano il
proprio corpo? E non solo per la prepotenza altrui, ma pure per un
legame con il proprio corpo che si stava facendo più tenue sua
sponte, a prescindere dall’atteggiamento dispotico dell’altro? Ossia a
causa di un’incipiente depersonalizzazione somato-psichica, di
un’iniziale ma non per questo meno perturbante scissione tra corpo
e Sé, come direbbe uno psichiatra. A ragione, cioè, di una specie di
deriva del corpo proprio, che al pari di una maionese impazzita
cessa di porsi come un indiscernibile rispetto al Sé.
Se questo fosse vero, puntare il dito contro l’altro, accusandolo di
voler confiscare il mio corpo, sarebbe solo un puerile meccanismo di
difesa, una proiezione sull’altro della responsabilità di un processo
del quale sfugge la causa, o la ragione. Ciò che non si vuole
riconoscere è che il mio rapporto con il mio corpo sta andando in
pezzi, il rapporto spontaneo, immediato, ingenuo di identificazione
con il mio corpo sta svanendo. In questa luce, “Il corpo è mio e lo
gestisco io!” è un grido di dolore, non di accusa.
Ma ci sarà pur un colpevole? O almeno una causa, qualcosa o
qualcuno cui imputare la dissolvenza del corpo? Sul banco degli
imputati non siede il Potere nelle sue forme autoritarie e repressive,
bensì il volto autorevole e rassicurante della Scienza. La
biomedicina promette salute e benessere, ma a un patto: che si
accetti che il corpo sia una cosa in sé, alla stregua di un oggetto, un
insieme di organi e funzioni da indagare oggettivamente, ovvero a
prescindere dalla persona, che cessa di essere quel corpo e diventa
invece colui che ha quel corpo. La cura di questo corpo diviene così
un gesto puramente tecnico che si occupa di un oggetto separato
dalla persona. Non si smette di contestare alla tecnica l’esigere che i
suoi utenti contraggano una specie di patto col diavolo: metti nelle
mie mani ogni pretesa di sapere sul tuo corpo, e in cambio avrai
lunga vita. La tecnica non chiede espressamente, come gli antichi
sovrani, il potere sul corpo, ma una delega circa il sapere. L’effetto,
al netto degli incontestabili vantaggi, è ancora più pervasivo perché
la promessa è allettante: “Lascia a me il sapere sul tuo corpo, a te
rimanga tutto il resto”.
Ma quale resto? Cosa mi resta se lascio ad altri il sapere sul mio
corpo? E che tipo di sapere è questo sapere che studia il mio corpo
dall’esterno, e deliberatamente sorvola sul modo in cui io sento il mio
corpo? Un sapere fondato, come scrive Foucault, sulla
trasformazione della domanda che il medico pone al suo paziente:
da “Come stai?” a “Dove ti fa male?”. Una domanda, dunque, che
trasferisce conoscenza e potere dal sentire del paziente allo sguardo
del medico. Il sapere sul corpo transita dalla cenestesi allo sguardo.
C’è un nesso tra la metamorfosi del rapporto con il proprio corpo e la
trasformazione della cura di sé promossa della medicina. “Bisogna,
per quanto possibile, rendere la scienza oculare,” dichiara
solennemente M.-A. Petit.
1 Siamo in piena epoca dei Lumi. La clinica
medica viene a costituirsi sulla base del paradigma della sovranità
dello sguardo. “La clinica,” scrive Foucault, “costituisce il primo
tentativo dopo il Rinascimento per fondare una scienza sul solo
campo percettivo e una pratica sul solo esercizio dello sguardo […] è
lo sguardo medico a dischiudere il segreto della malattia ed è questa
visibilità a rendere la malattia penetrabile alla percezione.”
2
La natura della biomedicina, ribadisce Deleuze, è essere una
“macchina ottica”. Il sottotitolo di Nascita della clinica poteva essere
“Archeologia dello sguardo” proprio perché la cura medica modula
una luce e costituisce uno spazio di visibilità della malattia, facendo
“scintillare” i sintomi per dare all’occhio la profondità e al male un
volume.
3
Si obietterà che i critici della tecnica esagerano. La tecnica non è
malvagia, aiuta a vivere meglio e più a lungo, non intende
espropriare la vita. Eppure… la domanda ronza e rimbomba: “Cosa
mi resta?”. Andiamo per esclusione: anche se cedo ad altri il sapere
sul mio corpo mi resta il vivere, ovviamente. Cioè mi restano i miei
legami affettivi, le mie relazioni, le mie emozioni, i miei desideri, le
mie pulsioni. Verissimo, a patto che la tecnica – adducendo a
pretesto la mia salute e il mio benessere, la prevenzione e
l’ottimizzazione – non voglia appropriarsi anche di questi. Non
tramite un esproprio, ma per delega. Una delega sottoscritta dal
delegante, ovvero tutti noi (o la maggior parte). Dapprima
consigliando, poi regolando, normando, infine prescrivendo,
proscrivendo ecc., la biomedicina prende possesso del mio corpo.
Affinché il corpo non abbia a soffrire, la cura del corpo è soggetta a
una delega. “Il corpo è tuo ma lo gestisco io”: un sussurro
persuasivo, non un ordine stentoreo.
Il
discorso della biomedicina (il corpo come cosa in sé, luogo
esclusivo della scienza in quanto conoscenza oggettiva e
oculocentrica, e della cura intesa in senso esclusivamente tecnico)
trova dunque un inatteso punto di contatto con lo slogan libertario
che sembra ergersi a difesa della proprietà del corpo, ma sottilmente
(e inconsapevolmente) denuncia la deriva del corpo verso la sua
oggettualizzazione. Questi due discorsi si toccano in quanto
l’oggettualizzazione del corpo perorata dalla biomedicina si pone, se
non a causa, almeno a supporto della deriva del corpo denunciata
dalle filosofie della corporeità.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :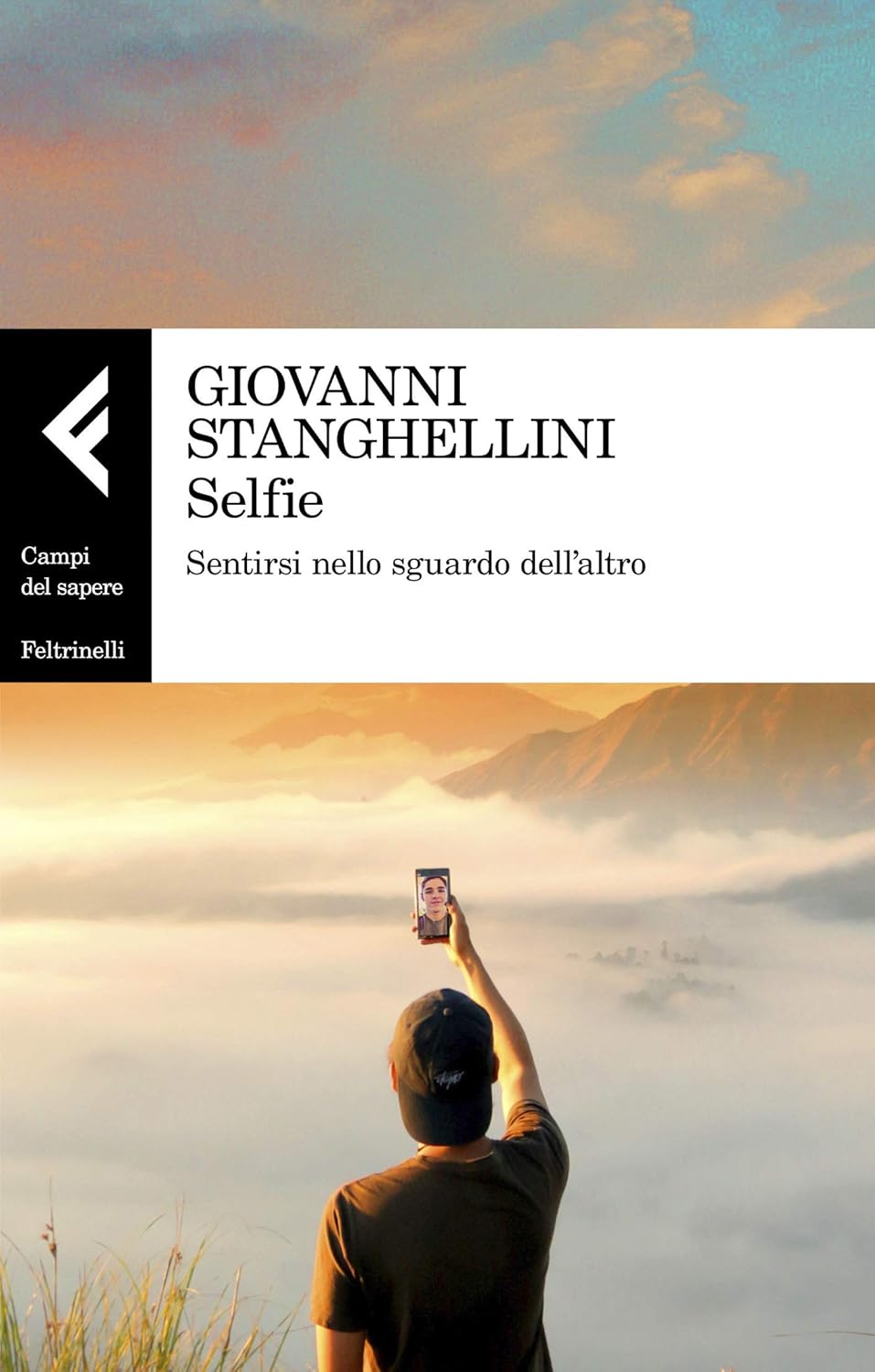






Commento all'articolo