Ricominciare dalla scienza – 10 ragioni per affidarsi alla ricerca quando il resto ci abbandona – Guido Silvestri
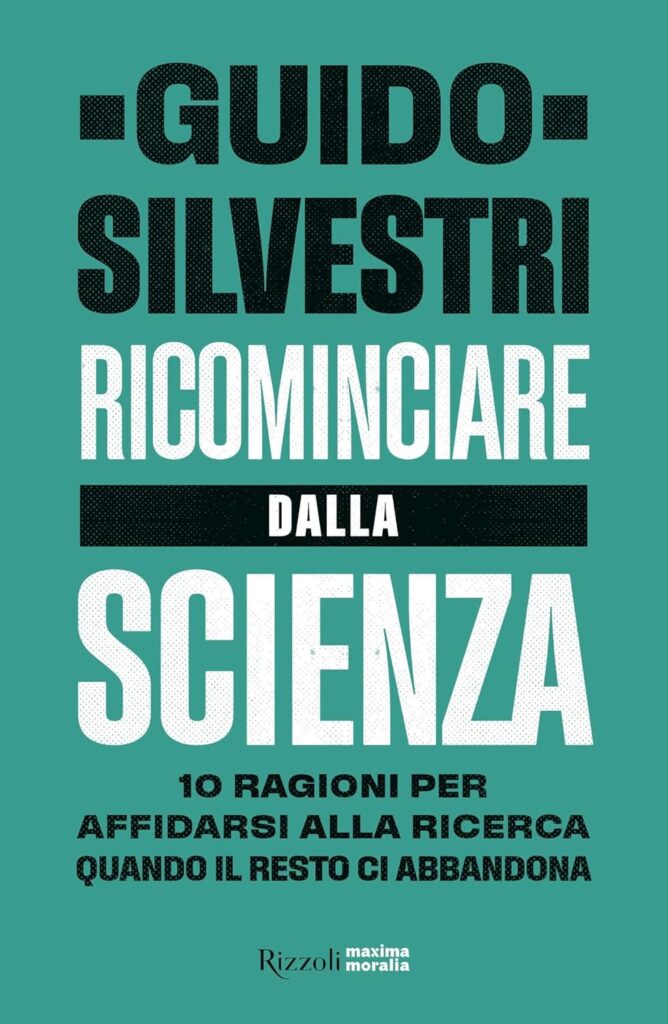
SINTESI DEL LIBRO:
Dacci oggi il nostro panico quotidiano
Nei mesi cruciali dell’emergenza Coronavirus, quando tu o il
mondo si è fermato per rallentare la diffusione dei contagi e le
piazze delle ci à, prima brulicanti di vita, sono diventate non luoghi
deserti e spe rali, abbiamo assistito a uno dei paradossi tipici della
nostra epoca, contro il quale gli esperti di comunicazione ci avevano
già messo in guardia: vivere in una società sempre più connessa,
dominata da Internet e governata dai Big Data è certamente una
straordinaria opportunità ma anche un rischio. All’inizio tu o
sembra magnifico. Basta un clic e davanti ai nostri occhi, sul monitor
di un computer o sullo schermo di uno smartphone, si spalanca
l’intero scibile umano. Eppure, ecco il paradosso, è proprio questo
eccesso di notizie a disorientare. L’accumulo compulsivo di
informazioni, sopra u o se generato dall’ansia e dalla paura,
provoca una specie di cortocircuito. E in condizioni di eccezionalità
come quelle che si sono venute a creare dopo lo scoppio della
pandemia, spesso è bastata una scintilla – una semplice fake news
a far divampare un incendio.
Abbiamo imparato, per esempio, che anche dalla bocca di un
personaggio come Luc Montagnier – premio Nobel nel 2008 insieme
alla collega immunologa Françoise Barré-Sinoussi per aver scoperto
nel 1983 il virus dell’HIV – possono uscire dichiarazioni pericolose. Il
caso è noto: in un’intervista di metà aprile al sito Pourquoidocteur.fr
il virologo francese aveva sostenuto che il nuovo Coronavirus SARS
CoV-2 fosse stato fabbricato in laboratorio a partire da quello
dell’AIDS. Peccato che uno studio sistematico delle sequenze
genetiche di SARS-CoV-2 (Andersen K.G. et al., «Nature Medicine»,
2020), pubblicato il 17 marzo, avesse già dimostrato che il virus ha
una origine naturale e zoonotica (da animali, e in particolare
pipistrelli e pangolini). Il fa o poi che la «bufala» del virus uscito
accidentalmente da un laboratorio di Wuhan sia stata rilanciata
anche in seguito dal segretario di Stato USA Mike Pompeo – per
ragioni più politiche che scientifiche – è un altro discorso…
A dire il vero, il caso Montagnier e i numerosi altri episodi di fake
news che si sono registrati in questi mesi, e che i media, molto
spesso, non hanno esitato a rilanciare, vanno tra ati con la massima
a enzione perché sono indicativi di un problema piu osto serio, ben
sintetizzato dalla domanda che il filosofo e professore di Scienze
cognitive Alvin Goldman si era posto nel 2001 in un suo celebre
articolo: Di quali esperti possiamo fidarci? Se lo sono chiesti anche
parecchi ci adini italiani durante le lunghe se imane del lockdown,
dopo essere stati travolti da un sovraccarico di notizie
pseudoscientifiche e allarmismi infondati. È in situazioni come
queste, di vera e propria «infodemia», che il problema sollevato da
Goldman mostra tu a la sua a ualità. Se due o più esperti si trovano
in disaccordo, come fa la persona comune a stabilire chi ha ragione?
E se un esperto avanza una teoria che «sembra» smentire quella
accreditata da tu i i suoi colleghi? Più in generale, come facciamo a
considerare credibili le informazioni di cui disponiamo? Goldman ci
viene in qualche modo in soccorso, suggerendo un metodo basato su
cinque punti, che non risolve tu o ma che, per comodità di analisi,
possiamo considerare simile a un procedimento di fact
checkingpiu osto utile. In sostanza, è sempre bene:
valutare con a enzione gli argomenti che l’esperto presenta per sostenere
le proprie opinioni e per criticare quelle dei suoi «rivali». Sembra una
banalità ma non lo è. Il primo passo da compiere, infa i, è concentrarsi
sul contenuto dell’argomento e non soltanto sulla risonanza che ha
riscosso in televisione, sui giornali, su Internet o, peggio ancora, sui social
network. Ci sono buone probabilità che, così facendo, ognuno di noi, da
profano, possa farsi un’idea più precisa e circostanziata del tema intorno
al quale gli esperti stanno discutendo. È già qualcosa, no?
verificare se tra gli esperti vi è un sostanziale accordo sulla materia in
questione o meno. Qui basta un po’ di buon senso e di intelligenza
intuitiva. Se la stragrande maggioranza della comunità scientifica
converge su una certa posizione, forse conviene non dico escludere a
priori, ma prendere con le molle la proposta del singolo esperto che
proclama di andare così controcorrente da rivoluzionare il futuro della
medicina o svelare un segreto che, chissà perché, nessuno vorrebbe
rendere noto tranne lui. Qui a giocare un ruolo determinante sono, per
esempio, la reputazione e l’affidabilità scientifica delle riviste sulle quali
l’argomento «bomba» dell’esperto viene proposto. Pubblicare un articolo
senza peer review (vale a dire senza so oporlo alla valutazione degli
specialisti) oppure farlo su un giornale di provincia anziché su «The
Lancet» o «Nature» ha la sua rilevanza. Insomma, è buona regola
incrociare sempre più fonti e concedersi un supplemento di indagine.
Farlo su Internet non porta via così tanto tempo. Sempre meno di quello
che la maggior parte delle persone dedica alle stories di Instagram…
controllare in che modo la comunità scientifica valuta la competenza
dell’esperto: in questo caso possono esserci d’aiuto il suo curriculum, le
istituzioni medico-scientifiche alle quali è affiliato, la credibilità di cui
gode presso il mondo accademico ecc.
verificare se esiste un confli o di interessi dell’esperto sull’argomento che
ha deciso di tra are;
esaminare i precedenti dell’esperto, che può aver contributo in maniera
significativa a una importante scoperta scientifica in gioventù, oppure in
un’altra fase della sua carriera, ma essersi poi indirizzato verso
improbabili orizzonti di ricerca o aver dato credito a pratiche cliniche o
farmacologiche di non comprovata efficacia.
Nel caso della pandemia provocata da SARS-CoV-2 gli scienziati,
va de o, hanno provato a informare la popolazione sul nuovo virus.
Non è stato semplice, perché la situazione evolveva rapidamente
so o il profilo epidemico e anche diagnostico, non tu i i dati a
disposizione erano affidabili e la loro interpretazione non sempre si
rivelava univoca. Il fa o è che su questa base di inevitabile
incertezza, che richiedeva una buona dose di prudenza, si sono
bu ati a capofi o i «virologi della domenica» e gli ospiti fissi dei talk
show, abilissimi nel dare credito ai complo ismi più demenziali. La
sensazione, non piacevole, è stata quella di una «guerra tra esperti»
che, il più delle volte, esperti non erano.
Ricordate, per esempio, la vicenda dei pazienti coreani guariti dal
COVID-19 che si ammalavano di nuovo? Anche in quel caso si sono
ignorate bellamente tu e le considerazioni fa e dalla comunità
scientifica a proposito delle differenze conce uali tra «reinfezione» e
«guarigione virologica ritardata» (su cui è intervenuto anche Jean
François Delfraissy, il consigliere speciale di Macron per COVID-19).
Non solo. Proprio lo studio coreano ha dimostrato che in alcuni casi
la «guarigione virologica» è più lenta di quella clinica, il che non
rappresenta di per sé una grande sorpresa. Ciononostante, la
«macchina del panico» ha insinuato che le persone potessero
ammalarsi più di una volta (e che di fa o non via sia un’immunità
contro COVID-19). Peccato che, per parlare di vera e propria «seconda
mala ia», occorre soddisfare le seguenti condizioni: un paziente
guarito, ossia risultato più volte negativo al tampone e con anticorpi
IgG nel sangue contro SARS-CoV-2, torna ad accusare una
sintomatologia tale da essere ricoverato in ospedale e in cui si
dimostra che è stato infe ato – ecco il punto essenziale – da due
varianti diverse del virus. C’è una bella differenza dal dire che chi
guarisce si riammala, non vi sembra?
Non a caso, dopo oltre cinque milioni di casi di COVID-19 al
mondo non c’è ancora, che io sappia, un solo paziente che soddisfi
questa definizione di reinfezione. Spesso all’origine di queste
«notizie» che avrebbero dovuto sconvolgere tu o ciò che sapevamo
di virologia e immunologia si diceva ci fossero non meglio precisate
«fonti sanitarie.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :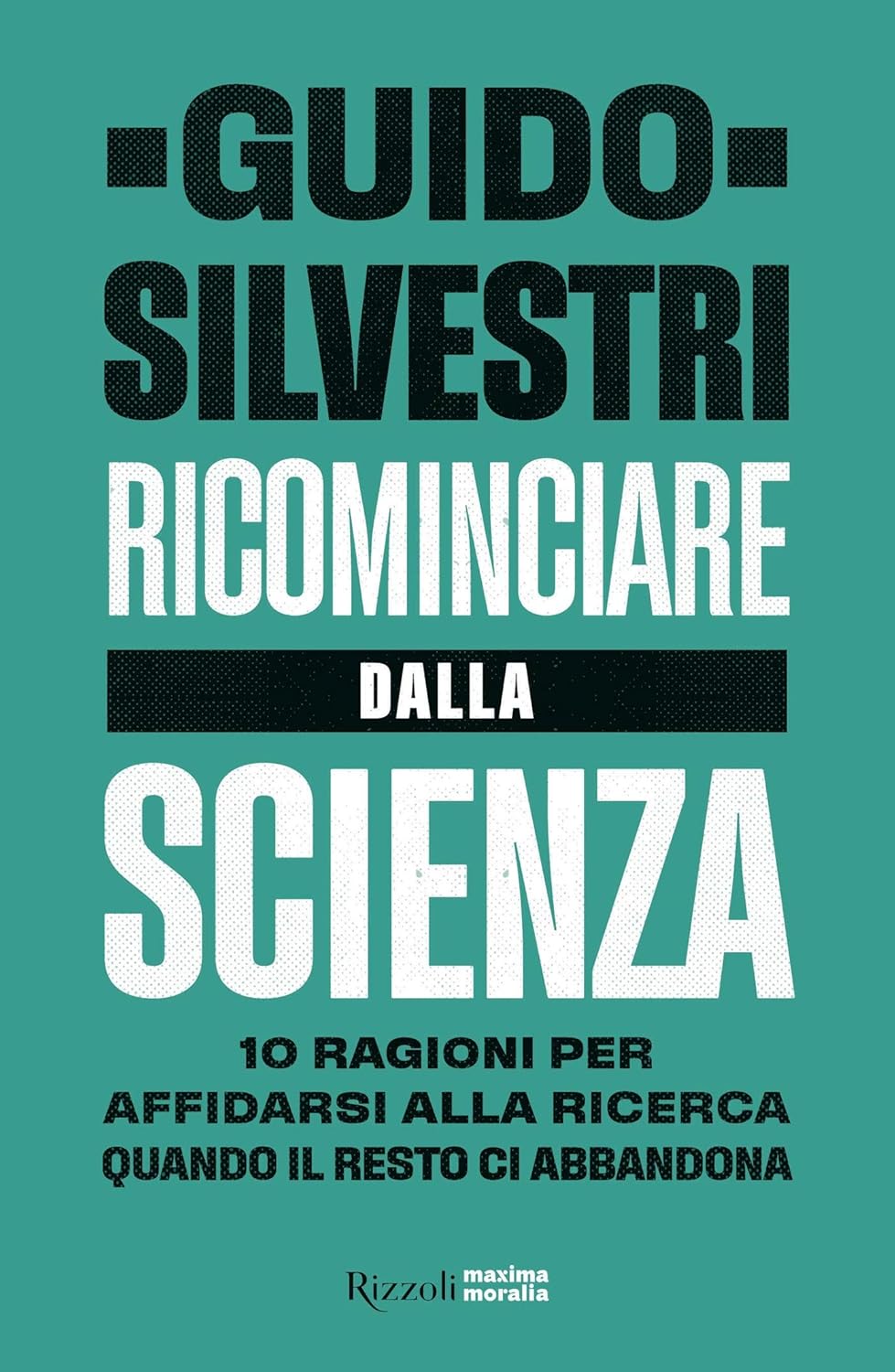




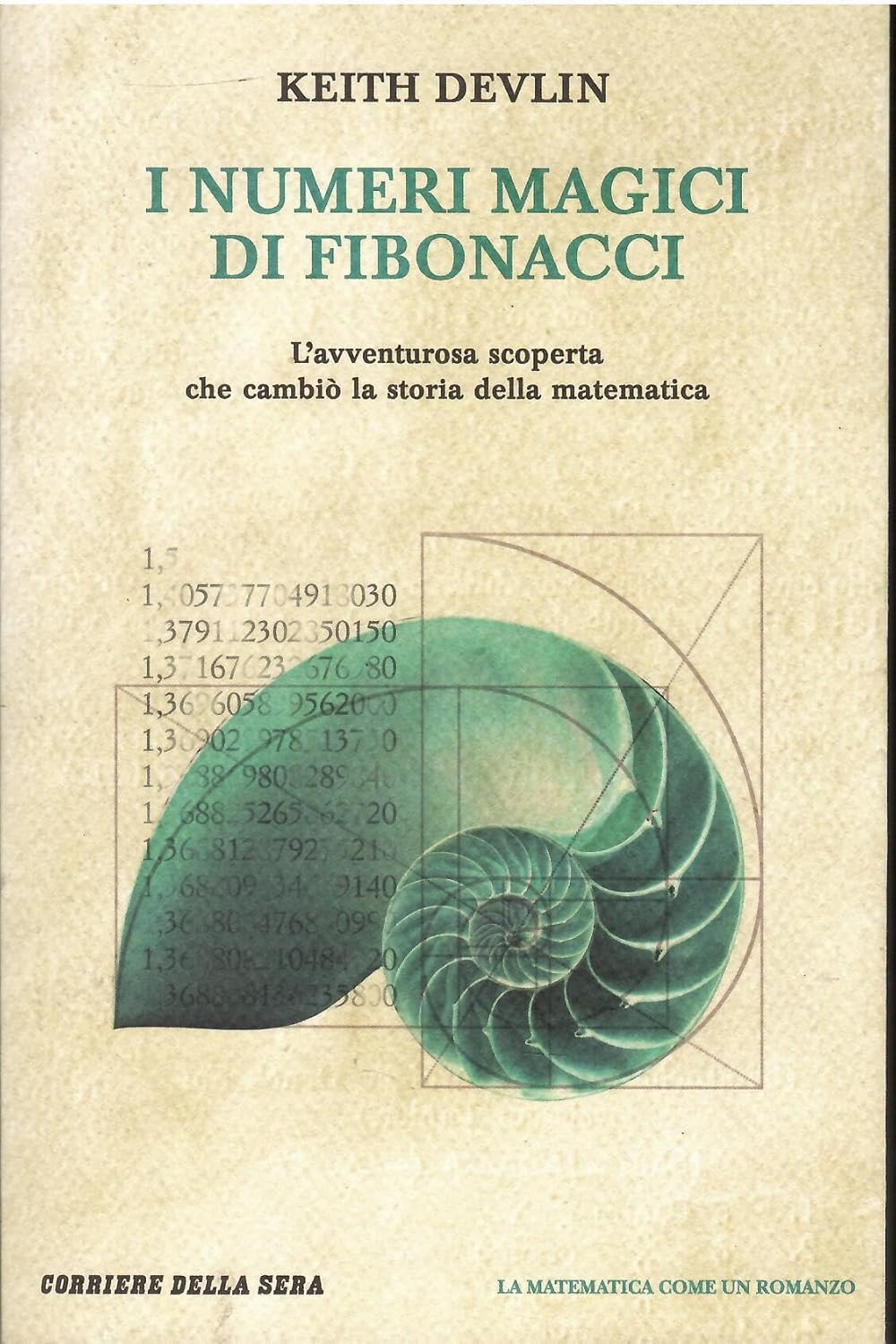

Commento all'articolo