Ricordati di Bach – Alice Cappagli
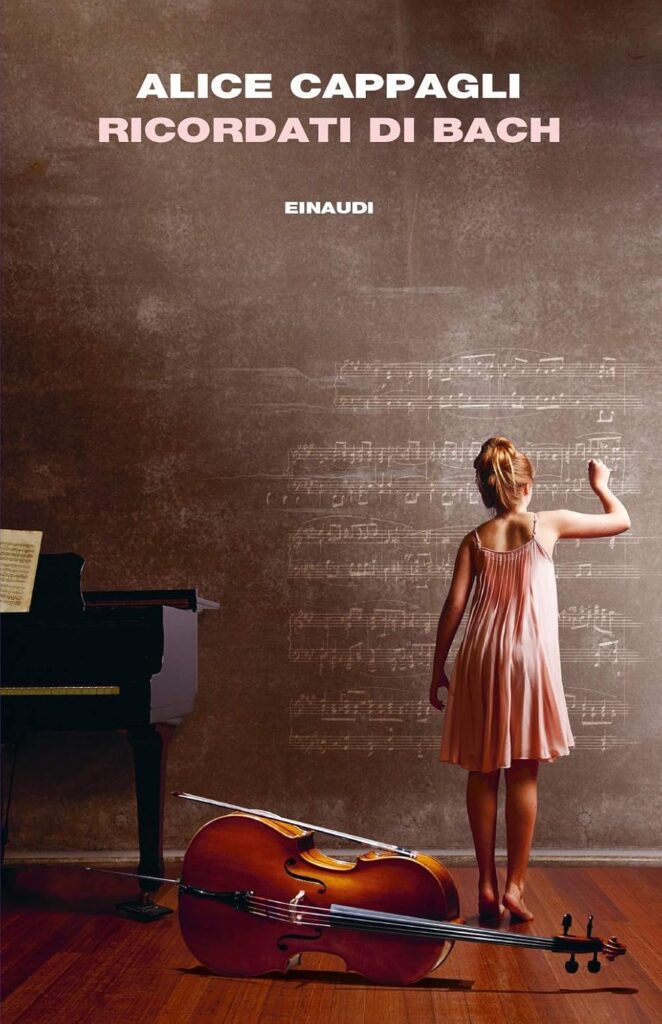
SINTESI DEL LIBRO:
Apro gli occhi.
Sono sdraiata su qualcosa di scomodo, una luce abbagliante
puntata sul braccio sinistro. Facce sconosciute mi scrutano da dietro
delle mascherine bianche, qualcuno mi chiede se ricordo qualcosa.
Lí per lí nulla, però alcuni frammenti di memoria mi attraversano
come una corrente calda e umida: è notte, il cruscotto oscilla
paurosamente, la mia voce dice «Mamma perché sbandi», i fari delle
auto arrivano in senso contrario, un urlo strozzato e uno schianto.
Rumore di vetri che vanno in frantumi, poi un buio piú denso della
notte.– Grillo, – riesco a sussurrare dopo un tempo indefinito. Chissà
dov’è finito, il grillo.
Le facce si guardano tra loro e annuiscono.
Un attimo dopo, ecco in bocca un sapore di marcio, una nausea
terribile e poi di nuovo nero, come un risucchio nell’oscurità.
Nel buio comincio a percepire le gambe, sembrano ancora
attaccate, e in un lampo rivedo l’immagine del mio braccio sinistro
coperto di sangue e molto corto, il braccio di una bambola, sembra,
non lo sento per niente, come la testa, le mani.
Un malessere insopportabile, il peggiore che abbia mai provato.
Però, oltre la mia voce che si lamenta, qualcosa succede: il cervello
mi sparpaglia davanti dei rimasugli arrivati da chissà dove, resti che
sembravano nulla fino a prima, ma che ora si ingigantiscono. Come
succede ai miei jeans, quando vengono rivoltati per essere messi ad
asciugare, e dalle tasche cade un foglietto, un bottone, una gomma,
una caramella zuppa.
E in quel pozzo del cervello vedo un po’ di tutto, perfino una
collana della zia, una tartarughina acquatica, il coraggio di dire che
odio il fegato alla veneziana.
Chissà dove sono finiti, i miei jeans. Le gambe me le sento nude
e fredde.
Sono viva.
Mi sono fatta male.
Sono da sola.
Quelli con la mascherina vengono a guardarmi di continuo, come
la torta nel forno, e cercano di tirarmi fuori dalla botola della paura,
senza molto successo. Tremo, sgusciando sempre piú giú.
Rumori estranei. Metallici.
La cosa piú terribile sono queste pareti. Si gonfiano come
membrane di un ranocchio e mostrano un reticolato disgustoso. Ma
non ce la fanno a imprigionarmi perché le allontano con la mano
destra, sibilando, come un serpente. L’odore dolciastro e
sconosciuto forse è sangue.
Se ora apro di nuovo gli occhi vedo dei neon rotondi, una porta
azzurra, un armadietto di ferro.– Siete tutti cattivi… – anche la lingua non è collegata, si mette in
moto da sola, senza preavviso.– Cecilia, – mi disse dolcemente una voce di donna dopo un
sacco di tempo. Attese che muovessi un po’ la testa, prima di
continuare: – Sei all’ospedale di Pisa, tra poco verrà la mamma, che
sta abbastanza bene. Il tuo grillo è scappato dalla gabbietta.
Volevo essere sicura che fosse vivo. Mi agitavo.– Adesso canta nell’erba…
Provai a girarmi un po’ per ringraziare quella signora, ma mi
sembrava di essere bloccata, vedevo solo qualcosa di bianco che
svolazzava via, tipo velo delle suore.
Nell’ospedale faceva molto caldo, era la fine di maggio e c’era
solo un ventilatore con le pale attaccato al soffitto che girava
lentamente terrorizzandomi, ero certa che sarebbe diventato un
gigante e mi avrebbe schiacciato peggio delle pareti. Un medico che
bollai come vecchio brutto e calvo venne a dirmi che le allucinazioni
erano la conseguenza del forte choc, e presto sarebbero passate.
Costui, dopo aver detto questa cosa improbabile, mi informò che mi
avrebbe aggiustato il braccio.– Come facevo io con le bambole una volta…
L’essenziale iniziò da lí, da quelle stanze afose e buie
dell’ospedale di Pisa dove il mondo esterno assunse i contorni di un
organismo gigantesco, sleale, imprevedibile, con cui dover fare i
conti per forza. E quindi da neutralizzare al piú presto.
Intanto in quell’incidente, che regalò un’indelebile cicatrice al
tronco di un pino marittimo dell’Aurelia, lasciai una bella dose di
fiducia nel futuro, ma soprattutto la certezza di essere invulnerabile.
Figlia unica curata e accudita come un bonsai nella serra
dell’imperatore, fino a quel momento ero stata scrupolosamente
tenuta al riparo dalle turbolenze dell’esistenza umana. E l’impresa
era riuscita abbastanza bene, fino all’inconveniente dell’incidente.
Cosí l’avrebbero chiamato in casa anni dopo, attribuendo
all’accaduto la rilevanza di un contrattempo.
L’operazione al braccio che mi fece il luminare vecchio brutto e
calvo fu lunga, di esito incerto, e richiese un’anestesia in grado di
stendere un elefante. Inoltre segnò l’inizio dei disagi di mia madre, la
quale quella sera si trovava al volante per scarrozzare marito, figlia e
amichetta di contorno.– Oddio, fortuna che ti sei fatta male soltanto te e non la tua
amica, – cominciò col dire.
Magra consolazione, pensavo dall’armatura di gesso in cui mi
avevano rinchiusa. Mi partiva dalla metà della mano sinistra per
arrivare alla spalla e poi all’ombelico, tipo maglione, costringendomi
a tenere il braccio sollevato e piegato ad angolo come se fossi
rimasta pietrificata nell’infilarlo.–
Ma io sto male… – belavo sperando che mia madre
raddrizzasse il tiro, invece niente. – Via via, sei una bimba matura e
consapevole, – continuava a sragionare, – vedrai che queste cose ti
serviranno, – ma non specificava a cosa, – e ricordati di non
raccontare mai nulla ai nonni che altrimenti si disperano,
specialmente il nonno. Anzi, di’ che sei caduta dalla bicicletta.– Sarebbe una bugia, – concludevo in base ai canoni educativi.
– No no, sembra una bugia, ma è una cosa buona in questo caso.
Sarà, ma la faccenda prendeva una piega che mi sfuggiva, non
me ne capacitavo neanche a mettere sotto pressione i neuroni piú
reattivi. Mi faceva sempre male la testa, mi sentivo sola, incapace di
spiegarmi. La lingua alle volte partiva con improperi inediti
all’indirizzo di medici, infermieri e innocue degenti con la flebo che
venivano a osservarmi. Mi dispiaceva anche, però proprio non
dipendeva da me.– Guarda che è già un miracolo che tu ti sia risvegliata cosí
presto, – diceva la mamma.
Quindi c’era poco da meravigliarsi di quel terribile mal di testa.
Per il resto dovevo sempre allontanare le pareti che si
deformavano e mi schiacciavano, e sudavo freddo. Il ventilatore,
ormai fuori controllo, si staccava dal soffitto e mi vorticava sul naso
facendomi agitare al punto di attirarmi l’infermiera con una siringa in
mano. Mia madre questa cosa non la capiva, il ventilatore secondo
lei non si spostava, e su questo non voleva sentire ragioni. Era un
soggetto complesso, per certi aspetti indecifrabile, mia madre. Mi era
sempre sembrato di non avere a che fare con una mamma normale
ma con qualcosa di chimico, perché le sue reazioni erano
imprevedibili. Insomma, nonostante fossi curata quanto un bonsai, a
momenti mi mandava al Creatore.– Ma babbo dov’è? – chiesi appena fui capace di stare seduta. Da
seduta era un’altra vita, se non altro riuscivo a tenere a bada le
pareti e il ventilatore almeno per una mezz’oretta di fila.– È caduto nell’erba del fossato appena la macchina è uscita di
strada, ha perso gli occhiali e si è slogato una caviglia.
Trascurò di dire che la macchina non era uscita di strada per
conto suo, ma ce l’aveva mandata lei. Il perché non lo sapeva, anzi
sosteneva che quell’auto aveva sempre goduto di una volontà
propria.– Ma te, mamma, cosa ti sei fatta?– Mi sono rotta quattro denti ma me li hanno rimessi.
Aveva anche mezza faccia violacea, ma erano comunque
bazzecole.– Quindi soltanto io…
– Sí, – tagliò corto, – ma guarirai presto –. E si mise a
singhiozzare prima di riuscire a precipitarsi fuori dalla stanza.
Ebbi la certezza che non me la sarei cavata alla svelta proprio per
niente.
Poi spostai lo sguardo dal neon all’armadietto, al lenzuolo
sfilacciato, al carrello con delle ferraglie dentro, e decisi di chiudere
gli occhi. Mi sarei fatta soffocare dalle pareti e dal ventilatore, forse a
quel punto mi conveniva anche.
Sopravvissi.
Tutto era in bilico: nessuno vedeva la realtà com’era, nessuno
aveva il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, nessuno
sapeva leggere il futuro. Cosí, per essere rassicurati sugli eventi,
scrutavano la mia faccia o le mie parole quasi fossi stata la Pizia, e
questo lo percepivo eccome.
Però di tempo per pensare ne avevo a tonnellate, lí dal mio letto
macchiato di tintura di iodio, e se non ero alle prese con le
allucinazioni potevo allenarmi nell’elaborazione dei dati. Scarsi quelli
recuperabili, ma certi.– E il babbo non ha nulla da dirmi?– Tornato al lavoro, poverino.
Già, poverino.– Messa cosí come faccio a giocare a campana?– Non giochi, fai qualcosa di piú interessante.– Tipo?– Leggere, o portarti avanti con i compiti che hai saltato.
Non appena uscii dall’ospedale stando sulle mie gambe per
miracolo, piantai una scenata epica come realizzai che lei
pretendeva di riportarmi a casa proprio in macchina, e per la
precisione a sud di Livorno, ossia con un viaggetto di mezz’ora da lí.
Le infermiere dovettero darmi un sedativo (l’ennesimo) per
caricarmici, e meno male, perché mia madre si rimise al volante
dicendo pure che quella macchina era un’altra, una «piú sicura», e
se non avesse guidato subito poi non l’avrebbe fatto piú.
Che dal mio punto di vista sarebbe stato l’ideale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :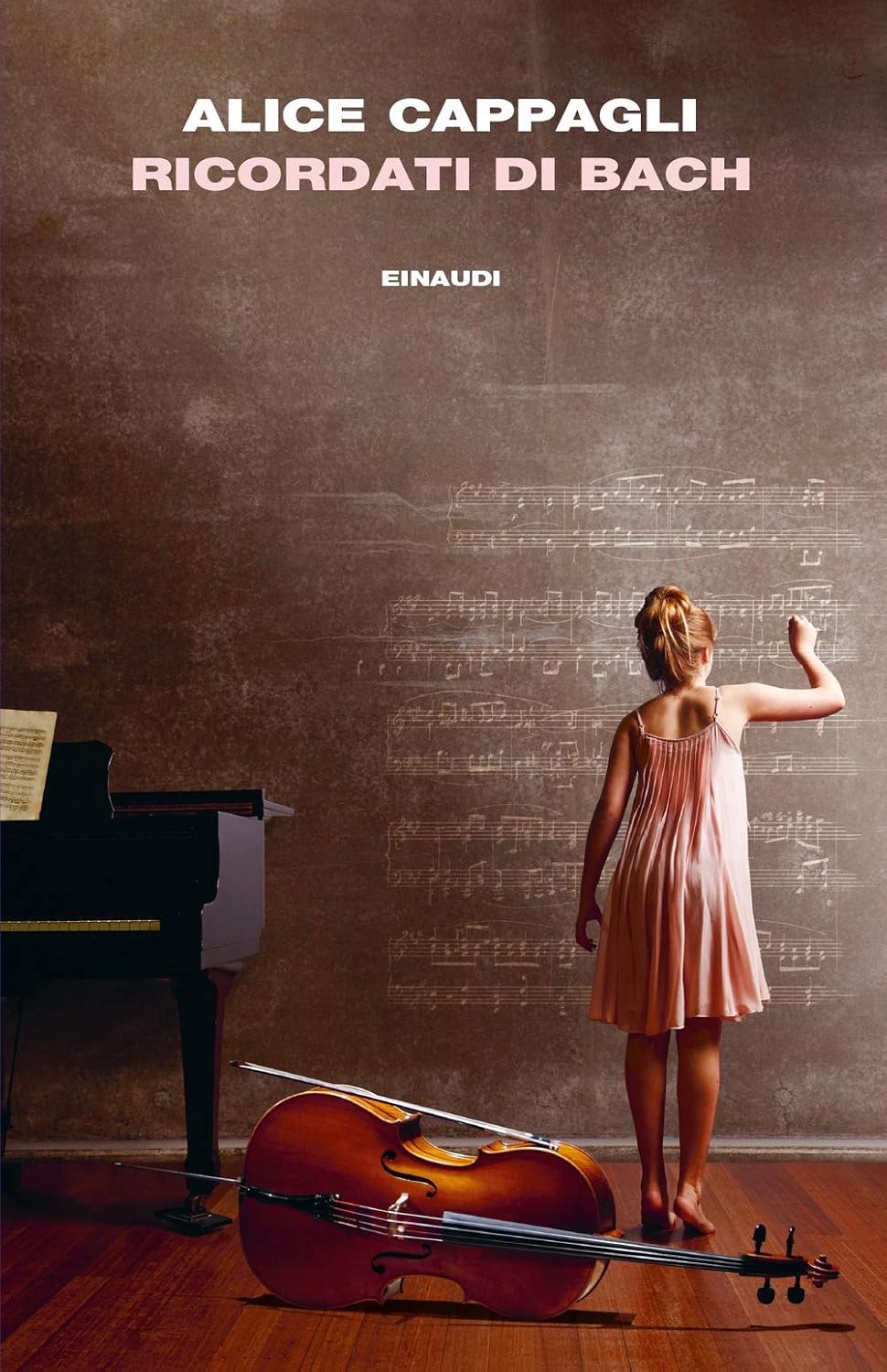






Commento all'articolo