Primo – non maltrattare – Storia della protezione degli animali in Italia – Giulia Guazzaloca
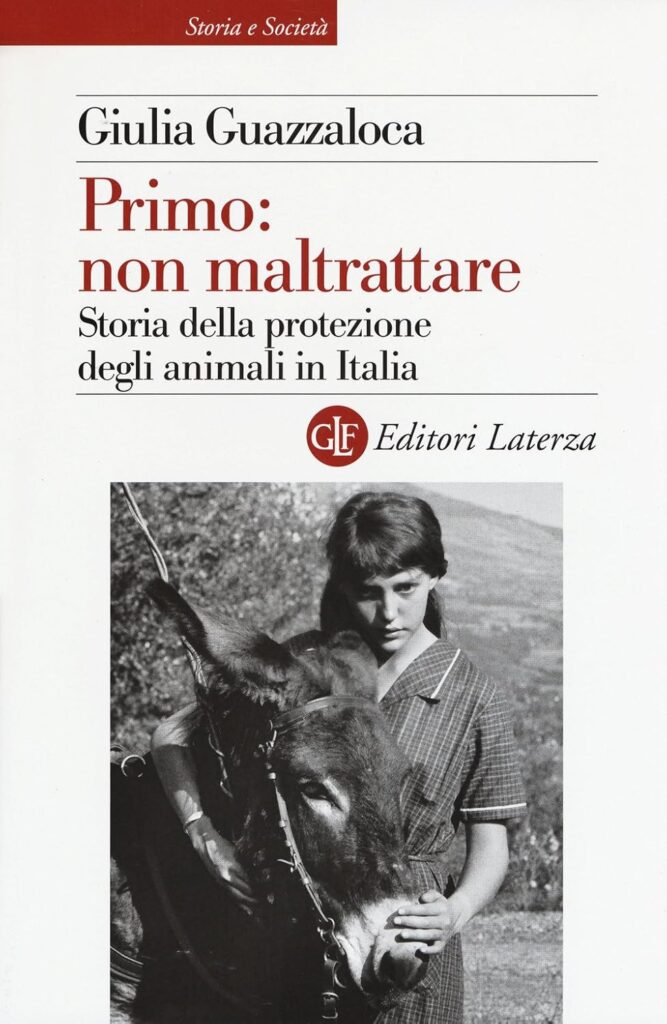
SINTESI DEL LIBRO:
Le prime forme di interesse per la condizione degli animali maturarono
nell’Ottocento presso le élites urbane colte, benestanti, tendenzialmente
progressiste. Nel nuovo contesto prodotto dall’industrializzazione e
dall’urbanizzazione, i valori di rispettabilità e decoro propri delle middle
classes, il modello familiare di tipo borghese, le attitudini di cura e
protezione verso i bambini, la «romanticizzazione» della natura e del
mondo agreste furono i principali fattori che aiutarono a plasmare una
nuova percezione del rapporto con gli animali11. A tale processo
contribuirono anche le riflessioni dei filosofi utilitaristi e illuministi e la
teoria evoluzionista darwiniana, primi tentativi di formulare in modo
nuovo i temi dell’«umanità» e dell’«animalità».
Per secoli, e con poche eccezioni, il pensiero occidentale aveva postulato
una differenza irriducibile tra uomo e animale: l’uomo dotato di
autocoscienza, pensiero razionale, capacità logico-inguistica e per taluni
anima immortale; l’animale essere inferiore, finalizzato all’utilizzo e allo
sfruttamento da parte dell’uomo e infine assimilato da pensatori come
Bacone e Cartesio ad una «macchina» incapace di sentire e soffrire. In
questa visione rigorosamente gerarchica e antropocentrica poteva al
massimo configurarsi – come proponevano, tra gli altri, san Tommaso e
Kant – l’invito a non esercitare crudeltà sugli animali nella presunzione
che potesse preludere a quella contro gli stessi umani12. A sfidare
parzialmente questa struttura concettuale furono l’utilitarismo e la
f
ilosofia dei Lumi, che aprirono un’epoca nella quale i non umani
cominciarono a diventare «soggetti della filosofia e della morale»13. Le
riflessioni di Hume, Voltaire, Diderot, John Stuart Mill, sostenendo
l’evidenza di analogie comportamentali fra umani e non umani, andavano
nella direzione di avallare la possibilità di estendere agli animali le basilari
norme del comportamento etico. In Italia l’abate Antonio Rosmini, a
partire dal «senso» come «radice dell’essenza animale», vi riconosceva «un
essere individuo, che sentendo opera»14. Fu però Jeremy Bentham, nel
1789, a fissare per la prima volta nella «sensività» il principio etico e
giuridico per l’attribuzione dei diritti a tutti gli individui, umani e non:
«la domanda non è ‘possono ragionare?’, né ‘possono parlare?’, ma
‘possono soffrire?’». Stabilì paragoni espliciti tra la condizione degli
schiavi e quella degli animali e fu il primo ad affermare la necessaria
inclusione degli animali nella comunità morale e politica15; inclusione
che, secondo il principio dell’utilità a fondamento della sua filosofia,
avrebbe consentito di perseguire la felicità per il maggior numero di
individui, e dunque aumentato la quantità totale di benessere collettivo.
Dal canto suo, la teoria darwiniana evidenziò la continuità evolutiva tra la
specie umana e le altre e aprì la strada a tutta una serie di studi e discipline
che nel corso del Novecento avrebbero dimostrato le forti analogie
biologiche e comportamentali tra l’uomo e gli altri viventi. Inoltre
Darwin riteneva che anche l’impulso alla considerazione etica è
sottoposto alle leggi dell’evoluzione, essendosi sviluppato a partire dagli
istinti di appartenenza al branco, e in tale prospettiva non escludeva che la
morale potesse superare i confini della specie umana per includervi tutte
le creature animali16.
Dalla filosofia e dalla scienza vennero quindi i primi impulsi a rivedere la
concezione tradizionale dell’animale-macchina e a trasformare la
tipologia del rapporto con le altre specie: da puramente economico e
scevro da valutazioni di giustizia a relazione di tipo etico o addirittura
etico-giuridico. All’inizio, tuttavia, queste teorie non ebbero ricadute
dirette nel sentire collettivo e nel diritto positivo. L’orientamento
compassionevole verso gli animali scaturì piuttosto dai fermenti sociali e
morali
della
modernizzazione
ottocentesca,
dall’umanitarismo
dell’Inghilterra vittoriana e dal «culto» del pet di famiglia, che soprattutto
in Gran Bretagna contribuì a forgiare il nuovo ideale della domesticità.
Presente già dal Cinque-Seicento presso le élites aristocratiche, la moda di
tenere cani e gatti (ma non solo) all’interno delle abitazioni si diffuse in
ambito borghese nel corso del XIX secolo17. Innocenti, puri e indifesi,
proprio come i bambini, i domestic pets fecero il loro ingresso nelle famiglie
delle middle classes e già nel 1851 la scrittrice inglese Jane Loudon volle
dedicare loro un libro, illustrandone caratteristiche e necessità; lei stessa
viveva con un cane, un gatto e due pesci, amava tantissimo gli animali e
«fortunatamente, nell’interesse del mio libro, ci sono migliaia di altre
persone che li amano quanto me»18. Furono i gatti la vera «scoperta»
dell’Inghilterra ottocentesca, dopo che per secoli erano stati perseguitati,
associati a demoni e streghe, al massimo utilizzati come acchiappatopi;
viziarli divenne di moda all’interno della borghesia vittoriana che li
indentificava con le virtù di dignità e decoro e con le doti femminili di
grazia, pulizia e leggiadria. «Angelo del focolare» come la donna, il gatto
cominciò ad essere celebrato da intellettuali, poeti, pittori e romanzieri
che lo rappresentavano come parte attiva della vita domestica19. Ovunque
il cane di razza, soprattutto da caccia, era simbolo e garanzia di uno status
sociale elevato, mentre lo sviluppo delle attività concernenti la
registrazione delle razze canine e feline (allevamenti, circoli, mostre, testi
specializzati) dimostrava che intorno alla moda dei pets si stava
consolidando un cospicuo giro d’affari20. Anche il settore del pet food, oggi
f
loridissimo, cominciò ad espandersi in Inghilterra e Stati Uniti sul finire
dell’Ottocento. Negli anni Sessanta-Settanta l’azienda Spratt aveva
iniziato a produrre biscotti per cani, creava slogan pubblicitari
accattivanti, faceva inserzioni sui quotidiani e sulle riviste cinofile e il
successo fu tale che venne presto imitata; durante la prima guerra
mondiale rifornì i cani-soldato inglesi e americani con oltre 70.000
tonnellate di biscotti21.
Da un lato quindi fu il pet, eretto a simbolo della nuova intimità delle
relazioni familiari, amato e coccolato dai proprietari, ad incrinare in parte
la tradizionale visione utilitaristica dell’animale; dall’altro, gli ideali
vittoriani di moderazione e «contenimento delle passioni» cominciarono
ad essere applicati anche al trattamento degli animali, nella convinzione
che le violenze nei loro confronti fossero riconducibili ai «comportamenti
antisociali» dei ceti lavoratori. Ritenendo che incrudelire sugli animali
predisponesse alla violenza verso gli stessi umani, secondo la «tesi della
crudeltà» di san Tommaso, tutti i primi attivisti zoofili muovevano da un
intento pedagogico di moralizzazione pubblica22. La Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, la prima società protezionista inglese
fondata nel 1824, si batteva infatti non solo per difendere gli animali, ma
in generale per «civilizzare i ceti inferiori»23. I quali – si pensava – erano
carenti di compassione verso gli animali perché «essi stessi erano come
animali. Era perciò sentito un dovere degli individui illuminati educarli e
disciplinarli, proprio come coi cani che non hanno mai conosciuto il
collare o un comando»24. Accadeva spesso, quindi, che le idee zoofile
trovassero accoglienza da parte delle organizzazioni di mutuo soccorso,
per l’assistenza ai poveri e per la beneficienza; analogamente la causa della
tutela animale era patrocinata da esponenti di associazioni riformatrici
come la Fabian Society, la Fellowship of the New Life, la London
Abattoir Society25. Emblematico, da questo punto di vista, il caso
dell’Humanitarian League fondata nel 1891 dal filosofo e riformatore
Henry Salt26: tra i suoi obiettivi, oltre alla protezione degli animali, vi
erano la riforma di prigioni e poor laws, l’emancipazione femminile,
l’obbligatorietà delle vaccinazioni, il miglioramento della dieta, la lotta
all’inquinamento. Tutte istanze nelle quali confluivano la compassione
verso i più deboli e l’idea di progresso morale e civile. «Oppressione e
crudeltà derivano sempre da una mancanza di immaginazione empatica»,
scriveva Salt, che tuttavia non si fermava a questo: «rivendicare i diritti
degli animali va molto al di là di implorare misericordia e giustizia per le
vittime di maltrattamenti [...] ha a che fare con la nostra civilizzazione,
con il progresso della nostra specie, con la nostra umanità (nel senso
migliore del termine)»27.
Se non era nuova l’idea che incrudelire sugli animali fosse il sintomo di
un carattere violento e incline alla sopraffazione, a cambiare nel corso
dell’Ottocento fu l’ambito a cui si applicava tale assunto: alla morale
collettiva e non più solo a quella del singolo. La violenza sugli animali era
potenzialmente foriera di quella verso gli umani e l’una e l’altra
producevano disordine sociale e degenerazione dei costumi. Negli Stati
Uniti riformatori e gruppi zoofili, collegando gli abusi sugli animali a
quelli sui bambini ed entrambi al degrado e alla criminalità,
«trasformarono la sofferenza privata in un problema pubblico»28; violenze
e soprusi, specie se praticati fuori dalle mura domestiche, diventavano
cioè un’offesa alle norme sociali e alla morale collettiva. Di conseguenza
tutte le prime società protettrici si occupavano principalmente di
prevenire e combattere le forme pubbliche di crudeltà: i combattimenti
fra animali, i maltrattamenti su quelli da traino e da lavoro.
Anche le prime leggi protezioniste riflettevano questo tipo di
sensibilità29. All’inizio a spingere per l’adozione di norme a tutela degli
animali fu il desiderio di salvaguardare gli interessi economici legati al
loro utilizzo e combattere pratiche «indegne» e «incivili». Indicativa
dell’approccio e del linguaggio dei legislatori dell’epoca è la legge
antisevizie emanata dallo Stato di New York nel 1829. Divisa in due
parti, che vietavano azioni molto differenti fra loro, distingueva fra
l’animale «appartenente ad un altro», stabilendo il divieto di ucciderlo, e
l’animale «appartenente a se stesso o un altro», al quale era proibito
causare sofferenze inutili; chiaramente lo scopo della prima parte era
quello di fornire una protezione legislativa alla proprietà privata30. Il tratto
comune di queste prime disposizioni era comunque il divieto dei
maltrattamenti impropri e inutilmente crudeli. In Gran Bretagna il Cruel
Treatment of Cattle Act del 1822 applicava tale divieto («percuotere
arbitrariamente e crudelmente, abusare e maltrattare») agli animali da
lavoro e da macello, prevedendo per i trasgressori multe e la carcerazione
f
ino a tre mesi. Nota come Martin’s Act dal nome del suo promotore, il
deputato irlandese Richard Martin, la legge trovò il sostegno di illustri
esponenti dell’evangelicalismo e del clero protestante, convinti che la pietà
verso gli animali potesse educare gli individui a comportamenti benevoli e
non cruenti31. Nel 1835 le medesime restrizioni furono estese a tori, cani,
orsi, capre, pecore e si introdusse il divieto dei combattimenti fra galli, fra
cani e fra orsi. Un divertimento, quello dei combattimenti fra animali,
diffuso soprattutto tra i ceti lavoratori; «i borghesi erano indignati tanto
per il disordine prodotto dagli sport con animali, quanto per le crudeltà
che vi si praticavano»32. Nel conflitto in corso tra «le forze del ‘progresso’
e le spinte alla sopravvivenza di istituzioni, costumi e idee provenienti dal
passato» vi rientrava dunque anche la questione del trattamento degli
animali.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :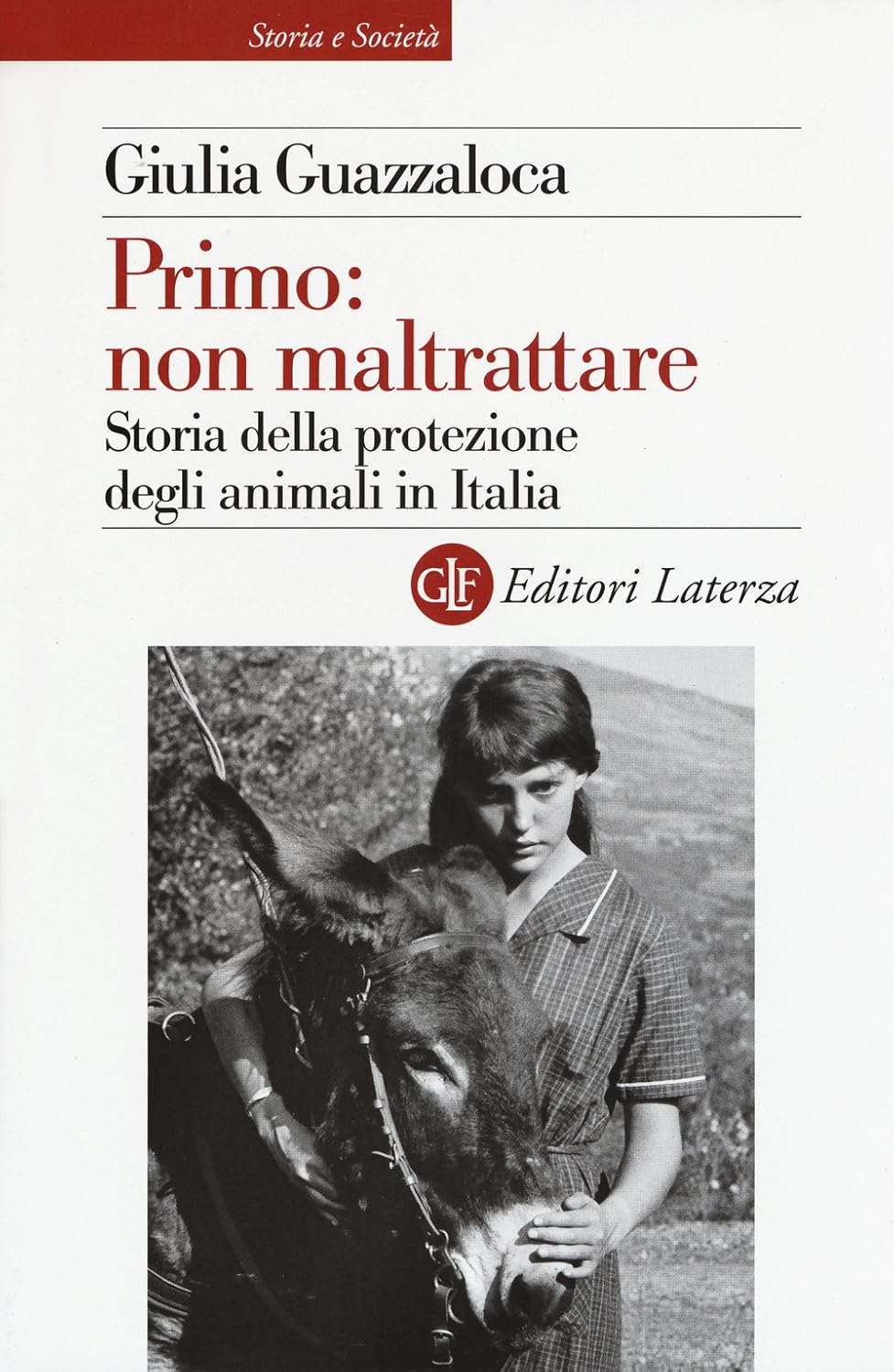






Commento all'articolo