Prima lezione di diritto – Paolo Grossi
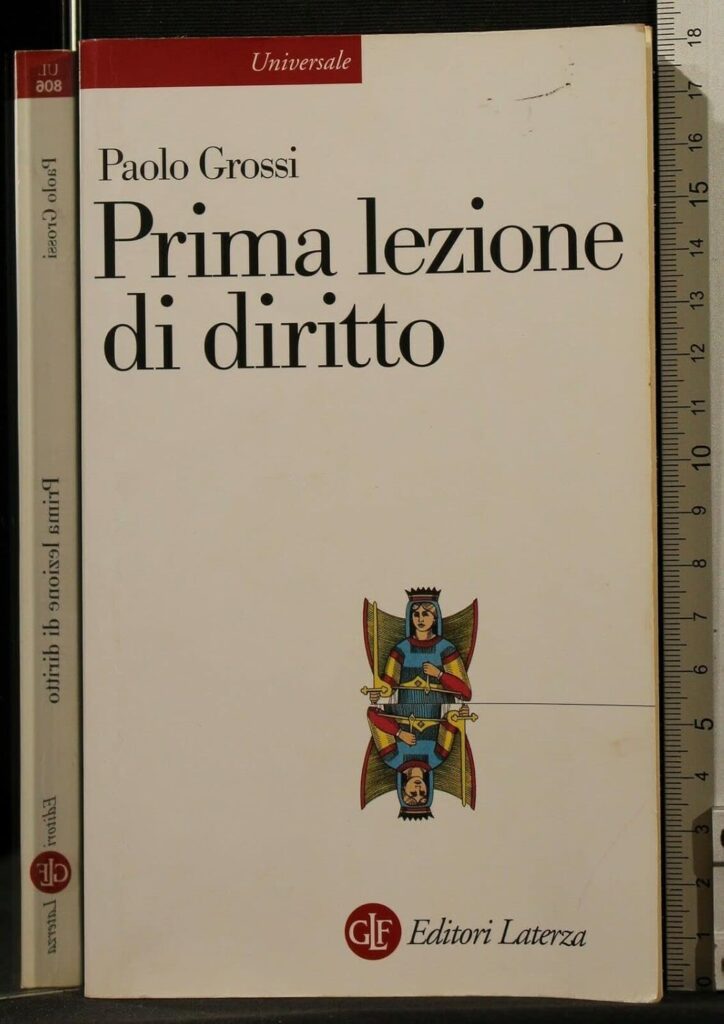
SINTESI DEL LIBRO:
Il diritto non appartiene al mondo dei segni sensibili. Il fondo rustico da
me acquistato sembra confondersi col fondo del mio vicino, se non vi
appongo una recinzione; il palazzo sede della ambasciata di uno Stato
straniero, e pertanto spazio extraterritoriale, può sembrare identico a tutti i
palazzi limitrofi se una targa non segnala la sua situazione straordinaria; la
striscia di terreno che separa la Repubblica italiana dagli altri Stati corre
continua se non ci sono segni visibili di confinazione o ufficiali di polizia e
di dogana per il controllo dei transiti.
Il diritto si affida a dei segni sensibili per una efficace comunicazione, ma
anche senza di essi il mio fondo rustico, la sede di una ambasciata, il
territorio di uno Stato sono e restano realtà caratterizzate e differenziate dal
marchio immateriale del diritto.
Questa immaterialità ne fa una dimensione misteriosa per l’uomo
comune, e nasce da qui il primo dei motivi per cui il diritto è circondato
da un fitto tessuto di incomprensioni. Ma v’è di più: dimensione
misteriosa e anche assai sgradevole.
Sì, sgradevole, perché all’uomo comune di oggi il diritto appare sotto due
aspetti che non contribuiscono certo a renderglielo benaccetto: gli piove
dall’alto e da lontano, assomigliando al tegolo che cade da un tetto sulla
testa di un passante; gli sa di potere, di comando, di comando autoritario,
evocando immediatamente l’immagine sgradevolissima del giudice e del
funzionario di polizia, con l’ulteriore possibilità di sanzioni e di
coercizioni.
Tutto ciò rende il diritto per l’uomo della strada una realtà ostile; in ogni
caso, una realtà estranea, che egli sente enormemente distante da sé e dalla
sua vita. Con un risultato che è doppiamente negativo per il cittadino e per
il diritto: il rischio probabile di una separazione fra diritto e società, con un
cittadino più povero perché gli sfugge di mano uno strumento prezioso del
vivere civile, con il diritto sostanzialmente esiliato dalla coscienza comune,
con il giurista – cioè con colui che sa di diritto – relegato in un cantuccio e
assai poco partecipe della complessiva circolazione culturale.
2. Le ragioni storiche di fraintendimenti e incomprensioni
Un simile risultato negativo era, almeno fino a ieri, inevitabile, né mi
sentirei di ritenerlo soltanto frutto di ignoranza dell’uomo della strada,
gravando le sue spalle di un grosso fardello di responsabilità.
Ciò sarebbe profondamente ingiusto. Un simile risultato è infatti la
conseguenza di scelte dominanti e determinanti nello scenario della storia
giuridica dell’Europa continentale durante gli ultimi duecento anni e che si
sono consolidate in un vincolo strettissimo e completamente nuovo fra
potere politico e diritto.
Il potere politico, divenuto sempre più – nel corso dell’età moderna
uno Stato, cioè una entità totalizzante tendente a controllare ogni
manifestazione del sociale, ha mostrato un crescente interesse per il diritto,
riconoscendovi con estrema lucidità un prezioso cemento della sua stessa
struttura; interesse tanto crescente da arrivare alla fine del Settecento, con
una decisa smentita di secolari atteggiamenti conservatisi fino all’esito
dell’antico regime1, alla piena monopolizzazione della dimensione
giuridica2.
Infatti, è proprio in quegli anni che, fra le molte mitologie3 laiche
inaugurate dalla Rivoluzione del 1789, si staglia nettissima quella
legislativa: la legge, cioè l’espressione di volontà del potere sovrano, è
assiomaticamente identificata nella espressione della volontà generale,
rendendola in tal modo l’unico strumento produttivo del diritto
meritevole di rispetto e di ossequio, oggetto di culto in quanto legge e non
per la rispettabilità dei suoi contenuti. Identificata nella legge la volontà
generale, ne conseguiva l’identificazione del diritto nella legge e ne
conseguiva la sua completa statalizzazione.
Ma lo Stato è soltanto, come vedremo meglio in alcune pagine seguenti,
una cristallizzazione della società, lo Stato è sempre – anche il cosiddetto
Stato democratico – un apparato di potere, una organizzazione autoritaria,
una fucina di comandi, e il diritto ne è rimasto ovviamente contrassegnato.
Solidissima grazie al basamento forte del mito della volontà generale4, la
credenza nella virtù della legge si è trascinata quasi intatta fino ad oggi,
sostenuta, da un lato, dalla strategia occhiuta del potere politico che non
poteva non ravvisarvi un mezzo efficace di governo della società, dall’altro,
dalla pigrizia intellettuale degli stessi giuristi, paghi del ruolo formale di
sacerdoti del culto legislativo (anche se si trattava per loro unicamente di
una modesta minestra di lenticchie).
Lo storico del diritto è, fra i giuristi, il personaggio che ne resta più
inappagato e anche allarmato. Avendo in uggia tutte le imbalsamazioni a
cui i miti sottopongono la complessità e vivacità della storia, percepisce le
chiusure gravemente negative delle mitologie giuridiche moderne proprio
in ordine a un divenire che avrebbe preteso scioltezza e disponibilità
maggiori. Abituato a cogliere il nascere del diritto nella incandescenza delle
forze sociali culturali economiche avverte il rischio grosso cui si è or ora
accennato, e cioè di una separazione della veste giuridica dal flusso storico,
con il risultato del suo ridursi a corteccia rinsecchita avulsa dalla linfa vitale
sottostante5.
Il processo di involuzione del diritto moderno è stato inarrestabile: la
legge è un comando, un comando autorevole e autoritario, un comando
generale, un comando indiscutibile, con una sua vocazione essenziale ad
essere silenziosamente ubbidito; da qui, la sua propensione a consolidarsi
in un testo, a rinserrarsi in un testo cartaceo dove chiunque possa leggerlo
per poi ubbidirgli, in un testo che è per sua natura chiuso e immobile, che
diverrà presto polveroso e, rispetto alla vita che continua a scorrere
rapidamente all’intorno, anche invecchiato. Ma il potere persisterà a farsi
forte di quel testo con l’ausilio di giuristi servili che persisteranno nelle loro
liturgie sul testo.
Torniamo al nostro punto di partenza. Non ha torto l’uomo della strada a
sentire estraneo e distante il diritto, a diffidarne, a temerlo nella sua
manifestazione squisitamente imperativa, giacché un comando può essere
anche arbitrario; soprattutto a coglierlo in nesso insopprimibile con il
giudice, con il funzionario di polizia o con il fisco. Non ha torto, perché
gli ultimi duecento anni della nostra storia europea continentale hanno
avuto quella ossificazione più sopra sommariamente disegnata.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :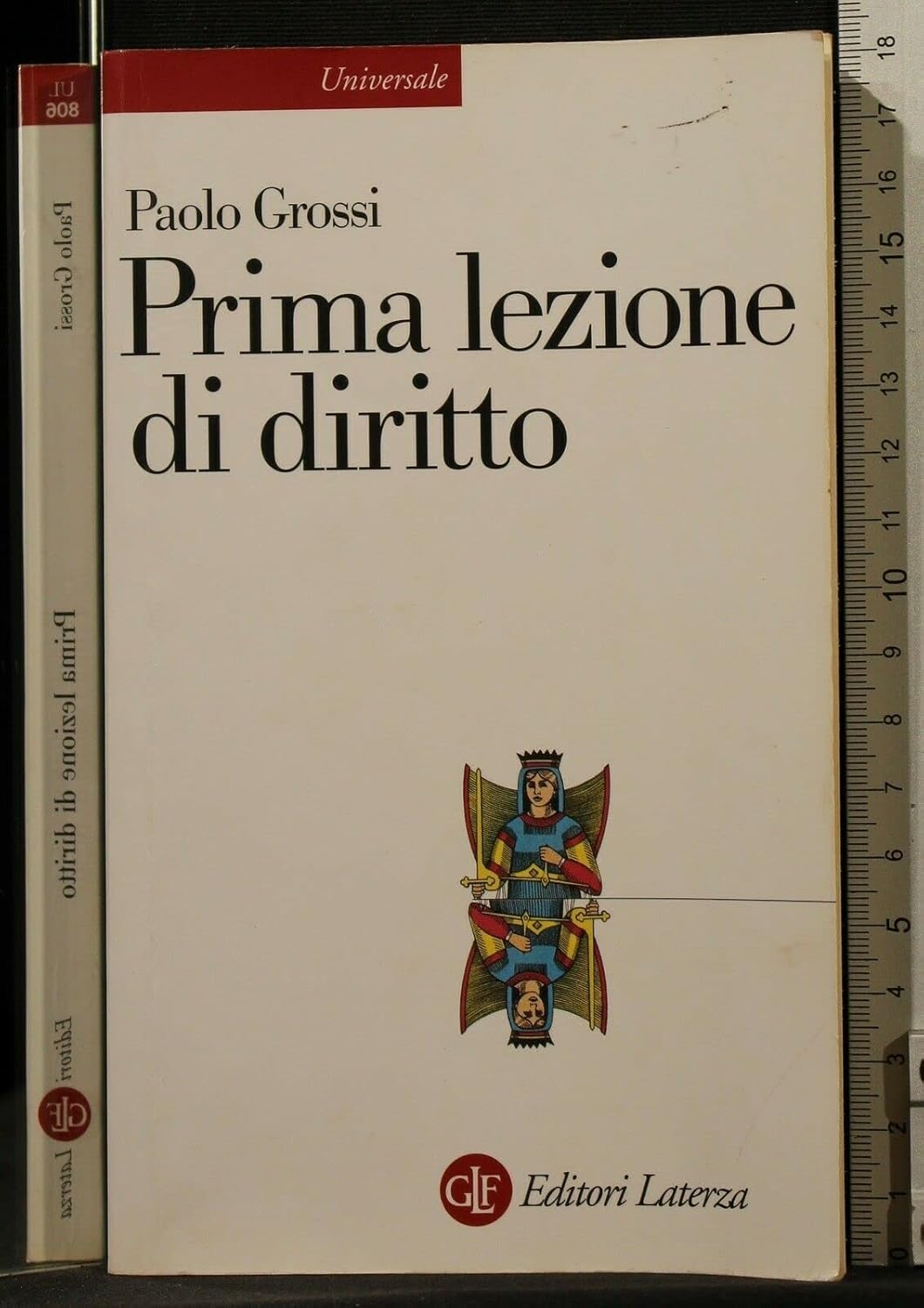





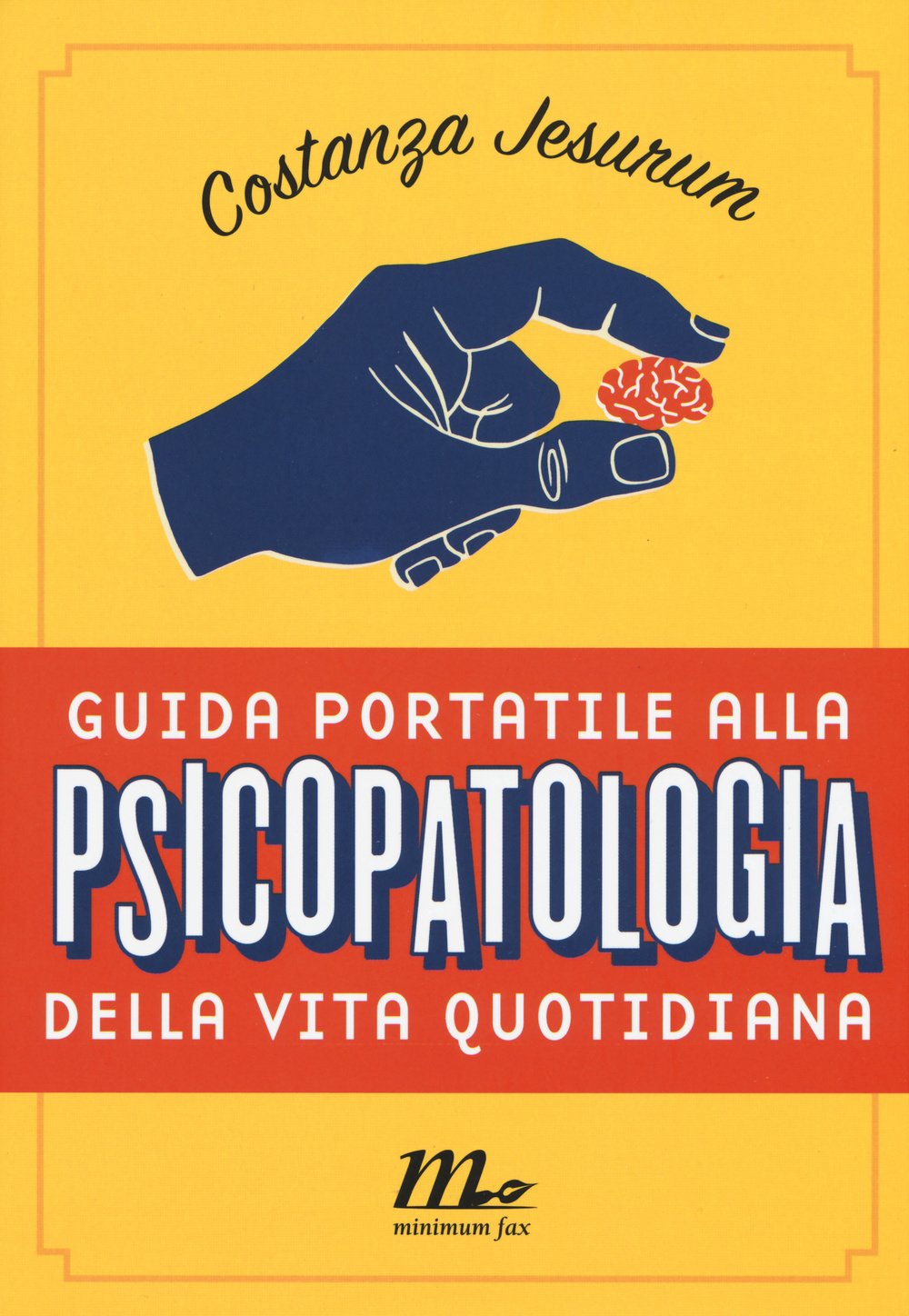
Commento all'articolo