Montagne di mezzo – Mauro Varotto
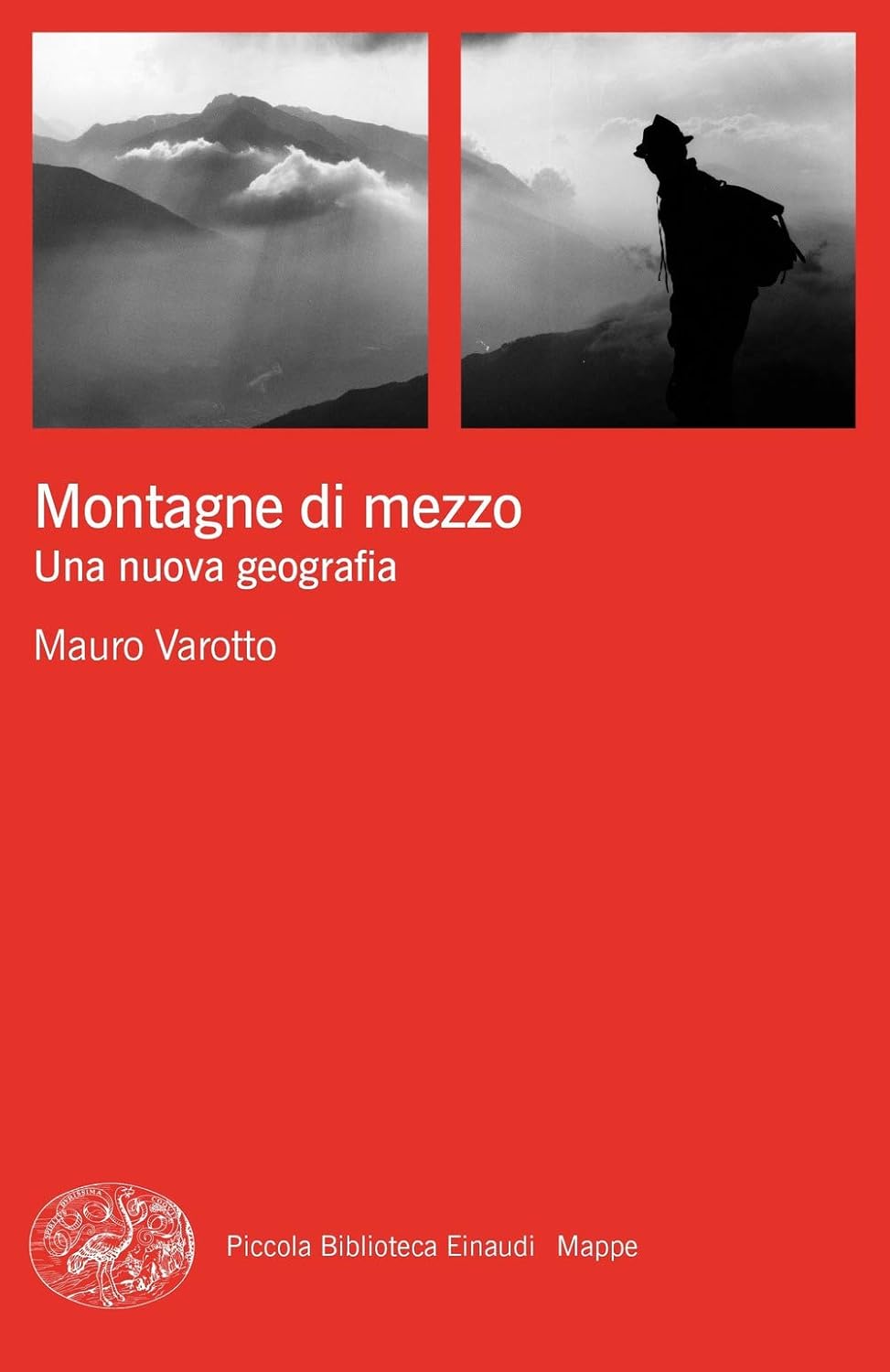
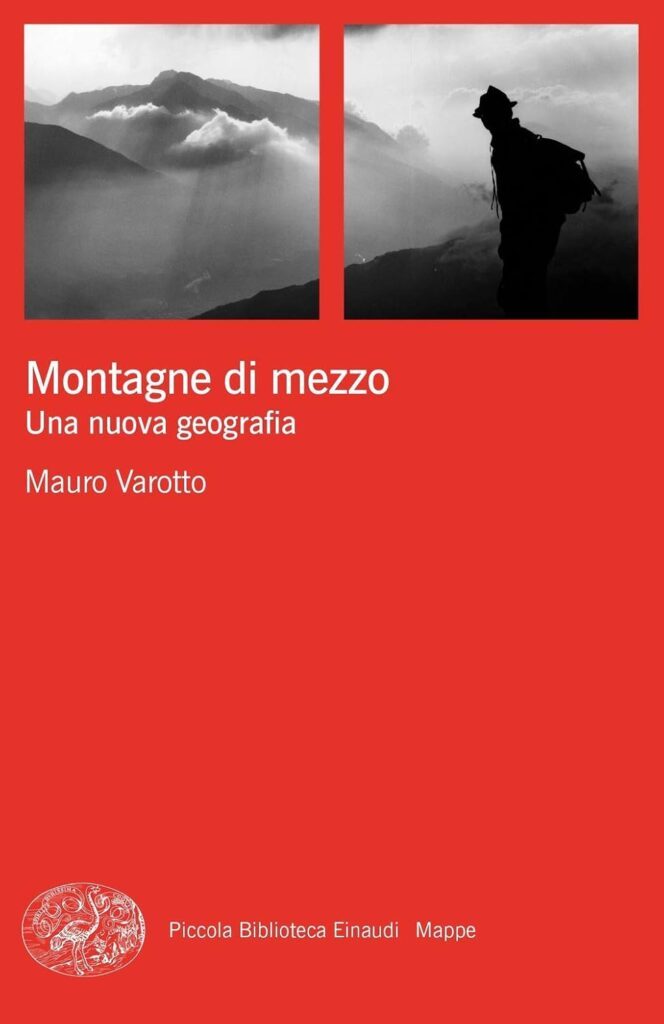
SINTESI DEL LIBRO:
Quando si parla di «montagne di mezzo» il primo pensiero va alla
loro posizione altimetrica: dove si collocano geograficamente? A
quale quota iniziano e terminano? Si trovano «in mezzo» rispetto a
quali altre montagne? Quello sulle «montagne di mezzo» è
inevitabilmente un discorso su qualcosa che (ancora) non c’è,
avvolto in un’aura indefinita ed evanescente, come la Terra di mezzo
dei romanzi di Tolkien, sospese nel nostro immaginario o avvolte in
una grande ambiguità. Per sgombrare il campo da alcuni equivoci di
fondo non si può che partire dal modo in cui classifichiamo
altimetricamente le montagne, e dai pochi punti certi (di partenza,
non di arrivo) relativi alla definizione delle montagne intermedie.
Misurare con precisione le montagne è un imperativo
relativamente
recente
della
storia
dell’umanità:
la
concettualizzazione delle montagne come oggetti misurabili
scientificamente è un prodotto della modernità occidentale2. I
discorsi sulla montagna hanno a che fare piuttosto con il suo
contrario, ovvero con qualcosa che per sua natura suscita stupore e
meraviglia per la sua incommensurabilità. Da sempre la parola
«monte» ha evocato nella mente dell’uomo un insieme di idee che
prescinde dalla possibilità pratica di misurarne l’altezza. Sin dalla
sua origine latina, la parola mons è usata, indipendentemente dalla
sua altezza assoluta, quando un rilievo presenta un dislivello
notevole rispetto al terreno circostante, quando la sua forma evoca
la vicinanza al cielo, quando alcuni versanti risultano inaccessibili.
L’uomo ha insomma usato la parola «monte» con l’intento di indicare
qualcosa che sfugge la misura, o che si distingue nettamente dal
contesto che lo circonda. Questo il motivo per cui il latino mons è
fortemente correlato anche al termine minae, «minaccia»,
condizione che proviene da ciò che di per sé non è controllabile,
dalla sua costitutiva incombenza.
Cosí nella toponomastica italiana sono detti «monti» alcuni aspri
promontori che non raggiungono i 600 metri (ad esempio il monte
Circeo o il monte Conero), mentre sono chiamati «colli» rilievi
superiori a 600 metri quando questi non presentano morfologie
dirupate (il Colle di Tenda a oltre 1800 metri tra Piemonte e
Provenza, il Col Rodella a oltre 2400 metri sulle Dolomiti o le
ondulate colline delle Langhe che lambiscono i 900 metri di quota ai
confini con la Liguria).
A partire dall’età illuministica la definizione di montagna ha
percorso tuttavia una strada diversa, prevalentemente orientata alla
comparazione scientifica dei suoi caratteri fisico-morfologici, che
hanno portato a stilare classifiche altimetriche e a perimetrare in
maniera sempre piú precisa confini e soglie della «montuosità». Uno
dei risultati piú prestigiosi e artisticamente piacevoli cui si giunge per
questa via nel corso dell’Ottocento sono le tavole sinottiche
comparative sulle altezze delle montagne (fig. 2), cui si associano
limiti
climatici, orizzonti vegetazionali, forme dell’insediamento
umano.
Ai metodi di misurazione scientifica dei caratteri fisici della
montagna si appoggiano i propositi di riorganizzazione politica della
Staatsgeographie3, con i nuovi assetti amministrativi basati sugli
spartiacque idrografici, la conquista alpinistico-nazionalistica delle
vette piú elevate delle Alpi, la «guerra delle croci» e la «guerra delle
bandiere» che a fine Ottocento già prefigurano il piú cruento conflitto
mondiale, in un percorso di progressiva conquista scientifica, politica
e militare delle vette4.
Ancora piú significativo è il fatto che ancora oggi su questa base
statistico-altimetrica si fonda la gestione politica delle aree montane,
ancorata a una definizione statistica che in ultima istanza poggia
ancora sull’altitudine in metri. Una operazione di «tomografia alpina»
solo in apparenza neutra: si taglia a fette l’orografia e la si
riorganizza in base a criteri di quota o pendenza destinati ad avere
conseguenze economiche e sociali notevoli, determinando la fortuna
o sfortuna di interi territori.
La montagna intesa come unità e articolazione complessa di
aspetti fisici e umani viene cosí di volta in volta assoggettata a
questo o a quel parametro per poter essere riconosciuta come tale.
Ancora oggi, nel discorso pubblico, una montagna si definisce a
partire da una quota, e poco importa se a livello europeo non vi sia
accordo su quale essa debba essere: dall’Irlanda e dal Regno Unito
che indicano rispettivamente in 200 e 240 metri la quota minima per
definire un territorio montano ai 500 metri dell’Austria, ai 600
dell’Italia o della Grecia. Sia che si prenda l’enciclopedia Treccani o
Wikipedia, che si parli di imprese alpinistiche o sussidi economici,
quello metrico è ancora il criterio scientifico prevalente – nella sua
versione piú semplice di quota sul livello del mare o in quelle piú
complesse che combinano quote, dislivelli e pendenze – per stabilire
lo statuto di «area montana» e l’accesso a misure di carattere
economico, con l’inevitabile corollario di polemiche sulla giustezza
dei criteri-soglia adottati.
Le soglie altimetriche sono alla base anche dell’adozione dei
criteri di denominazione: in ambito toponomastico, negli Stati Uniti il
Board on Geographic Names usava fino agli anni settanta il termine
mountain per rilievi oltre i 1000 piedi (poco piú di 300 metri), quota in
seguito abbandonata a favore di quella inglese che stabilisce in 2000
piedi (circa 610 metri) la linea di demarcazione tra collina e
montagna, analoga a quella italiana che separa statisticamente le
aree di collina e di montagna.
Nel tentativo di dare omogeneità alla definizione di montagna, a
livello europeo si è giunti a una prima definizione di mountain areas
con lo studio commissionato nel 2004 dalla Commissione Europea,
in base al quale risulta che la montagna copre circa il 40 per cento
del territorio continentale (1 900 000 kmq) e in essa vive un quinto
della popolazione complessiva (oltre 94 milioni di persone). Lo studio
identifica le aree montane e le classifica in sette diverse categorie
seguendo il metodo adottato nel 2000 dall’UNEP-WCMC (United
Nations Environment Programme World Conservation Monitoring
Centre) che intreccia criteri altimetrici (a partire da 300 metri di
quota), di pendenza (superiori a 2 gradi) e di dislivello (oltre i 300
metri su scala locale calcolati in un raggio di 7 km)5.
Ogni paese europeo, tuttavia, ha poi proceduto a definire in
maniera autonoma ciò che è considerato «area montana» in termini
legali e amministrativi, rispetto a ciò che viene definito montagna in
termini fisici. In Italia la «montagna amministrativa» è regolata a
partire da quanto previsto dalla Legge 991 del 25 luglio 1952 (art. 1),
in cui si considera montano il territorio comunale che abbia almeno
l’80 per cento della superficie oltre i 600 metri di quota o il cui
dislivello tra quota minima e massima sia superiore ai 600 metri. Su
questa base, l’Uncem (Unione nazionale dei comuni, comunità ed
enti montani) ha stilato nel 2002 un ampio elenco di comuni
totalmente o parzialmente montani che comprende oltre la metà dei
comuni italiani (4205 comuni, di cui 3516 «totalmente montani», pari
al 43,7 per cento degli 8100 comuni italiani); su di essi insiste una
popolazione di oltre 14 milioni di abitanti (poco piú del 23 per cento
della popolazione nazionale, in un’area che comprende oltre il 58 per
cento del territorio, pari a circa 175 000 kmq). Sempre secondo
l’Uncem, le aree amministrative classificate come «aree
svantaggiate» ammonterebbero a 3587 comuni, pari a una
popolazione di 16 156 107 abitanti e 143 226 kmq6. Secondo questa
classificazione, in termini di estensione amministrativa la montagna
sarebbe predominante in quattordici regioni italiane su venti
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli, Marche,
Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e
Sardegna). Tale demarcazione include anche aree a quote
altimetricamente inferiori alla soglia statistica dei 600 metri,
prescindendo il parametro del dislivello dalla quota di partenza: da
un punto di vista strettamente altimetrico, infatti, la montagna oltre i
600 metri di quota supera di poco gli 84 000 kmq, pari al 31,4 per
cento del territorio nazionale, e solo tre regioni «vantano» una
superficie montana superiore al 50 per cento del territorio (Valle
d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Abruzzo, rispettivamente con il 97, il
92 e il 52 per cento del territorio regionale).
Questi parametri di demarcazione netta di ciò che è/non è
montagna hanno prestato in passato e presteranno sempre il fianco
a discussioni e polemiche. Summum ius summa iniuria, verrebbe da
dire: nel tentativo di essere il piú possibile precisi si giunge a esiti
quanto meno curiosi, come quello dei comuni delle Cinque Terre in
Liguria, in cui Manarola e Corniglia non sono classificati comuni
montani, mentre Riomaggiore, Monterosso e Vernazza sí; oppure si
ottiene l’esito opposto di una montagna troppo «larga», che porta
alle «comunità montane al livello del mare» denunciate nel libro La
casta, esito di una serie di leggi regionali che nella definizione di
«comunità montana» hanno incluso comuni contermini che montuosi
non sono (concetto che si potrebbe estendere, di contermine in
contermine, all’intera penisola italiana, osserva Gian Antonio
Stella)7. Si tratta però di situazioni assolutamente plausibili, laddove
la montagna scende letteralmente a picco sul mare, come nelle
coste liguri, campane o calabresi. Il problema, a ben vedere, è un
altro: definire condizioni di svantaggio socioeconomico sulla base di
meri parametri altimetrici.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo