Maghi, guerrieri e guaritori – Gli archetipi della politica italiana – Fabrizio Luisi
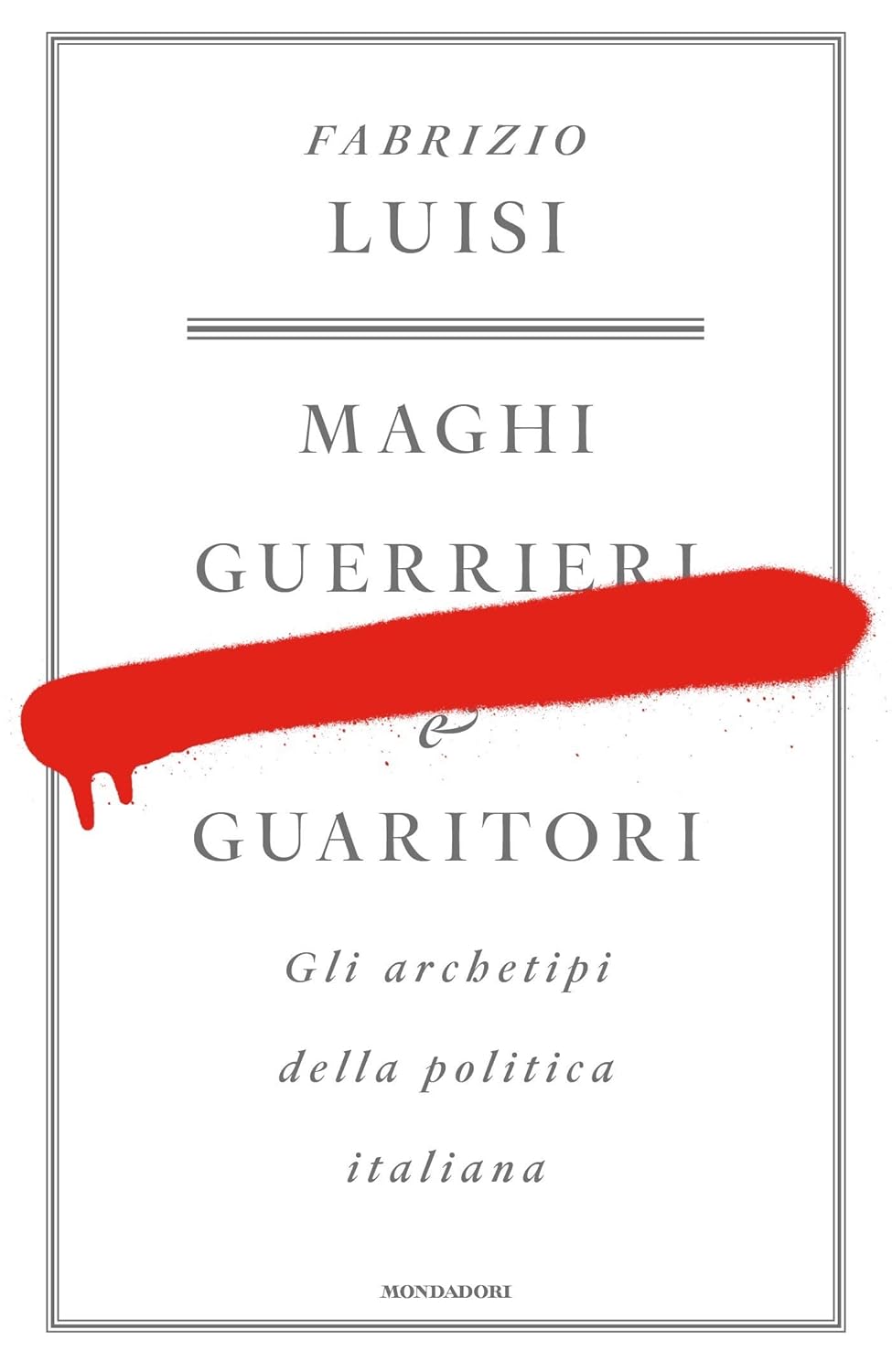
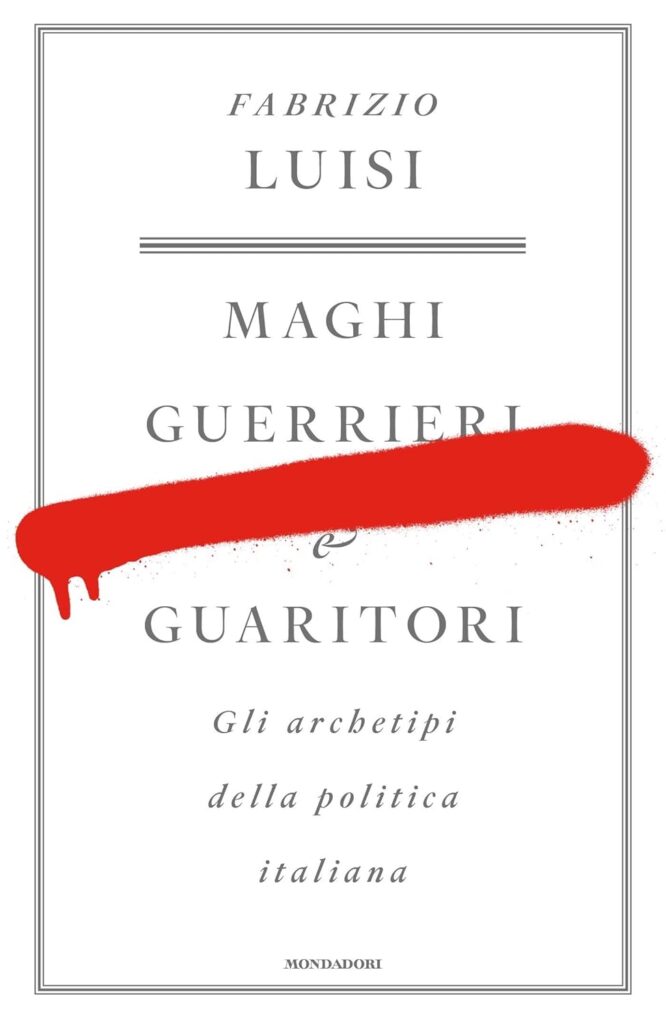
SINTESI DEL LIBRO:
Le narrazioni sono stru ure complesse, costituite da stru ure più
semplici che possiamo chiamare frame. A sua volta, il frame è
costituito da elementi fondamentali chiamati «metafore».
Il conce o di frame si deve a Daniel Kahneman e Amos Tversky
ed è stato poi impiegato nello studio della comunicazione politica da
George Lakoff, professore di scienze cognitive e linguista, che lo
definisce come una cornice mentale che determina la nostra visione
del mondo, e di conseguenza i nostri obie ivi, i nostri proge i, le
nostre azioni e i loro esiti. I frame fanno parte delle stru ure
cognitive con cui pensiamo. Stru urano un’enorme porzione del
nostro pensiero e operano dall’inconscio. È stato calcolato che il 98
per cento dell’a ività mentale ha luogo senza che ne siamo
consapevoli: usiamo queste narrazioni in modo automatico, senza
controllo conscio e senza memoria.
Inoltre è stato scoperto che queste narrazioni sono istanziate
f
isicamente nel nostro cervello: i conce i sono fissati nei circuiti
neurali. De o in altre parole: il significato è incorporato. Le idee
formulate dal nostro cervello dipendono prima di tu o dalla nostra
anatomia, dal modo in cui noi come esseri umani ci relazioniamo
con lo spazio a orno al nostro corpo e con gli altri esseri viventi. È il
cervello connesso al corpo in azione nel mondo fisico e sociale che dà
significato e fondamento alla ragione. Il modo in cui pensiamo
modella il linguaggio e il linguaggio modella il modo in cui
pensiamo. E noi pensiamo metaforicamente.
LE METAFORE
Le metafore sono gli elementi fondamentali di cui si compone un
frame. Fra i diversi tipi di metafore, Lakoff ne individua un gruppo
che chiama «metafore primarie», le quali emergono proprio
dall’esperienza del corpo e dai suoi bisogni più istintivi.
Per esempio, il corpo sta bene se può stare in posizione ere a: un
essere umano in piedi è vivo e in forze, se sta seduto è stanco, se è a
terra potrebbe essere morto. Da qui lo «stare in piedi» ha assunto
una connotazione positiva, mentre il contrario è negativo («questo
proge o non sta in piedi»; «l’ho a errato»). Questa connotazione ha
generato ulteriori livelli di astrazione: stare in alto in posizione ere a
significa moralità («re itudine», «elevati principi morali», «a schiena
dri a») mentre stare in basso significa immoralità («compiere una
bassezza», «abbassarsi a», «essere un serpente», «so obanco»). E
ancora: il nostro corpo ha bisogno dell’esposizione solare e sta bene
se è alla luce, e quindi la luce è associata a valori morali positivi,
mentre il buio a valori negativi («avere un’illuminazione»,
«chiaramente»; «una vicenda oscura»).
Il corpo sta bene se mangia cibo sano e sta male se mangia cibo
avariato, e quindi la freschezza è positiva, il marcio è negativo («i
tempi sono maturi», «succoso»; «guasto»; «la faccenda puzza», «non
ho digerito questa decisione»). Il corpo sta bene se è in salute e male
se è in mala ia («sano per il paese»; «una politica malata»). Il corpo
valuta gli altri corpi come fisicamente a raenti oppure no («una bella
situazione»; «un bru o affare»…).
A partire da queste metafore primarie, di pari passo alla
costruzione sociale e culturale del pensiero, si sviluppano metafore
più complesse, ma riconducibili sempre allo stesso principio: come
esseri umani abbiamo la necessità di tradurre il più possibile i
processi interiori e i conce i astra i in metafore incarnate nel nostro
corpo che agisce nel tempo e nello spazio. Per esempio: la vita la
raccontiamo come un viaggio, come un movimento da un punto a
un altro («la mia relazione va avanti», «c’è stata una svolta», «sono
arrivato a un decisione»); conseguire uno scopo è come raggiungere
una destinazione («raggiungere un obie ivo»); raccontiamo le
difficoltà come ostacoli al movimento («sul lavoro sono un po’
bloccato»); associamo l’intimità emotiva alla vicinanza nello spazio
p
(«ti sono vicino»); i pensieri sono ogge i in movimento («seguire un
ragionamento»), e così via.
TRE ESEMPI DI FRAME
Compreso che il modo con cui leggiamo la realtà è essenzialmente
metaforico, capiamo meglio cosa intendiamo con frame.
Il frame è quella stru ura mentale che organizza le metafore in
una cornice di significato grazie all’a ribuzione di certi ruoli e di una
sequenza di azioni, ovvero di un racconto molto semplice. Per
capirci meglio, ecco tre esempi di frame.
Un’azione elementare come afferrare un ogge o è un frame:
prevede dei ruoli – chi afferra, l’ogge o afferrato, la parte del corpo
usata per afferrare – e un racconto: il braccio avvicina la mano
all’ogge o, la mano si apre, la mano tocca l’ogge o, la mano si
chiude sull’ogge o, il braccio e la mano portano l’ogge o alla
destinazione desiderata. Quindi un frame contempla dei ruoli, delle
relazioni tra i ruoli e delle azioni messe in a o da coloro che
interpretano i ruoli.
La somma delle immagini e delle formule a cui pensiamo quando
sentiamo la parola «deli o» è un frame. Il deli o prevede come ruoli
la vi ima, l’assassino, l’investigatore, i testimoni, l’arma, le tracce, gli
indizi. E come azioni prevede l’investigatore che compie le indagini,
scopre il colpevole e lo ca ura, il colpevole che fa di tu o per non
farsi prendere, il testimone che viene intervistato in televisione, e
tanti altri. Esempi analoghi possono essere la guerra, il matrimonio,
l’esame di maturità, ecc.
Come scoperto dal sociologo Erving Goffman, le principali
istituzioni sono stru urate da frame. Per esempio, l’ospedale, la
scuola, l’esercito prevedono tu i dei ruoli e dei racconti molto
precisi. L’ospedale prevede un paziente che ha un problema, un
medico che è incaricato di risolverlo, l’infermiere, lo specialista, il
primario, l’acce azione, l’a esa o l’operazione d’urgenza, ecc.
Come potete immaginare, i frame in cui siamo immersi sono
tantissimi. Il punto è che più è familiare e condiviso il frame a cui mi
appello, e più la mia affermazione apparirà familiare e condivisibile.
LE PAROLE SONO IMPORTANTI
Un frame è di solito accompagnato da un suo campo semantico: un
gruppo di parole correlate fra loro. Le parole nominano gli elementi
di un frame e li rendono usabili. Assegnare dei nomi ai vari elementi– siano essi personaggi, strumenti, azioni – è infa i il primo passo
per la costruzione del frame. Allo stesso tempo le parole hanno il
potere di evocare interi frame preesistenti. Se per raccontare un
dissidio interno alla maggioranza di governo dichiaro qualcosa sul
genere: «Le coppie che non litigano mai di solito è perché hanno
smesso di amarsi», sto evocando il frame del fidanzamento; se invece
dichiaro che «abbiamo opinioni diverse sulla strategia da ado are
ma abbiamo chiaro qual è il nemico da sconfiggere», sto evocando il
frame della guerra e del governo come esercito.
A questo aspe o il politico deve stare molto a ento. Se per
sostenere il mio argomento uso parole che a ivano il frame del mio
avversario, il mio argomento scompare e tu o ciò che sto facendo è
rafforzare il racconto del mio antagonista.
Per esempio, se parlo di «pressione fiscale», evoco il frame
neoliberista che vede le tasse come un peso da scrollarsi di dosso e lo
Stato come un ostacolo all’iniziativa individuale.
Insomma, le parole sono importanti, come dice il maestro. Ma non
tu e, non sempre. Sono importanti quelle che a ivano determinati
frame. Ma quindi gli slogan, gli hashtag servono oppure no? Gli
slogan sono efficaci solo se a ivano dei frame già esistenti e se
contribuiscono a rinforzare dei frame in costruzione, nell’ambito di
campagne che durano se imane, mesi e anni. Quindi non si può
pensare di cavarsela con uno slogan, senza lavorare anche al frame.
Per citare un piccolo esempio recente, verso la fine del 2019,
pensiamo alla capacità e alla rapidità di mobilitazione innescata dal
movimento delle «sardine». Sardine perché mute come pesci in
un’epoca di politica urlata, sardine perché la modalità di
partecipazione scelta era un flash mob di piazza in cui ci si
ammassava uno di fianco all’altro, stre i stre i, sardine perché non
abboccano all’amo di Salvini. Niente di così diverso da infinite altre
manifestazioni di piazza del passato. Ma tu o differente sul piano
narrativo. Una parola nuova, dal significato immediatamente
riconoscibile e particolare, è bastata a costruire una nuova identità
politica, simbolicamente chiara e allo stesso tempo politicamente
abbastanza vaga da accogliere chiunque si opponga alla destra. C’era
evidentemente un bisogno latente, inespresso, che aveva necessità di
un’a ivazione metaforica e narrativa per esprimersi.
Il rilancio mediatico è stato immediato, poiché i media sono
sempre affamati di metafore e di racconti nuovi. Le sardine hanno
poi dato vita a una vera e propria animal wave: a ivisti di destra si
sono soprannominati «pinguini», a ivisti di sinistra radicali hanno
rivendicato la parola «piranha», Salvini ha risposto con l’immagine
di un ga ino che mangia un pesce e lo slogan «Ga ini con Salvini»,
evocando il frame della catena alimentare e della naturale,
inesorabile superiorità del predatore sulla preda, e allo stesso tempo
rivendicando i ga ini come parte del proprio immaginario.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo