Magellano – Stefan Zweig
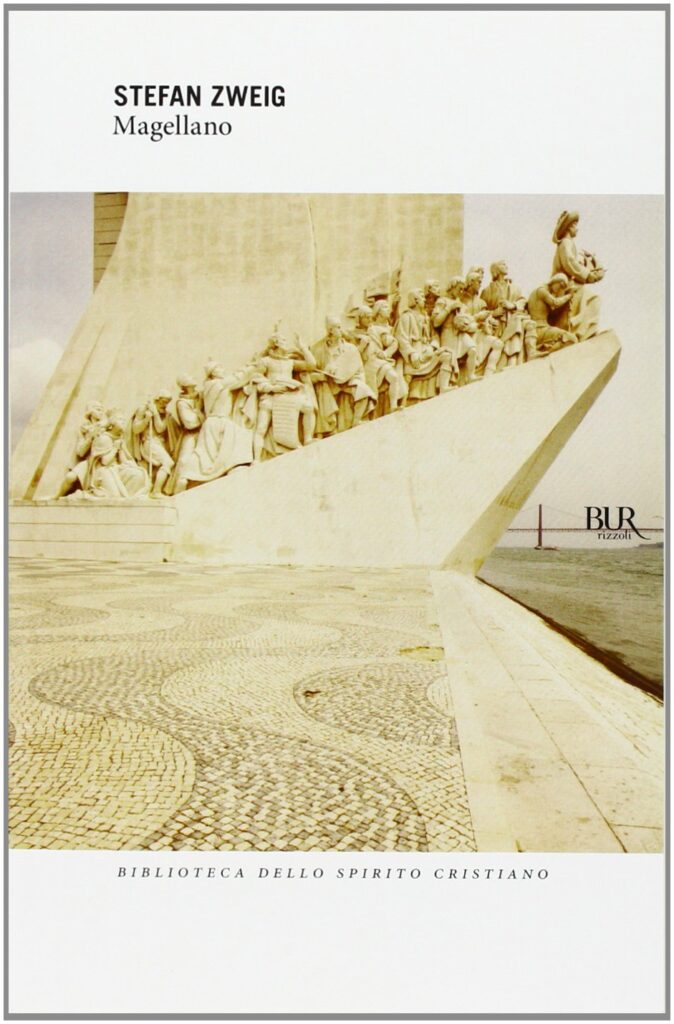
SINTESI DEL LIBRO:
In principio erano le spezie.» Da quando i romani per la prima volta
durante i loro viaggi e le loro spedizioni militari gustarono i
condimenti brucianti, eccitanti, aromatici e inebrianti del lontano
Oriente, l’Occidente non sa più rinunciare né in cucina né in cantina
alle droghe indiane, alle spezie. Non bisogna dimenticare che per
tutto il Medioevo i cibi nordici erano rimasti incredibilmente scipiti e
monotoni. Doveva passare molto tempo ancora prima che i frutti più
comuni della terra, come la patata, il granoturco e il pomodoro, si
acclimatassero durevolmente in Europa; era ancora quasi ignoto il
limone per dare acidità, lo zucchero per addolcire, non s’erano
scoperti il caffè e il tè tonificanti; perfino alle tavole dei sovrani e dei
ricchi la volgare ingordigia faceva dimenticare la noiosa uniformità
dei pasti. Ma ecco il miracolo: basta un granello di spezie indiane, un
pizzico di pepe, un chiodo di garofano, una puntina di cannella o di
zenzero aggiunto alle vivande più usuali per far provare al palato un
eccitamento esotico e squisito. Fra il deciso diesis e il bemolle del
dolce e dell’agro, fra scipito e sapido, vibrano d’un tratto numerose e
squisite tonalità culinarie; ben presto le papille gustative ancor
barbare del Medioevo non riescono a saziarsi dei nuovi godimenti.
Una vivanda non è più perfetta se non è pepata e drogata alla
diavola; si mette lo zenzero perfino nella birra, e tritandovi certe
droghe si accende il vino a tal punto che basta un sorso a bruciare la
gola come polvere da sparo. Ma non soltanto per la cucina
l’especería è richiesta dall’Occidente; anche la vanità femminile
reclama insaziabile i profumi d’Arabia, sempre nuovi: il voluttuoso
muschio, la greve ambra, la dolce essenza di rosa; tintori e tessitori
devono preparare sete e damaschi indiani, gli orafi procurarsi le
perle bianche di Ceylon e i diamanti azzurri di Narsingar. La Chiesa
cattolica favorisce moltissimo l’uso di prodotti orientali, giacché non
uno dei miliardi e miliardi di granelli d’incenso che fumano negli
incensieri di migliaia di chiese europee è cresciuto in terra europea;
ognuno di quegli infiniti granelli deve essere trasportato per terra e
per mare, compiendo l’interminabile percorso sin dall’Arabia. Anche i
farmacisti sono clienti perenni delle celebrate droghe indiane, come
l’oppio, la canfora, la preziosa gomma; sanno per esperienza che
nessun balsamo o nessuna medicina sembrano veramente salutari
ai malati se sui barattoli di ceramica non si legge a lettere azzurre la
magica parola arabicum oppure indicum. Tutto ciò che viene
dall’Oriente acquista ineluttabilmente, per la sua esoticità, la sua
rarità e forse anche il caro prezzo, una suggestione ipnotica.
Arabico, persiano, indostano nel Medioevo (come nel Settecento
francese) sono sinonimi di raffinato, elegante, aulico, prezioso e
costoso; non vi è articolo di commercio tanto ricercato quanto le
spezie; parrebbe quasi che il profumo di questi fiori orientali abbia
per strana magia inebriato l’anima dell’Europa.
Ma appunto perché tanto desiderata dalla moda, la merce indiana
rimane cara e diventa sempre più cara. Difficilmente riusciamo oggi
a valutare la crescente curva di quei prezzi, giacché tutte le tabelle
finanziarie del passato rimangono una astrazione; una visione più
concreta di questa sopravvalutazione si può raggiungere ricordando
che al principio del secondo millennio quello stesso pepe che oggi è
a disposizione di tutti su ogni tavola di osteria, e viene sciupato
come la sabbia, veniva, allora, contato granello per granello e valeva
pressappoco quanto l’argento. Anzi, il suo valore era così sicuro che
molti stati e molte città facevano i loro calcoli in base al pepe, quasi
si trattasse di un nobile metallo. Col pepe si poteva comprare fondi e
case, costituire doti, ottenere una cittadinanza; principi e città
stabilivano i loro dazi partendo da misure di pepe: nel Medioevo, per
indicare un ricco sfondato, si diceva che era «un sacco di pepe».
D’altra parte lo zenzero e la cannella, la corteccia di china e la
canfora, venivano pesate su bilance di precisione, chiudendo
accuratamente porte e finestre perché un soffio d’aria non portasse
via neppure un briciolo di quelle preziose polverine. Per quanto
appaia assurda a noi moderni questa sopravvalutazione, essa
diventa spiegabile appena si pensi alle difficoltà e al rischio dei
trasporti. In quei tempi l’Oriente è incommensurabilmente lontano
dall’Occidente, e a quali pericoli sono esposte le navi, le carovane, i
carri prima di giungere! Quale odissea deve superare ogni granello,
ogni fiore, prima di giungere dal cespuglio verdeggiante
dell’arcipelago malese al suo ultimo approdo, sul banco del
rivenditore europeo! In sé nessuna di queste droghe sarebbe una
rarità. Dall’altra parte dell’emisfero le bacchette di cannella di Tidore,
i
garofani di Amboina, le noci moscate di Banda, gli alberi del pepe
del Malabar crescono con la stessa abbondanza con cui da noi
vengono i cardi, e un mezzo quintale di quelle spezie non vale in
quelle isole più di quanto valga in Europa una piccola presa di esse.
Ma maneggiare deriva da mano, e per molte mani deve passare la
merce prima di poter giungere, attraversati mari e deserti, all’ultimo
compratore che l’userà. La prima mano è sempre la meno
compensata: lo schiavo malese, che coglie i fiori ancor freschi e li
porta sul suo bruno dorso al mercato, non ha per compenso altro
che il proprio sudore. Ma il suo padrone già ci guadagna: il mercante
maomettano gli comprerà tutto il carico e con esso navigherà su una
piccola canoa, sotto il sole ardente, per otto o dieci giorni, dalle Isole
delle Spezie sino a Malacca, in vicinanza della odierna Singapore.
Qui l’aspetta già il primo grosso ragno appostato nel centro della
ragnatela: il sovrano del porto, il sultano di Malabar, esige dal
mercante un tributo per lo scarico. Pagato questo dazio, il frutto
odoroso potrà essere ricaricato sopra una giunca più capace e
sicura, e così procederà, spinto lentamente da larghi remi o da una
vela quadrata, da un posto dell’India all’altro. Passano così i mesi
nella monotonia di una navigazione a vela interrotta da infinite attese
nella bonaccia, sotto un cielo ardente senza nubi, o da improvvise
fughe di fronte ai tifoni e ai corsari. Con indicibile pena, con
incredibili pericoli il trasporto continua attraverso i due o tre mari
tropicali: di cinque imbarcazioni ce n’è sempre almeno una che
perisce vittima delle bufere o dei pirati, e il mercante ringrazia Dio
quando finalmente raggiunge Ormuz o Aden, e con ciò trova
accesso all’Arabia felix o all’Egitto. Ma il nuovo genere di carico che
qui si inizia non è meno complicato e pericoloso. A migliaia, disposti
in lunghe file, attendono impazienti negli scali i bravi cammelli, si
inginocchiano docili a un cenno del padrone e l’uno dopo l’altro
vengono caricati e legati sulle loro groppe i sacchi e le balle con il
pepe e le droghe, che essi porteranno, grandi navi a quattro zampe,
dondolando lentamente sull’immenso mare di sabbia. Le carovane
arabe viaggiano per mesi e mesi (ci ritornano all’orecchio i nomi
delle Mille e una notte) e, passando per Bassora, Bagdad e
Damasco, giungono a Beirut e Trebisonda, oppure per Gedda
toccano Il Cairo. Queste lunghe vie carovaniere del deserto sono
antichissime, note ai mercanti sin dai tempi dei faraoni e dei
battriani; ma sciaguratamente anche i beduini, i pirati del deserto, le
conoscono altrettanto bene, e spesso un attacco improvviso
distrugge di colpo il carico e il profitto di innumerevoli mesi di lavoro.
Ciò che è sfuggito felicemente alle tempeste di sabbia e ai beduini
può ancora allettare altri masnadieri; per ogni carico di cammello,
per ogni sacco di merce gli emiri dell’Heggiaz, i sultani della Siria e
dell’Egitto esigono un tributo assai alto; si calcola che soltanto
quest’ultimo sfruttatore egiziano intaschi ogni anno per il pedaggio
delle spezie centomila ducati. Quando alla fine è raggiunta la foce
del Nilo presso Alessandria, ivi è in attesa l’ultimo e non il più
trascurabile dei profittatori: la flotta di Venezia. Dopo la perfida
distruzione della grande concorrente Bisanzio, la piccola repubblica
ha conquistato completamente il monopolio del commercio delle
droghe per l’Occidente; invece di essere ricaricata e inoltrata
direttamente, tutta la merce va portata prima a Rialto, dove i
compratori di Germania, di Fiandra e d’Inghilterra potranno
acquistarla. Solo allora, su carri dalle solide ruote, quei fiori maturati
e fermentati due anni prima dal sole tropicale supereranno fra le nevi
e il ghiaccio i passi alpini, raggiungeranno il mercato europeo e,
finalmente, il consumatore.
Per almeno dodici mani, constata malinconicamente Martin
Behaim, tracciando il suo celebre «globo» nel 1492, devono passare
le spezie indiane soggette a usura prima di giungere a quelle del
consumatore. Ma se anche dodici mani si dividono quel guadagno,
ciascuna riesce a spremerne un sufficiente rivolo d’oro; malgrado i
rischi e i pericoli, il commercio delle spezie è considerato, nel
Medioevo, il più redditizio, perché al minimo volume della merce fa
riscontro il massimo margine di guadagno. Se anche di cinque navi
(la spedizione di Magellano proverà questo fatto) quattro andranno a
picco con tutto il carico, se anche duecento uomini su
duecentosessantacinque non torneranno più, i marinai e i capitani ci
rimetteranno la vita, ma i mercanti in quella partita guadagneranno
sempre. Basta che la più piccola di quelle cinque imbarcazioni ritorni
dopo tre anni ben carica di droghe, perché quella sola merce
compensi le perdite con largo profitto: un solo sacco di pepe a quei
tempi valeva più di una vita umana. Non vi è dunque da stupirsi se,
data la grande disponibilità di vite senza valore e la intensa richiesta
di preziosissime droghe, i conti tornano sempre benissimo. I palazzi
di Venezia e quelli dei Fugger e dei Welser sono stati eretti quasi
esclusivamente coi guadagni delle spezie.
Ma inevitabilmente, come la ruggine al ferro, l’invidia si
accompagna ai grandi guadagni. Sempre il privilegio dell’uno vien
sentito dagli altri come ingiusto, e dove un piccolo gruppo si
arricchisce oltre misura, va formandosi spontaneamente una
coalizione degli esclusi. I genovesi, i francesi, gli spagnoli già da
tempo guardano di malocchio la troppo abile Venezia, che ha saputo
avviare quell’aurea corrente fino al Canal Grande. Guardano con
ancor più acuta amarezza all’Egitto e alla Siria, dove l’islam ha eretto
un muro insuperabile fra l’India e l’Europa. Nessuna nave cristiana
può veleggiare sul Mar Rosso, nessun mercante cristiano ha il
permesso di transito; il commercio dell’India passa con inesorabile
esclusività per le mani dei mercanti turchi e arabi. In questo modo
non solo si fa rincarare la merce per i consumatori europei, non solo
si toglie al commercio il primo profitto, ma c’è anche la minaccia che
la pletora d’oro fluisca verso l’Oriente, giacché le merci d’Europa non
raggiungono neppure da lontano il valore delle preziose importazioni
indiane. Già per questo deficit commerciale sensibilissimo doveva
farsi sempre più intensa l’impazienza dell’Occidente a sottrarsi al
rovinoso e umiliante controllo. Finalmente le energie si raccolgono,
le
crociate non furono (come spesso fu detto per renderle
romantiche) un tentativo puramente mistico di strappare agli infedeli
il
santo sepolcro; questa prima coalizione europea e cristiana
rappresentò anche il primo logico o cosciente sforzo per infrangere
lo
sbarramento verso il Mar Rosso e liberare e conquistare
all’Europa e al cristianesimo il commercio orientale. Essendo fallito
quel colpo, cioè non essendosi potuto strappare l’Egitto ai
maomettani e continuando l’islam a chiudere la via dell’India, era
inevitabile si ridestasse il desiderio di trovare una via per l’India
nuova e indipendente. L’audacia che spinse Colombo verso ovest,
Bartolomeo Diaz e Vasco da Gama verso sud, Caboto verso nord,
cioè verso il Labrador, derivò soprattutto dalla cosciente volontà
degli europei di scoprire finalmente, per il mondo occidentale, una
via d’acqua libera, senza dazi e senza ostacoli, sino all’India,
infrangendo così l’odioso predominio dell’islam. Sempre, nelle grandi
invenzioni e scoperte, una molla spirituale e morale è la vera forza
determinante; ma per lo più la spinta decisiva all’attuazione pratica
viene data da moventi materiali. Certo i sovrani di Spagna e di
Portogallo, con i loro consiglieri, si saranno entusiasmati, in nome
delle audaci concezioni, alle proposte di Colombo e di Magellano,
ma mai avrebbero arrischiato le somme necessarie per attuare i loro
piani, né principi e speculatori avrebbero armato una flotta senza la
concomitante speranza che il viaggio di scoperta avrebbe
compensato mille volte la somma arrischiata. Dietro agli eroi dell’età
delle grandi scoperte ci sono, come energia propulsiva, i
commercianti; anche questo magnifico impulso epico alla conquista
del mondo ha preso le mosse da forze molto terrene: «Nel principio
erano le spezie!
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :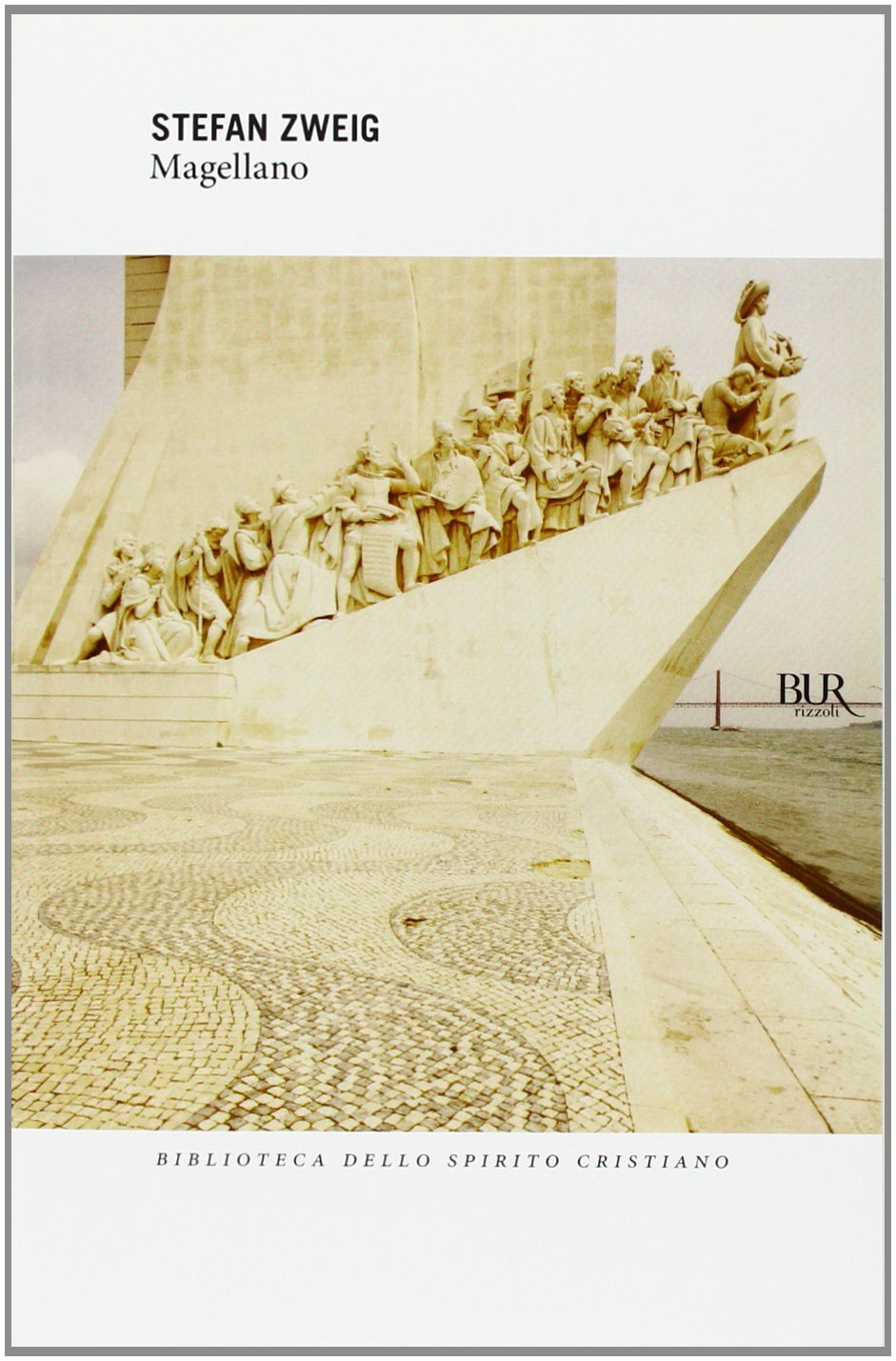





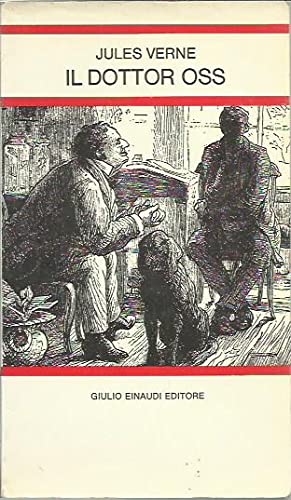
Commento all'articolo