L’ultima leonessa – Costanza Afan De Rivera
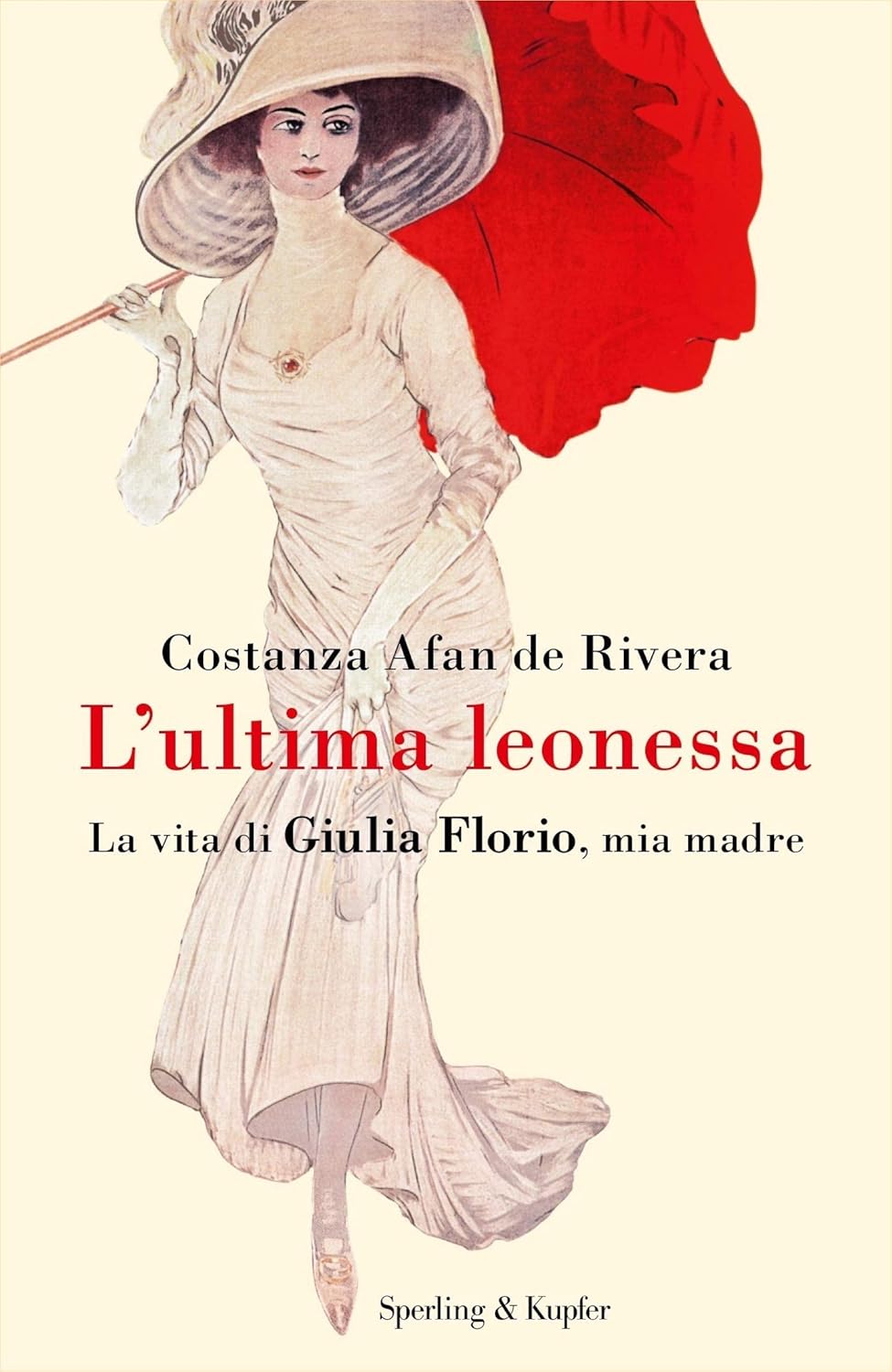
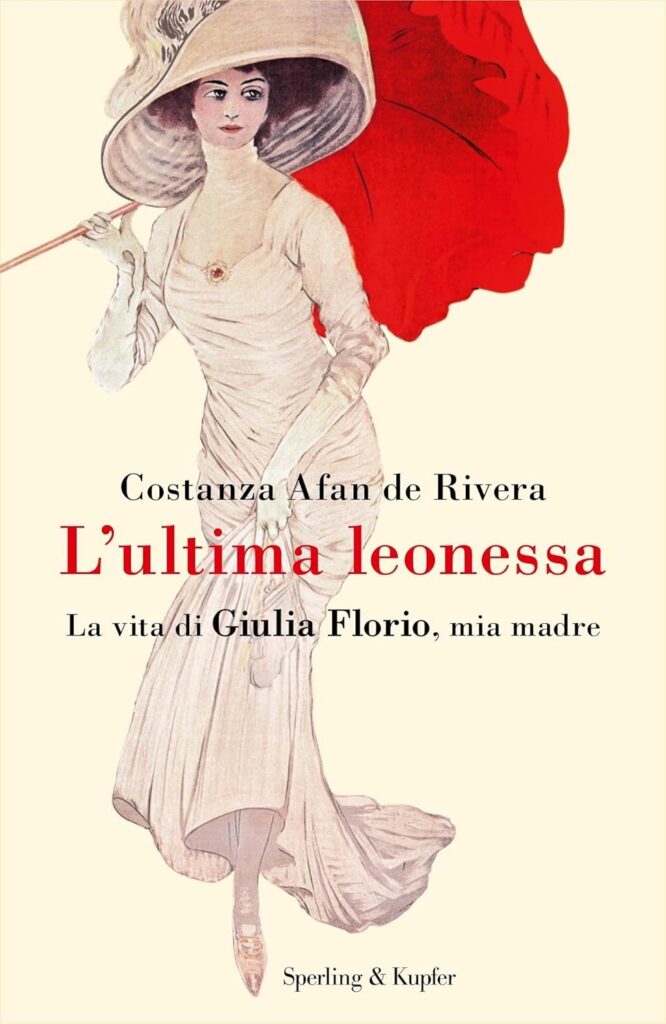
SINTESI DEL LIBRO:
DONNA Franca, mia nonna, si a accò al boccaporto con tu e le sue
forze, il mare era grosso, l’aria gelida le schiaffeggiava il viso.
Malgrado tu o non aveva scelta. Si affacciò in direzione del vento
appena in tempo per rovesciare in mare anche l’anima.
Non aveva mangiato nulla da quando erano partiti, eppure i
conati di vomito si susseguivano frequenti e inarrestabili.
«È bile, è il prezzo da pagare. Ogni donna lo sa», mormorò fra sé,
quasi per darsi coraggio. «Ma non sarà certo un figlio in arrivo a
fermarmi.»
Aveva bisogno di sentirsi viva, di dare un nuovo senso
all’esistenza che si stava spegnendo troppo in fre a in un rincorrersi
di fatalità. Anche quello era un prezzo da pagare: l’eccesso di
esposizione a ira sempre la ia ura, le maledizioni degli invidiosi
colpiscono a tradimento. Troppo. Del resto, in casa Florio tu o è
sempre stato troppo: il lusso, il denaro, la bellezza, il potere, le
amicizie altolocate… e le disgrazie.
«Per vincere il proprio dolore bisogna abbracciarne uno più
grande. Verrò con te a Messina, ad aiutare quegli sciagurati», aveva
risposto con determinazione al marito che avrebbe preferito lasciarla
riposare per qualche altro mese a Favignana. Erano le parole di un
f
ilosofo tedesco, le e in un’opera che aveva sfogliato per distrarsi dal
tedio dell’inoperosità.
Greny, come noi nipoti l’abbiamo sempre chiamata, di Favignana
non ne poteva più. Aveva pianto infinite lacrime segrete, non aveva
più nulla da perdere. Consapevole che nulla avrebbe potuto opporre
o rimediare contro un fato crudelissimo che si era fa o beffe di lei. In
pochi anni le aveva elargito e presto strappato tre figli. Le era stata
so ra a la gioia della maternità, restava solo la bruciante memoria
dei fastidiosi mesi d’a esa. Non voleva più pensarsi madre, meditare
una letizia che il destino forse le avrebbe negato ancora una volta,
dunque avrebbe fa o meglio a vivere il presente. Di colpo si riscosse
come da un’ubbriacatura.
C’era Igiea. Non l’aveva certo dimenticata, la figlia della salute era
la sua unica consolazione.
Il presente aveva un sapore così diverso dai tempi spensierati
dell’altro secolo!
In famiglia la chiamavano tu i amorevolmente Checchina, era la
f
iglia di Pietro, fratello minore di Salvatore Jacona barone di San
Giuliano. La madre era Costanza Notarbartolo, figlia del duca di
Villarosa. Tu avia la quantità di titoli di famiglia era dire amente
proporzionale alla quantità di debiti accumulati nel corso dei
decenni, ma Checchina non se n’era mai resa realmente conto. Un
crescente stillicidio di ipoteche le aveva permesso di vivere sempre
nell’agio, circondata da un lusso superiore a quel che avrebbe potuto
perme ersi, bellissima bambina e poi giovine a, vezzeggiata e
coccolata da tu i.
Molto diversa dal fratello, quel «povero Franz», come tu i lo
chiamavano, che non brillava certo per acume. Il ragazzo non era
molto istruito né intelligente, perciò tenuto in ombra e con il
sopraggiungere della maturità il tribunale di Palermo lo avrebbe poi
interde o e posto so o la tutela della moglie, una solerte infermiera
che si era votata al suo accudimento o enendo in cambio la rendita
dell’agrumeto di Bagheria.
Non era stato certo un problema per Franca, che non si
rammaricava neanche di non aver potuto frequentare i grandi collegi
europei per signorine, allora molto in voga, compiaciuta da
innumerevoli lusinghe, tanto più efficaci perché provenienti da altre
dame.
«Elle était si merveilleusement belle que de la regarder seulement c’était
une veritable fête pour les yeux. Elle était certainement la plus belle femme
d’Europe», scriveva di lei la cugina Francesca di Villarosa contessa
d’Orsay.
A sedici anni era già una giovane irresistibilmente affascinante,
riconosciuta da tu i come la più bella donna d’Europa, un privilegio
che avrebbe resistito indenne a ogni tempesta, l’unica costante della
sua vita. Anche se, così stravolta dalla nausea e dalla lama gelida del
vento no urno, forse, qualcuno avrebbe potuto dubitarne.
* * *
So raendosi alla vista di chiunque, svuotata di ogni energia, si
trascinò in cabina. Neanche la sua cameriera personale avrebbe
dovuto vederla in quello stato. Il laudano, unico amico discreto, le
venne in soccorso e la consegnò a una breve tregua fino all’alba. Un
sonno cui si abbandonò viaggiando a ritroso nella memoria.
Inevitabile che il destino l’avesse spinta fra le braccia del più
desiderabile scapolo di Palermo.
D’altra parte lui, come lei, era abituato a o enere dalla vita e dal
mondo la realizzazione di qualsivoglia desiderio. E così era stato. Gli
sguardi prudenti avevano presto ceduto il posto a biglie i infuocati e
a baci furtivi. Si incontravano lungo la spiaggia dell’Acquasanta,
testimone muto un capanno da pesca abbandonato. Tu avia le
famiglie avevano manifestato una certa diffidenza, specialmente la
madre di lui, rimasta improvvisamente vedova nel maggio del 1891,
e il padre di lei che aveva deciso repentinamente di trasferire la
residenza a Livorno.
Ignazio Florio aveva dovuto reagire in fre a al dolore per la
perdita del padre. Era l’unico dei tre eredi – il fratello minore era
appena un bambino, la sorella Giulia era già diventata moglie del
principe di Trabia – in grado di prendere in mano le redini delle
a ività della più facoltosa famiglia della Sicilia.
I
Florio avevano sempre goduto della stima da parte dei
dipendenti, ma dopo un paio d’anni dalla scomparsa di Ignazio
senior si era iniziato a diffondere il movimento dei Fasci dei
lavoratori siciliani e anche a Palermo vi fu un particolare fermento
fra i lavoratori della Ngi.
La Navigazione generale italiana era nata un decennio prima, con
l’appoggio politico del Crispi e del Depretis che avevano posto a
fondamento dei propositi di governo il sostegno e la
riorganizzazione dei servizi mari imi.
La maggiore compagnia di navigazione dell’epoca apparteneva
all’imprenditore genovese Raffaele Ruba ino, perennemente in crisi
f
inanziaria e alla ricerca di capitali. I ricchissimi Florio avevano le
Flo e Riunite Florio, nate dalla loro Società dei ba elli a vapore
siciliani. Si persuasero alla fusione e a finanziare la nascita di una
nuova compagnia di navigazione, certi che fosse un’opportunità di
sviluppo per il Sud. La Ngi o enne sul nascere le promesse
sovvenzioni statali e il monopolio dei servizi. Con una flo a di
o antanove piroscafi era diventata una delle più potenti del
Mediterraneo, aveva avuto grande espansione verso le Americhe
trasportando sia merci sia migranti, ma si era a irata pure la forte
ostilità degli armatori veneziani e genovesi.
Nel corso degli anni gli equilibri politici erano mutati e l’allora
ministro del Tesoro Giovanni Gioli i aveva a uato una manovra di
contenimento scegliendo di lesinare loro i sussidi. L’indo o
palermitano, che ruotava intorno alla compagnia e dava lavoro a
1.400 famiglie, allora aveva cominciato a soffrirne.
Assunta la responsabilità degli affari di famiglia, Granpapà (come
noi abbiamo sempre chiamato nonno Ignazio) era stato costre o a
procedere ad alcuni dolorosi licenziamenti, ma era riuscito a tenere a
bada le agitazioni operaie. Raggiunta la sua amata a Livorno, erano
convolati a nozze nella chiesa di San Jacopo, restaurata grazie al suo
sollecito e generoso finanziamento.
L’emergenza era stata superata grazie al rinnovo delle concessioni
mari ime statali e gli sposi erano rientrati serenamente a Palermo. Il
loro immenso palazzo rimesso a nuovo era diventato presto la meta
delle più illustri personalità e teste coronate d’Europa. Palermo
aveva sentito il pressante bisogno di sostituire la presenza del re e
l’ospitalità di casa Florio ne aveva preso disinvoltamente il posto.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo