L’uomo artigiano – Richard Sennett
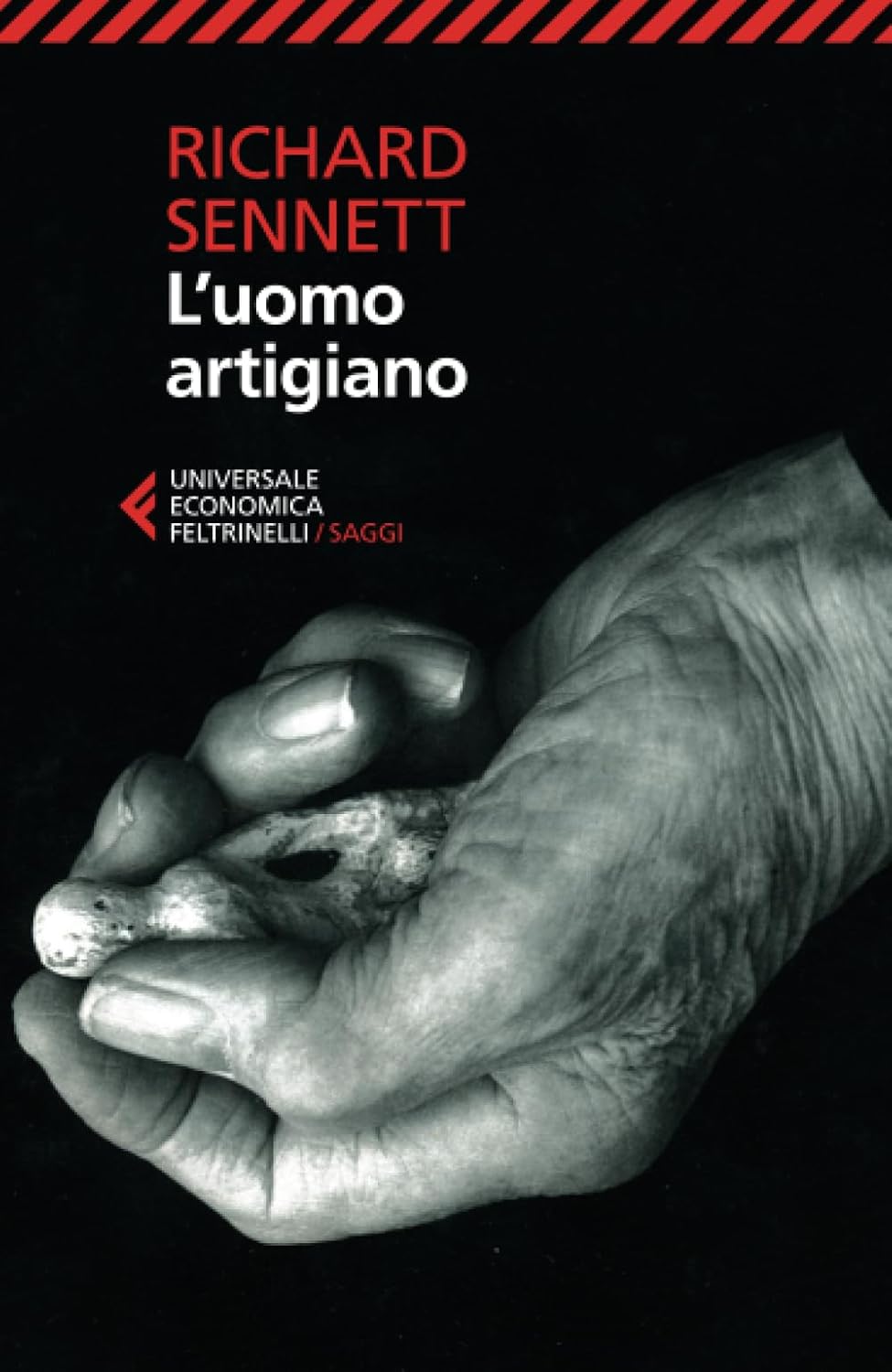
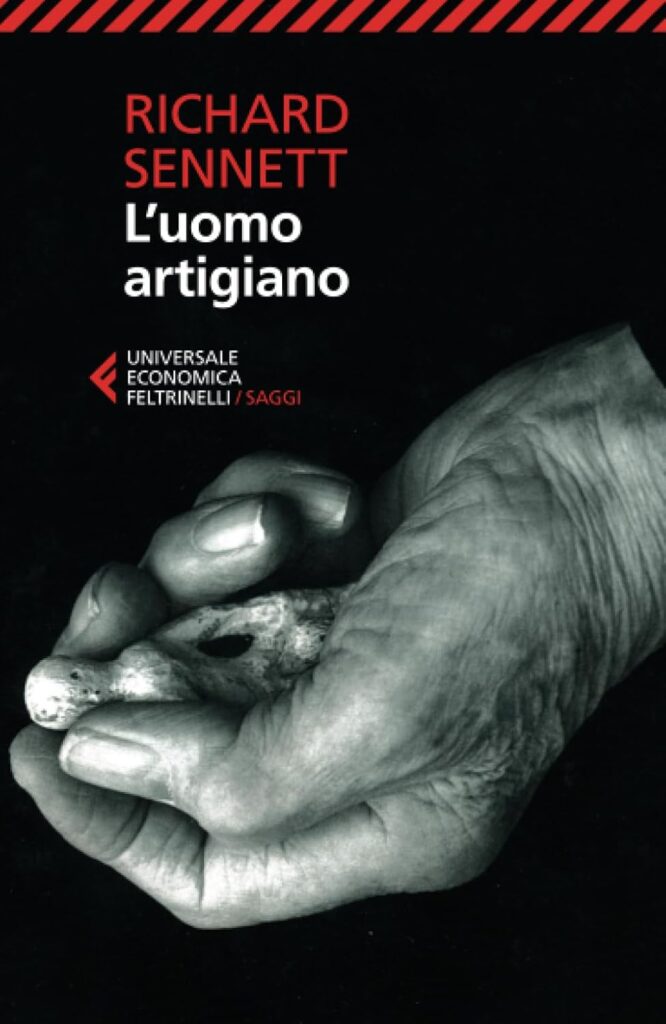
SINTESI DEL LIBRO:
La parola “artigiano” evoca immediatamente una scena. Se
spiamo dalla finestra nella bottega di un falegname, vediamo un
uomo di una certa età circondato dai suoi apprendisti e dai suoi
arnesi. L’ordine regna sovrano: parti di sedia impilate secondo il tipo,
l’odore fresco dei trucioli riempie il locale, il falegname è chino sul
suo bancone, intento a incidere con precisione le forme per un
intarsio. Ma la sopravvivenza della bottega è a rischio da quando
hanno aperto una fabbrica di mobili in serie in fondo alla strada.
Si può scorgere l’artigiano anche in un laboratorio scientifico poco
lontano. Una giovane tecnica osserva accigliata sei cavie morte,
riverse sul bancone, con la pancia aperta da un'incisione. È
preoccupata perché l’iniezione che ha praticato alle cavie non ha
dato i risultati previsti; si sta chiedendo se ha sbagliato lei
nell’eseguire l’operazione o se è sbagliato il procedimento.
Possiamo trovare un terzo artigiano nel Conservatorio cittadino.
L’orchestra sta facendo le prove di un concerto con un direttore
venuto da fuori; il direttore lavora ossessivamente sulla sezione degli
archi, fa ripetere innumerevoli volte alcune battute per ottenere la
perfetta sincronizzazione del movimento degli archetti. I musicisti
sono stanchi ma anche euforici, perché sentono che il suono
prodotto è sempre più compatto. L’amministratore è preoccupato; se
il direttore va avanti in questo modo, finisce che l’amministrazione
dovrà pagare gli straordinari agli orchestrali. Un problema che non
sfiora minimamente il direttore.
Il falegname, la tecnica di laboratorio e il direttore d’orchestra sono
tutti artigiani, nel senso che a loro sta a cuore il lavoro ben fatto per
se stesso. Svolgono un’attività pratica, ma il loro lavoro non è
semplicemente un mezzo per raggiungere un fine di un altro ordine.
Se lavorasse più in fretta, il falegname potrebbe vendere più mobili;
la
tecnica del laboratorio potrebbe cavarsela demandando il
problema al suo capo; il direttore d'orchestra sarebbe forse invitato
più spesso dalle orchestre stabili se tenesse d’occhio l’orologio.
Nella vita ce la si può cavare benissimo senza dedizione. L’artigiano
è la figura rappresentativa di una specifica condizione umana: quella
del mettere un impegno personale nelle cose che si fanno. Uno degli
intenti di questo libro è quello di spiegare come avvenga che le
persone si impegnino praticamente ma non necessariamente in
modo strumentale.
Come ho accennato nel Prologo, quando la si riferisce soltanto
all’abilità manuale, per esempio del falegname, ci si fa un’idea
insufficiente della maestria tecnica. Per evocare il lavoro
dell’artigiano il tedesco usa la parola Handwerk e il francese
l’aggettivo artisanal. La lingua inglese è meno limitativa e usa craft
(arte, mestiere) in abbinamenti di più ampia portata, come in
statecraft, l’arte di governare, l’abilità politica. Cechov applicava il
termine mastersvo sia alla sua arte di medico sia a quella di
scrittore. In questo libro mi propongo, innanzitutto, dì trattare tutte
queste pratiche concrete alla pari, come fossero laboratori nei quali
sottoporre ad analisi sentimenti e idee comuni a tutte. In secondo
luogo, voglio indagare che cosa succede quando viene introdotta
una separazione tra mano e testa, tra tecnica e scienza, tra arte e
mestiere. Mostrerò come in questo caso sia la mente a soffrirne;
intelligenza
e capacità espressiva ne vengono entrambe
compromesse.
In tutti i campi, la maestria tecnica si fonda su abilità sviluppate al
massimo grado. Per applicare un’unità di misura di uso comune: è
stato calcolato che per produrre un maestro carpentiere o un
musicista professionista occorrono circa diecimila ore di pratica.
Diversi studi indicano che l’abilità tecnica, quanto più progredisce,
tanto più viene rivolta agli aspetti problematici dell’attività, come
abbiamo visto nel caso della tecnica di laboratorio che si interrogava
sul procedimento usato, mentre le persone con livelli di abilità
elementari si preoccupano essenzialmente che le cose comunque
funzionino. Ai livelli più elevati, la tecnica non è più un'attività
meccanica; soltanto una volta imparato a svolgere bene la loro
attività, le persone sono in grado di capire a fondo, con il sentimento
e con il pensiero, quello che stanno facendo. Come dimostrerò, è al
livello della padronanza piena che emergono i problemi etici dei
mestieri tecnici.
La ricompensa emotiva per lo sforzo di raggiungere l’abilità
richiesta è duplice: il lavoratore si sente ancorato nella realtà
tangibile e può provare orgoglio per il lavoro svolto. Ma la società,
oggi come in passato, interferisce in queste gratificazioni. In vari
momenti della storia occidentale, l’attività pratica è stata svilita, vista
come irrilevante quando non estranea alla realizzazione di fini
considerati
più
nobili.
L’abilità
tecnica
è
stata
scissa
dall'immaginazione, la realtà tangibile è stata screditata dalla
religione, l’orgoglio per il proprio lavoro trattato come un lusso. Se
l’artigiano è speciale in quanto essere umano che mette un impegno
personale nel suo lavoro, tuttavia le sue aspirazioni e le sue difficoltà
rendono visibili a tutti noi questi importanti temi più generali, nel
passato e nel presente.
L’Efesto moderno
Gli antichi tessitori e i programmatori di Linux
Una delle prime celebrazioni dell’artigiano compare nell’inno
omerico a Efesto, il dio protettore degli artigiani: “Efesto, glorioso per
la destrezza, canta, o Musa dalla limpida voce: / egli, insieme con
Atena dagli occhi scintillanti, opere egregie / insegnò sulla terra ai
mortali, che fino allora / vivevano negli antri, sulle montagne, come
le fiere, / ma ora, grazie a Efesto glorioso per l’ingegno avendo
appreso le arti, / facilmente, fino al compimento dell’anno, la vita /
conducono sereni nelle proprie case”.
17 Lo spirito del poema è in
contrasto con quello della leggenda di Pandora, che prese forma più
o meno nella medesima epoca. Pandora presiede alla distruzione,
Efesto al lavoro dell’artigiano inteso come portatore di pace e
iniziatore della civiltà.
Superficialmente, l’inno a Efesto può apparire la celebrazione di
un cliché, quello che pone l’inizio della civiltà nel momento in cui gli
esseri umani cominciarono a usare utensili. Ma esso fu scritto
migliaia di anni dopo che ebbe inizio la fabbricazione di attrezzi
come i coltelli, la ruota e il telaio. Più che essere un tecnico,
l’artigiano civilizzatore è colui che ha usato quegli attrezzi per un
bene collettivo, per porre fine dell’esistenza nomadica di un’umanità
di cacciatori-raccoglitori e di guerrieri senza radici. Riflettendo
sull’inno omerico a Efesto, uno storico moderno scrive che, appunto
perché la manifattura “aveva liberato gli individui dall'isolamento,
personificato dai cavernicoli Ciclopi, artigianato e comunità erano,
per i greci arcaici, indissolubili”.
18
La parola greca che traduciamo con artigiano è demiourgos, un
composto che unisce l’idea di pubblico (demios: “appartenente al
popolo”) e di produzione (ergon: “opera, lavoro”). L’artigiano dell’età
arcaica occupava una fascia sociale equivalente grossomodo alla
nostra classe media. I demiourgoi, oltre ai lavoratori manuali
specializzati, come i vasai, comprendevano anche i medici e i
magistrati minori, nonché gli aedi professionisti e gli araldi o
banditori, coloro che annunciavano nelle strade notizie di interesse
pubblico. Questa fetta di cittadini comuni si situava nel mezzo tra gli
aristocratici, relativamente pochi e liberi dalla necessità di
guadagnarsi da vivere, e la massa degli schiavi, che svolgevano
quasi tutto il lavoro necessario alla società ed erano in molti casi
dotati di elevate abilità tecniche, che non gli conferivano però
riconoscimento e diritti politici.
19 Fu nel contesto di tale società
arcaica che l’inno a Efesto celebrò come civilizzatori coloro che
sapevano usare congiuntamente la testa e la mano.
La Grecia arcaica, al pari di molte società che fino a non molto
tempo fa gli antropologi definivano “tradizionali”, dava per scontato
che le abilità tecniche venissero tramandate da una generazione
all’altra. Questo assunto è più significativo di quanto non sembri a
prima vista. Nelle società “basate su abilità specializzate” ma di tipo
tradizionale, le norme sociali avevano maggior valore delle doti
individuali. Lo sviluppo dei propri talenti dipendeva dal seguire le
regole stabilite dalle generazioni precedenti; in tale contesto, la
parola “genio”, nel senso di qualità personale, tanto importante per i
moderni, non aveva senso. Sul piano personale, il diventare abile in
un’arte o un mestiere richiedeva di essere obbediente alle norme
sociali. L’autore dell’inno a Efesto accettava la natura di questo
legame comunitario. Come succede in ogni cultura nei confronti di
valori profondamente sentiti, sembrava una cosa assiomatica che le
persone si identificassero con altri artigiani in quanto concittadini.
L’abilità tecnica le legava ai loro antenati tanto quanto ai loro
colleghi. Nella loro evoluzione graduale, le abilità tradizionali
sembrano dunque sottrarsi al principio arendtiano della “natalità”.
Se nell'età omerica l’artigiano era celebrato come persona
pubblica, nell’età classica la sua dignità si offuscò. Il lettore di
Aristofane trova un piccolo segnale di questo cambiamento nel
disprezzo con cui il commediografo tratta i vasai Kittos e Bacchios,
considerati stupidi e ridicoli a causa del lavoro che fanno.
20 Un
segnale più grave delle diminuite fortune dell’artigiano compare negli
scritti di Aristotele sulla natura del lavoro manuale. Si legge nella
Metafisica: “Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione
nelle singole arti siano più degni di onore e posseggano maggiore
conoscenza e siano più sapienti dei manovali, in quanto conoscono
le cause delle cose che vengon fatte…”.
21 Si noti che Aristotele
abbandona il vecchio termine demiourgos, per usare invece
cheirotechnes, lavoratore manuale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo