Lo sciame umano- Una storia naturale delle società – Mark W. Moffett
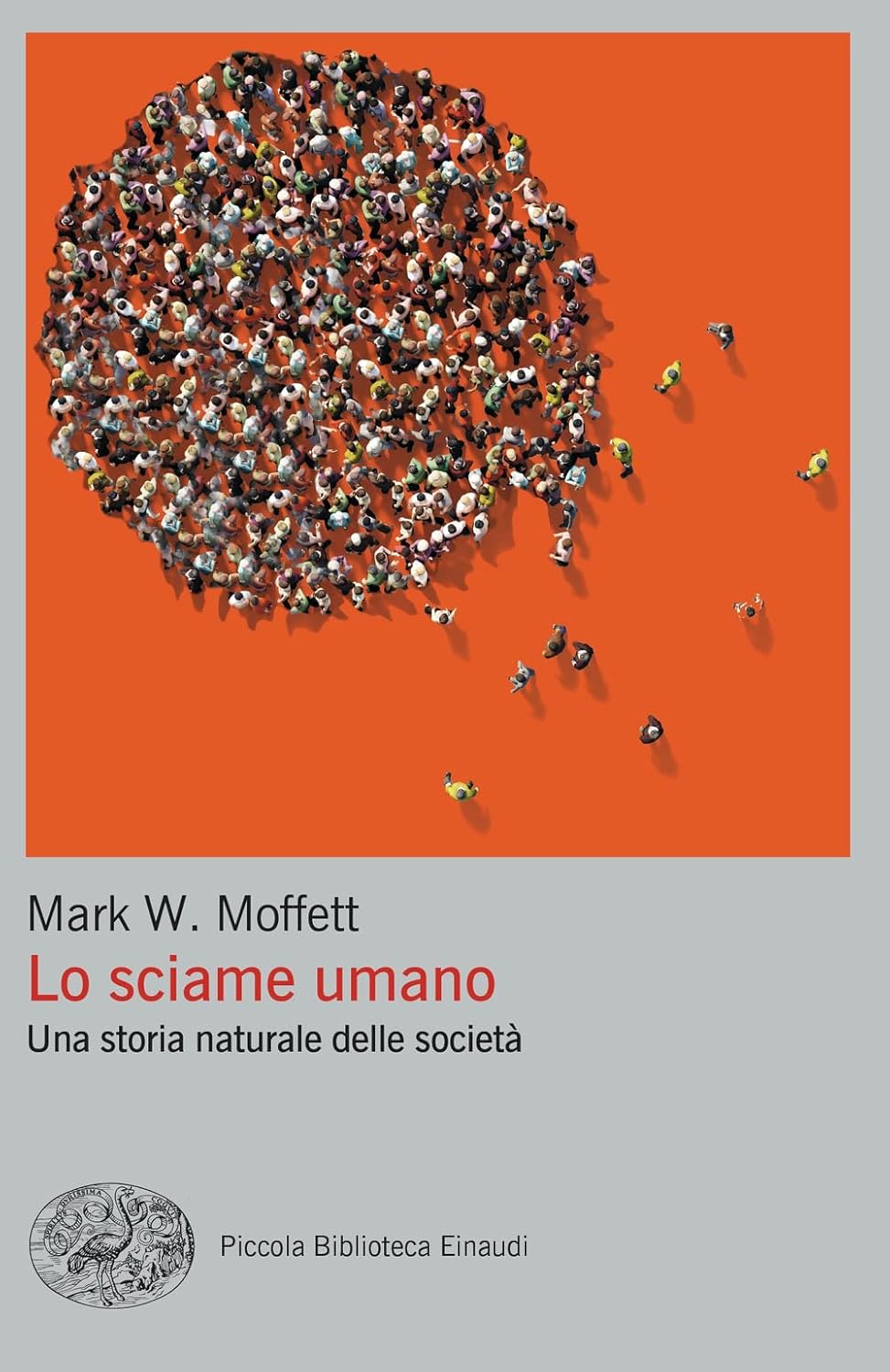
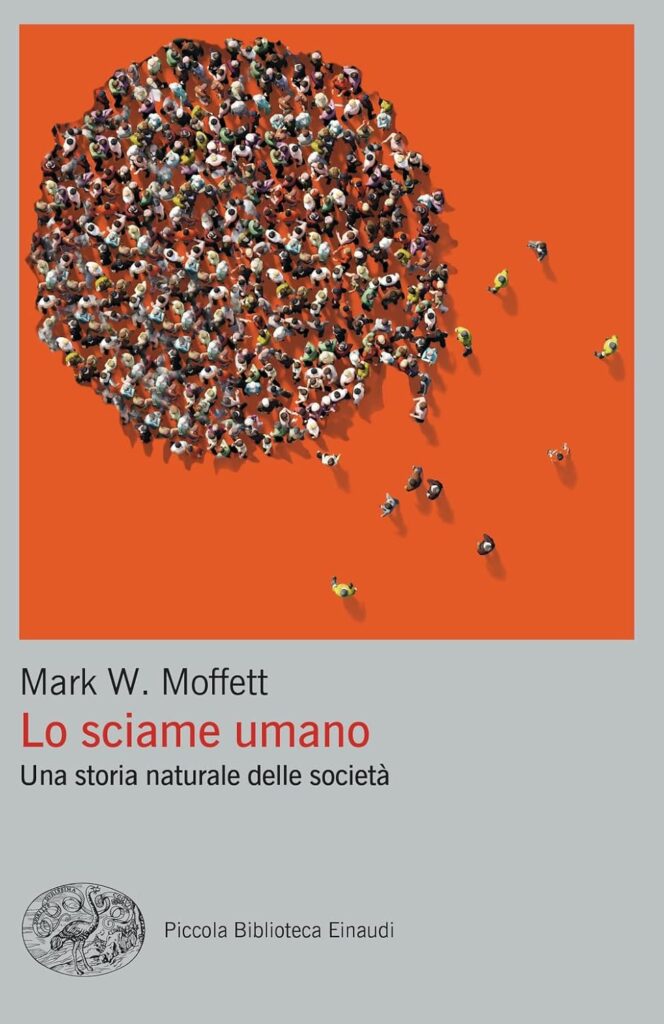
SINTESI DEL LIBRO:
Guardando dalla scalinata nell’atrio principale del Grand Central
Terminal di New York, sciami di persone roteano e vorticano sotto il
famoso orologio a quattro facce. Lo scalpitio staccato delle scarpe
sul marmo del Tennessee, e il clamore delle voci che monta e cala
come l’oceano in una conchiglia, si riverberano nella cavernosa
meraviglia acustica. Il soffitto a volta, che rappresenta 2500 stelle
congelate ciascuna sulla sua orbita prevista di una notte di ottobre a
New York, fa da perfetto contrappunto al tumulto dell’umanità
sottostante.
L’enorme numero e diversità di persone che si sfrecciano
accanto, o si raggruppano qua e là a chiacchierare, fanno di questa
scena un microcosmo della società umana nel suo complesso: una
società non come associazione volontaria di individui, ma come
gruppo persistente, di quelli che occupano un territorio e ispirano
patriottismo. Pensando a simili società ci vengono in mente gli Stati
Uniti, l’Antico Egitto, gli Aztechi, gli Indiani hopi: gruppi centrali
all’esistenza umana, pilastri della nostra storia collettiva.
Quali sono le caratteristiche di una popolazione che la rendono
una società? Che si pensi al Canada, all’antica dinastia Han, a una
tribú amazzonica o anche a un branco di leoni, una società è un
gruppo discreto di individui che ammontano a piú di una famiglia
singola (piú di uno o due genitori con una singola generazione di
prole indifesa), la cui identità condivisa li distingue da altri gruppi
simili e viene mantenuta ininterrottamente attraverso le generazioni.
Può anzi arrivare a produrre altre società simili, come quando gli
Stati Uniti si separarono dalla Gran Bretagna, o quando un branco di
leoni si scinde in due. Soprattutto, l’appartenenza a una società
cambia di rado e con difficoltà; si tratta di un gruppo chiuso, o
«delimitato». Anche se può variare l’intensità della passione che i
suoi componenti associano alla propria coscienza nazionale, molti la
pongono al di sopra di qualsiasi altra forma di appartenenza, escluso
il
legame con i nuclei familiari. Negli uomini questa importanza si
manifesta con l’impegno a lottare, anche a morire per il bene della
propria società, se le circostanze lo richiedono1.
Per alcuni studiosi di scienze sociali, le società sono
principalmente costrutti di convenienza politica, una forma di
organizzazione emersa negli ultimi secoli. Fra loro, lo scomparso
Benedict Anderson, storico e scienziato politico, concepiva le nazioni
come «comunità immaginate», poiché hanno popolazioni troppo
numerose per permettere ai membri di conoscersi di persona2. Io
concordo con la sua idea di base. Aiutando a distinguere noi, coloro
che ne fanno parte, da loro, gli estranei, un’immaginazione condivisa
è tutto ciò che ci occorre per creare società che siano entità
autentiche e ben ordinate. Anderson ha anche suggerito che queste
identità inventate siano prodotti artificiali della modernità e dei mass
media, ed è qui che lui e io divergiamo. Le fantasie condivise legano
i
popoli con una forza mentale non meno valida e reale della forza
fisica che lega gli atomi in molecole, trasformando entrambe in realtà
concrete. È cosí da sempre. Il concetto di comunità immaginate
infatti è valido non solo per le società moderne, ma per tutte le
società dei nostri antenati, probabilmente a partire dalle loro lontane
origini preumane. Quelle dei cacciatori-raccoglitori, unite da un
senso di identità comune, non dipendevano dallo stabilirsi di
relazioni univoche tra i membri, e nemmeno dal conoscersi di
persona, come vedremo; anche in altre specie animali le società
sono rappresentate saldamente nella mente di chi ne fa parte, e
quindi in questo senso altrettanto immaginate. Con ciò non intendo
togliere valore alle società umane: le società sono radicate nella
natura, e tuttavia si sono sviluppate in modi elaborati e significativi
che sono vistosamente caratteristici nella nostra specie (un tema
che approfondiremo).
Credo che questo punto di vista colga ciò che molti di noi hanno
in mente quando si parla di «società». Naturalmente ogni parola
deve ammettere una certa variabilità, e non esiste una società
animale che equivalga a una società umana, come non esistono due
società umane uguali. Lo dico per chi si preoccupa di stabilire un
limite: l’utilità di una definizione si mostra soprattutto da ciò che
impariamo nelle situazioni anomale, dove quella parola non funziona
a dovere. Se forzata a sufficienza, qualsiasi definizione va in pezzi,
escluse quelle matematiche e astratte. Mostrami un’auto, e io potrei
mostrarti un cumulo di scarti che un tempo era un’auto (e forse lo è
ancora nella mente di un meccanico). Mostra a qualcuno una stella,
e un astronomo indicherà una massa di pulviscolo convergente
surriscaldato. Il tratto distintivo di una buona definizione non è solo di
delimitare ordinatamente una serie di x, ma anche di collassare
quando le cose per la x si fanno concettualmente interessanti3. Di
conseguenza, esistono stati che forzano in modo istruttivo la mia
idea di società come gruppo discreto con un’identità condivisa.
L’Iran, ad esempio, conta parecchi curdi tra i suoi cittadini,
nonostante il governo abbia soppresso la loro identità di gruppo,
mentre quei curdi si considerano una nazione separata e
rivendicano il diritto al loro territorio. Situazioni in cui gruppi come i
curdi hanno identità in conflitto con la società fanno luce su fattori
che nel tempo possono servire a rafforzare ed espandere
ulteriormente le società stesse, oppure a lacerarle e a formarne di
nuove4. I conflitti sull’identità possono sorgere anche in altre società
animali.
Molti esperti nel mio campo della biologia, e anche antropologi,
offrono una diversa definizione di società, descrivendola non tanto in
termini d’identità, quanto piuttosto come gruppo organizzato in forma
cooperativa5. Anche se i sociologi riconoscono come la
collaborazione sia vitale per il successo delle società, nel loro campo
è ormai diventato raro equipararle a sistemi di cooperazione6.
Tuttavia è facile considerarle in questi termini, e per ovvie ragioni:
noi umani ci siamo evoluti in modo da rendere la cooperazione
essenziale per la nostra sopravvivenza. In questo superiamo le altre
specie, avendo affinato la capacità di comunicare le nostre intenzioni
e di dedurre quelle degli altri per raggiungere obiettivi condivisi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo