Lo scialo – Vasco Pratolini
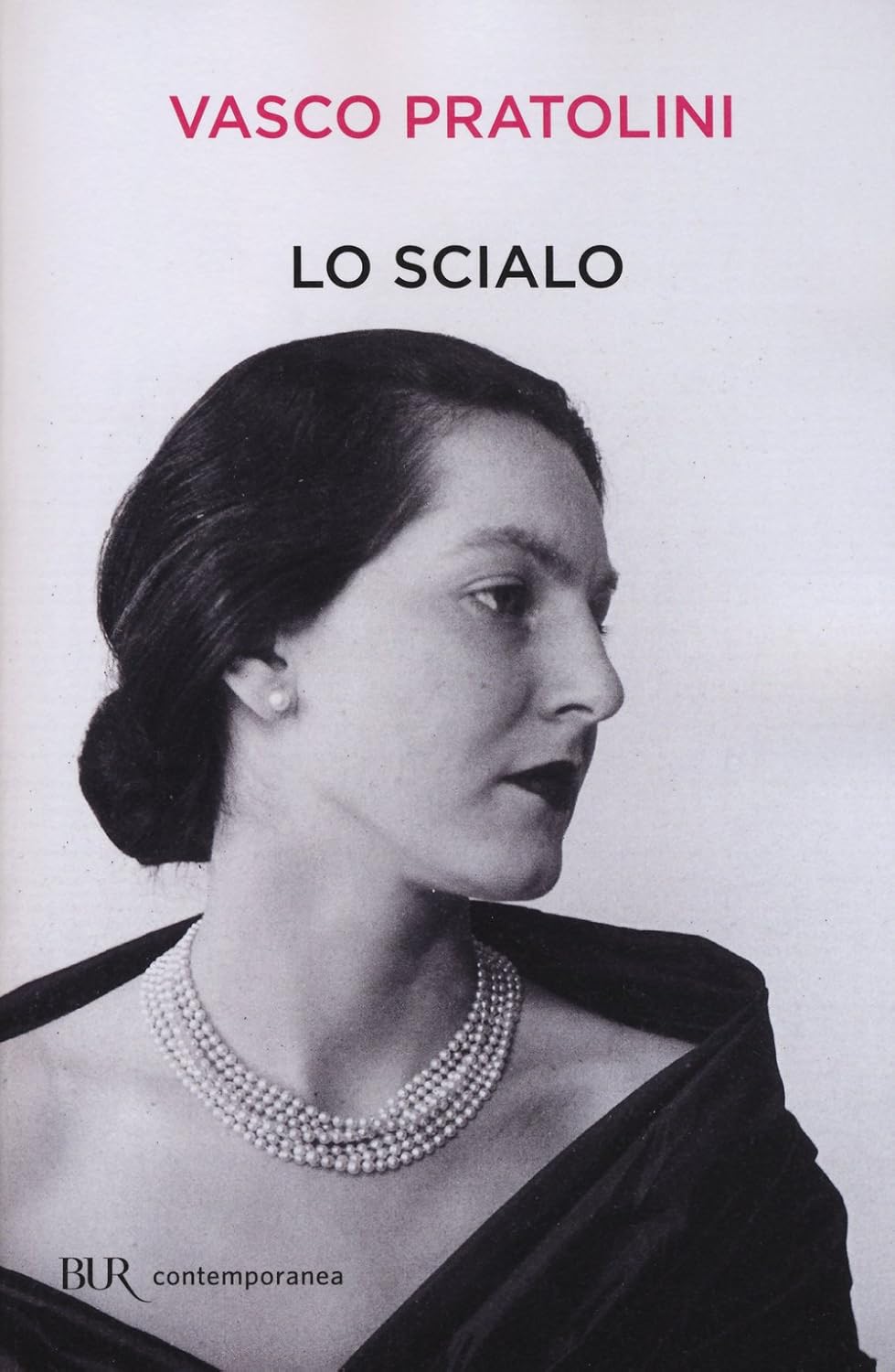
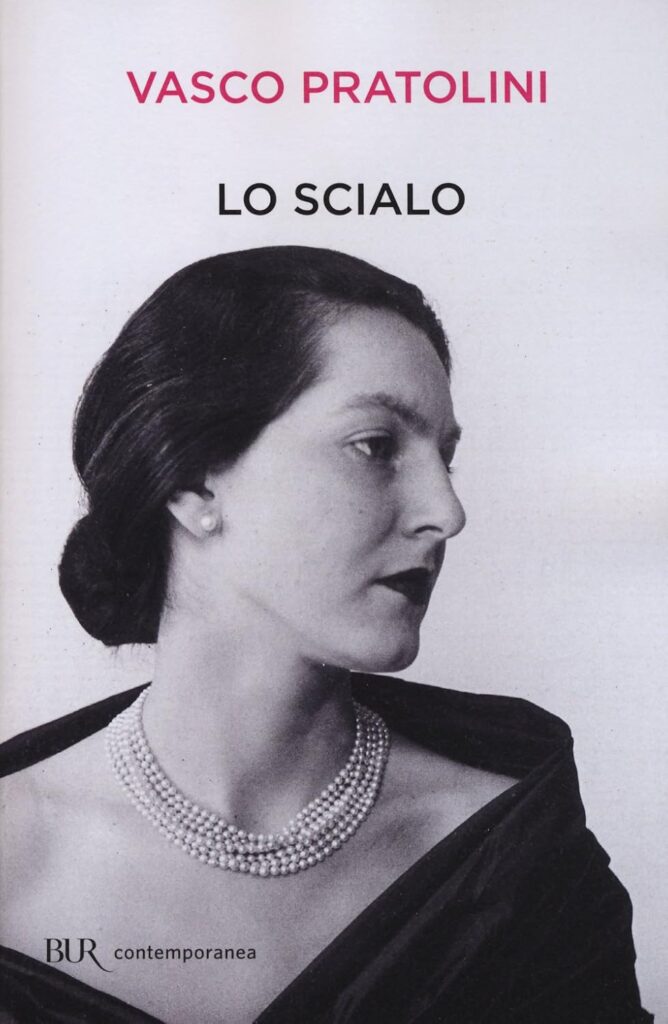
SINTESI DEL LIBRO:
Nella e Giovanni si conobbero la sera di Berlingaccio sulla pista da
ballo delle Due Strade. Era un ambiente popolare, mezzo operaio
mezzo contadino; c’era un’orchestra di mandolini e un chitarrista che
di tanto in tanto esprimeva ad alta voce l’opinione generale: Chi si
vuole bene, si bacia. Entrambi era la prima volta che ci andavano:
Nella in compagnia di zia Concetta, e per un ripicco, un capriccio di
cui si era già scordata; Giovanni perché sperava d’incontrare una
modista con la quale aveva amoreggiato e non riusciva a
dimenticarla. Quando Nella entrò, si ballava il trescone: un cozzar
d’anche e un frullar di mani, un gridìo. Le venne incontro un giovane
basso come un ragazzo, dalla camicia senza colletto, spavaldo e
quasi con indifferenza. Zia Concetta lo licenziò. «Siamo venute per
andar via.» Nella, si tolse e rimise lo spillone del cappello dietro la
nuca. Ora era un valzer, si fece avanti quest’altro giovane
sconosciuto, distinto e sulla trentina. Indossava un vestito grigio, il
solino rivoltato alle punte, la cravatta fantasia; aveva i capelli col giro
sulla fronte, i baffi arricciolati. Abbassò la testa e chiese il consenso
a zia Concetta; Nella gli aveva steso le braccia. Ballava un po’
caricato, tutto rigido e a distanza, ma il suo viso faceva simpatia:
aveva un neo sullo zigomo come una damina, magari era una
verruca, quei baffi lo assomigliavano a tanti come lui, eppure in lui
c’era qualcosa di diverso e di eccezionale. Lo sguardo, negli occhi
chiari, era di una persona seria e sempre allegra. Si presentò,
ballando; e poi: «Ho l’onore?».
Lei sorrise. «Provi a dire.»
«È una padroncina di qui, intorno alla Certosa.»
«Oh, nodavvero.»
«Io sono di città» lui disse.
«Anch’io.»
E insieme dissero le stesse parole: «Mi ci trovo per
combinazione».
Sorrisero insieme.
«Io» egli disse «abito in Ognissanti, sul Prato.»
«Io in Santissimi Apostoli.»
«È tutta strada.»
La pippolese accelerò il tempo, coi mandolini; essi volteggiarono
guardandosi negli occhi. Formavano la coppia più elegante, al centro
dell’arena dove non sarebbero mai più tornati.
Un anno dopo, nemmeno, dieci mesi appena, si sposavano.
Nella, apparteneva a una famiglia di artigiani: quegli orefici e
argentieri che a Firenze hanno una tradizione e laboratorio al di qua
e al di là di Ponte Vecchio. Ancora fanciulla, era stata promessa ad
Antonio Moradei, suo biscugino e suo coetaneo, il cui padre gestiva
un forno nel Quartiere di Santo Spirito; ma avvicinandosi la maggiore
età e la ragazza rivelatasi spratica e fantasiosa, priva di ogni
disposizione per stare dietro il banco, i parenti Moradei meditavano
di ritirare la parola. Nella, li aveva preceduti, una domenica che al
solito, le due famiglie riunite, non si voltava carta senza ricamarci
attorno delle allusioni.
«Io diventare la moglie di un fornaio?»
Fu una risata che mandò all’aria il gioco e anticipò i commiati.
Malgrado la parentela, avevano smesso di frequentarsi. Tonino ebbe
un tracollo nervoso. «Povero Tonino» lei commentò. «Non ha idea
come me lo figuro, lo Sposo.» Giorno per giorno, ella abbandonava
un sogno e ne incominciava uno nuovo. Le sue fantasie avevano
esili piattaforme da cui spiccare il volo: erano le esaltazioni di una
ragazza accontentata in tutto ma “di onesti pensieri”. La proteggeva
l’ordine familiare e la nessuna esperienza, il “candore verginale” che
zia Concetta, ormai sulle soglie della vecchiezza, divideva con lei.
Durante la scuola, “le complementari, poi c’era stata la passione per
il
piano”, non aveva stretto sodalizi; e chiuso com’era il giro delle
conoscenze, più che i pretendenti erano mancate le occasioni. Colui
che bussasse ai vetri della finestra per rapirla sopra un pallone. Era
dunque Giovanni, l’eroe ch’essa aspettava?
«Un mangiapane del Governo, un bifolco rivestito. Spiégati,
Nellina.»
«Non si spiega, zia Concetta, è l’amore.»
Anche disse: «Ho ventun’anni, sono figlia unica e ho una dote,
sono nell’età della ragione».
Ma il suo “amore” essendo povero, all’inizio della carriera, la dote
se ne era andata nell’arredamento della casa e nel viaggio di nozze,
“una pazzia”, che aveva portato gli sposi a Livorno, la prima notte,
poi a Parigi.
Giovanni, lui era di origine schiettamente minuta. Solo al mondo,
generazioni di ortolani di spaccapietre di carriolanti, stavano alle sue
spalle. Veniva da Scandicci, una borgata del contado, dove scorre
l’Ema e c’è un mulino. Egli lasciò il paese, l’anno del terremoto, il
fagotto dei panni appeso al bastone, percorrendo i sette chilometri
per arrivare in città, con l’animo dell’emigrante che attraversa i mari.
Dall’uno all’altro cantiere, assistendolo la fortuna, di lì a poco
lavorava come manovale alle dipendenze delle Ferrovie. Aveva
ancora i calli alle mani, l’ambizione che lo pungolava, quando si
iscrisse ai corsi serali dell’Università Popolare: ottenuto il diploma,
era passato nei ruoli degli impiegati. La sua marcia alla conquista del
mondo si era rapidamente conclusa. Ora, deposto il badile per
impugnare la penna, raccoglieva i frutti della sua mutata condizione.
E Nella, con la sua bellezza originale ma non inquietante: gli occhi
celesti,
i
capelli
neri,
il
corpo straordinariamente perfetto:
rappresentava quanto di più nobile e meritato il destino potesse
riserbargli. Sorridere e compiacersi delle sue improvvise malinconie
e dei suoi subitanei entusiasmi, gli sembrò naturale. Accanto ad
essa, fine di modi, bene allevata, anche la sua educazione si
completava. Unica contrarietà, l’avversione di zia Concetta, intristita
all’ombra della propria sorella e del cognato, crescendosi lei Nella
più della madre.
«È un vanesio, un sovversivo, un ateo, e la farà tribolare.» Ma zia
Concetta, quest’ape operaia, chi l’ascoltava?
2
La felicità domestica durò i tredici giorni della luna di miele, e per sei
anni ancora. Se ne potevano trascrivere le date, presto Nella vi
avrebbe indugiato.
Il giorno delle nozze, quel 12 di giugno del Quattordici, un sabato
di gran sole, coi landò, i fiori, la Chiesa dei Santissimi Apostoli
piccola come una cappella e tutta per loro. Zia Concetta, rimasta in
casa per non vederla “andare al macello”, si era fatta venire il
singhiozzo, a furia d’ingoiare commozione. E la notte di Livorno:
arrivarono ch’era già buio, non trovarono una carrozza, li divertì
scoprire che invece di un uomo era una donna ad accendere i
lampioni agli angoli delle strade. Nella, si ricordava tutta un fremito e
remissiva. Quindi il corpo di Giovanni che l’opprimeva, fu subito un
peso doloroso e dolcissimo da sopportare. L’albergo dava sulla
Darsena, di fronte c’erano i Quattro Mori. Al mattino, un alterco, si
udivano bestemmie più che parole, la destò. Giovanni dormiva
quieto, supino. Nel sonno, ella aveva abbandonato la mano sopra il
suo fianco. Dové proibirsi, quella volta e per sempre, il desiderio di
toccarlo. Questa tentazione, in cui Nella vedeva qualcosa
d’immondo, le procurò uno spasimo anche più lancinante. Parigi,
infine, la sera che uscivano da Notre Dame e incrociarono una
colonna di soldati. «Mais non!» Dicevano attorno, sul sagrato. E lo
strillone dei giornali, la venditrice di fiori.
«Nom de Dieu.»
«Les boches.»
Ella teneva il braccio nel braccio di Giovanni. Aveva l’ampio
cappello velato, l’abito lungo, lilla, l’ombrellino da sole aperto e quasi
appoggiato sulla spalla, come nella fotografia. Oltrepassato il Ponte,
lontano dalla Cattedrale, i soldati continuavano a sfilare e la gente gli
faceva ala. Giovanni, battendo i piedi come per segnare il passo,
intonò la Marsigliese. Ma la sua voce non trovò eco, se non in lei e
nella sua risata. Si udirono delle parole incomprensibili, certo di
gergo, e non di approvazione. Essi staccarono la corsa, tenendosi
per mano. La sottana la impacciava, le cadde l’ombrellino.
Conservava di quei giorni un ricordo minuzioso e inesauribile, come
di un’intera esistenza che giunta al suo naturale declino, consentisse
di essere rievocata, pacatamente ormai, e con rapidi, abbaglianti
soprassalti della nostalgia. Tale era la sua natura, la sua sensibilità
sempre disposta a tramutarsi in emozione; una circostanza, la più
labile, piuttosto degli episodi altrimenti capaci di commuovere ed
esaltare, poteva folgorarla e lasciare un segno nella sua memoria.
Così, gli anni che seguirono, sembrarono aver contato, per lei, meno
di quei brevi giorni della luna di miele, durante i quali si era operato,
dentro di lei, un totale, amoroso perché volontario, elettivo trapasso
da un’antica ad una nuova dimensione della vita. L’eccezionalità
medesima degli eventi, il loro incalzare e compenetrarsi, l’avevano
trovata sì, forte nell’affrontarli e nell’averne ragione, ma come per
immobilità, per stordimento. Malgrado il distacco a cui la guerra li
costrinse, Nella si era sentita protetta “dall’armonia dei sentimenti”
che la legavano a Giovanni; poi, dalla presenza del figlio, nel quale
riconosceva Giovanni, e vi si riconosceva. Questo le aveva
permesso di vivere, “come in una giostra”, assordata dal pianino e
maggiormente da quei silenzi tragici, improvvisi, di quando finisce la
musica e ne incomincia un’altra. “Bisogna scendere per capire dove
siamo.”
Sei anni sono lunghi, eppure, dopo, sembra averli vissuti in un
baleno. Come la notte che si sta alzati a vegliare un moribondo. (La
notte che Nella avrebbe trascorso al capezzale della madre.) È
eterna la sua agonia; non ci si sente mai tanto vicini alla Verità, e
nello stesso tempo, non se ne ha mai tanto terrore, quanto in
codeste ore. D’un tratto, in realtà ne abbiamo accelerato noi il corso,
con la nostra angosciosa aspettazione, la notte si disfa dentro la
prima luce. È il momento che sceglie la Morte per le sue rapine,
l’istante in cui il Bene e il Male ci appaiono nettamente divisi; e ci
troviamo sgomenti, incapaci di farcene una ragione. Un baleno, il
medesimo che scosse l’universo quando Cristo spirò, e già la
menzogna, tutt’uno con la luce, è tornata a proteggerci. Allo
spavento succede la disperazione. Di essa abbiamo bisogno per
sopravvivere. La pace è dei morti, di questa spoglia che
accarezziamo, su cui versiamo le nostre lacrime, che scuotiamo
perché resti complice dei nostri egoismi come delle gioie che
insieme ci inventammo. Poi, il sole è a mezzo il cielo, e tutto
appartiene al passato. Ci consoliamo nella dolcezza del ricordo. Ma
quanto più è stato violento il trauma, la paura, e più vogliamo bene a
noi stessi, più riusciremo a dimenticare. Mettiamo una parete di
marmo davanti alla nostra anima di vetro. Ci proibiamo di pensare,
che è come consegnarsi alla morte restando vivi. Ella era credente,
senza essere bigotta; e spontanea, non ipocrita, non calcolata, era
questa sua disposizione a superare le avversità nel segno della
Grazia. Del resto, fino da quel giorno, il suo destino era in ogni
senso legato al destino di Giovanni. “È l’amore”, si ripeteva. O non
lei stessa, che a furia di mitizzare lo Sposo, nell’attesa di vederselo
comparire davanti, bello, regale, aveva dato corpo alla propria
impazienza? L’amore erano i suoi occhi chiari ed il suo sguardo
malizioso, la sua figura prestante che la sovrastava di un palmo, i
suoi capelli, naturalmente ondulati “come quelli di una donna”.
L’amore furono i suoi baffi alla moschettiera, la sua cura nel vestire,
la sua amabile perché misurata spregiudicatezza quando parlava.
Fu poi amore, ritrovare tra le sue braccia l’appagamento dei sensi
così come, ignorandolo, ella se lo attendeva. La naturalezza
diciamo, la gagliardia, a cui subito Giovanni l’aveva abituata: ciò che
di più sano, e ottuso, autenticamente li univa. E la sicurezza di sé,
del proprio avvenire. “Non sono venuto al mondo per morire
pensionato” egli diceva, per cui anche la superiorità intellettuale, o
soltanto la diversa e maggiore educazione che Nella si scopriva, di
volta in volta le strappava un sorriso, come per qualcosa ch’essa
potesse teneramente offrirgli, a sua insaputa.
Di ritorno dal viaggio di nozze, nella loro casa in via da
Verrazzano: le finestre della camera da pranzo davano sul giardino
di Palazzo Pepi, c’era una magnolia immensa che odorava le stanze
e che lo recintava: Giovanni aveva ordinato una targa per la porta
sulle scale.
«Quel Corsini!» ella esclamò. “Troppo grande, pesante,
stampatello” stava per dire. Non gli avrebbe mai detto: “un po’
volgare”.
«È il tuo nome, ci dovrai fare l’abitudine.»
Lei tacque; insieme avvitarono la targa e stettero a rimirarla.
«Casa nostra» egli disse. «Casa mia.»
E quando Nella gli confidò di trovarsi incinta: «Giusto, preciso»
egli disse. «Dev’essere stato la notte di Livorno.»
3
Fu una gravidanza difficile, con le nausee, il mal di reni; sempre tra
letto e poltrona, senza la possibilità nemmeno adesso di fare delle
conoscenze. Neanche coi vicini, che non c’erano. La strada era
silenziosa, la casa piena di luce, ma in uno stabile di tre piani,
d’angolo con via del Fico: ne era padrona un’amica di famiglia, la
signora Chiti, era tutta la sua proprietà, l’aveva ereditata
cinquant’anni prima; gli faceva pagare “un miscèa”. Da una parte, il
giardino Pepi; dall’altra, via da Verrazzano e il muro dirimpetto che
proteggeva ugualmente un giardino. Abitavano il secondo piano;
sopra, come una grande soffitta, c’era il deposito del signor Chiti che
gestiva, non un forno come i cugini Moradei, ma una “mescita”, e in
quella soffitta teneva le damigiane vuote, i fiaschi, le sue “carabattole
di vinaio”; al piano sottostante, i Fantechi: due vecchi e una figlia più
vecchia di loro, sempre tappati. Un giorno avevano fermato Giovanni
per dirgli che dopo le sei di sera non è più permesso andare e
venire! Come su un’isola, quando era sola; e come in un’ariosa
fortezza di una cucina e tre stanze, la più piccola delle quali non
ancora arredata: aspettavano di prepararla per il bambino. Piazza
Santa Croce, con la sua animazione, lì a pochi passi che se ne
intravedeva uno spicchio e il seguito delle panchine, sembrava a
volte di sognarla con gli occhi; così veniva, dal capo opposto, come
un lontanissimo tuono, il rumore dei tram su via Ghibellina. Sortire
non poteva; né ricevere. Chi poi, e nelle sue condizioni? Era appena
riuscita ad invitare Ernesto Bugatti che in quel tempo era il migliore
amico di Giovanni, forse il solo. Troppo cerimonioso e nello stesso
tempo sfuggente: aveva un braccio più corto, portava le lenti celesti.
Non le piaceva, ma teneva per sé la propria impressione,
rimproverandosene; anche se Giovanni non mancava occasione per
esprimersi su zia Concetta, invece.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo