L’importanza di ogni parola – Toni Morrison
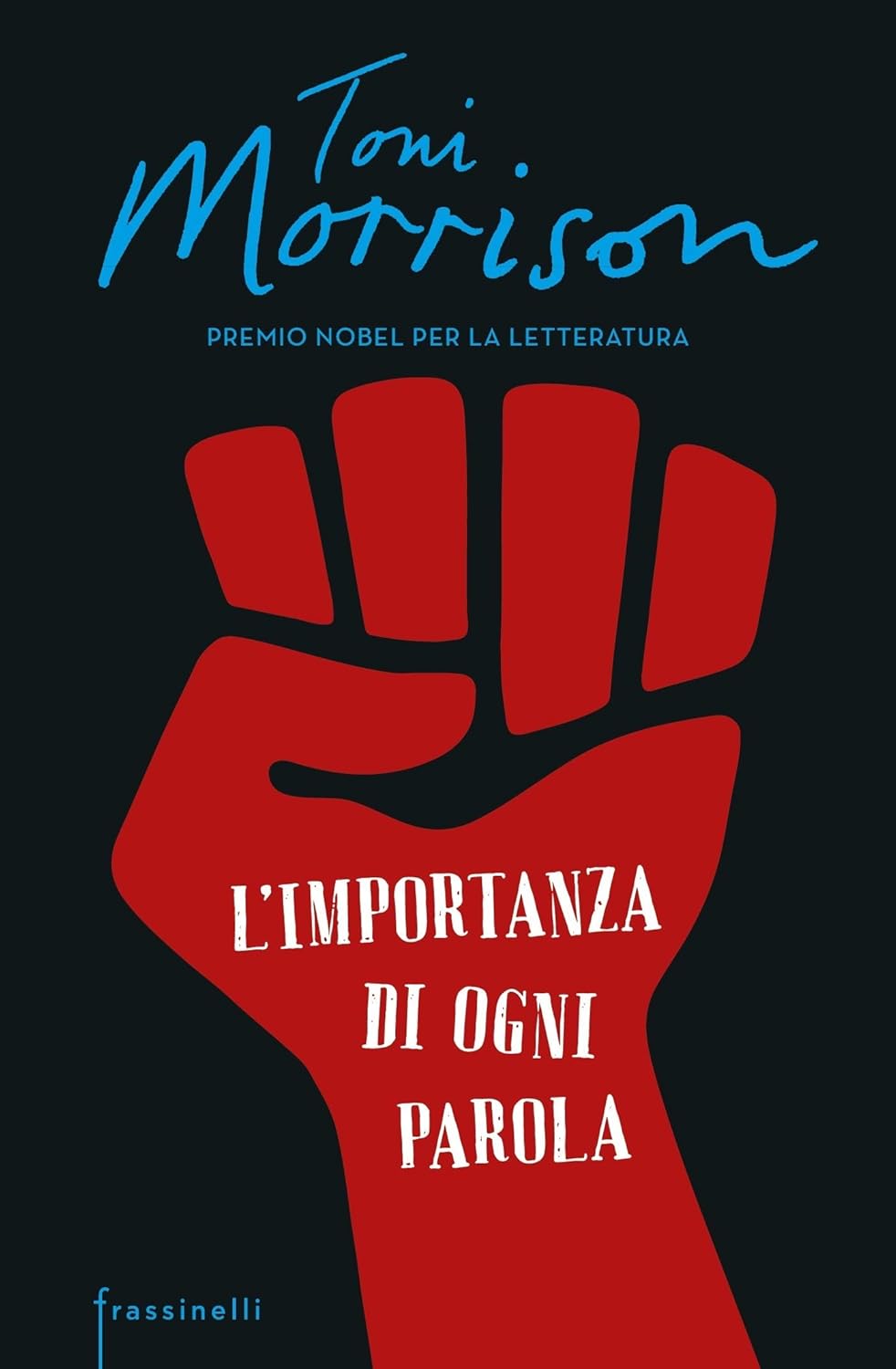
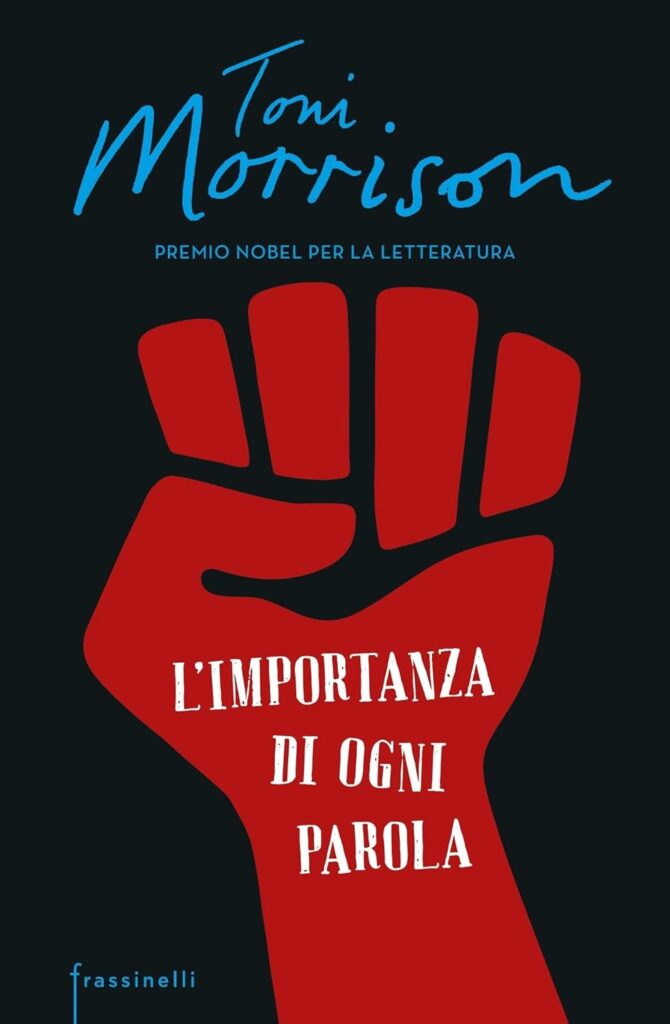
SINTESI DEL LIBRO:
Alcuni hanno le parole di Dio; altri hanno canti di consolazione per i
dolenti. Se riuscissi a trovare il coraggio, vorrei parlare dire amente
ai morti – i morti di se embre. Quei figli di progenitori nati in ogni
continente del mondo: Asia, Europa, Africa, le Americhe; nati da
progenitori che indossavano kilt, obi, sari, gele, larghi cappelli di
paglia, yarmulke, pelle di capra, zoccoli di legno, piume e veli a
coprire i capelli. Ma non direi una parola senza avere messo da parte
tu o ciò che so o credo sulle nazioni, la guerra, i leader, i governati e
gli ingovernabili; tu o ciò che sospe o sulle armature e le viscere.
Prima mi rinfrescherei la lingua, abbandonerei le frasi plasmate per
conoscere il male – sfrenate o studiate; esplosive o quietamente
sinistre; nate dalla fame oppure da un appetito saziato; dalla
vende a o dal semplice impulso a opporre resistenza prima di
cadere. Espungerei dal mio linguaggio le iperboli, così pronte ad
analizzare i livelli di malvagità; a ordinarli, calcolando la posizione
di ciascuno rispe o agli altri.
Parlare a chi è straziato e a chi è morto è troppo difficile per una
bocca piena di sangue. Un a o troppo sacro per pensieri impuri.
Poiché i morti sono liberi, assoluti; non si può sedurli con soluzioni
rapide.
Per parlare a voi, i morti di se embre, non devo rivendicare una
falsa intimità o invocare un cuore in tumulto placato appena in
tempo per le telecamere. Devo mantenermi salda ed essere chiara,
pur nella consapevolezza che non ho niente da dire – nessuna parola
che sia più forte dell’acciaio che vi ha stre i in sé; nessuna scri ura
più antica o più elegante degli atomi arcaici in cui vi siete tramutati.
E non ho nemmeno niente da dare – se non questo gesto, questo
f
ilo teso tra la vostra umanità e la mia: voglio stringervi tra le braccia e,
g
g
come la vostra anima è esplosa dal suo guscio di carne,
comprendere, come voi avete fa o, l’intelligenza dell’eternità: il
dono di una liberazione assoluta che squarcia la cupezza dei suoi
rintocchi.
a. Titolo originale: The Dead of September 11, commemorazione presso l’Università di
Princeton, Princeton, 13 se embre 2001.
La patria dello straniero a
Escludendo il culmine del commercio di schiavi nel diciannovesimo
secolo, il movimento di masse umane nella seconda metà del
ventesimo secolo e all’inizio del ventunesimo è imponente come non
mai. È un movimento di lavoratori, intelle uali, rifugiati, eserciti che
a raversano oceani e continenti, migranti che superano le dogane o
percorrono vie nascoste, parlando molteplici linguaggi: quelli del
commercio, dell’intervento politico, della persecuzione, dell’esilio,
della violenza, della povertà. È fuor di dubbio che la redistribuzione
(volontaria e involontaria) degli esseri umani nel globo sia in cima ai
pensieri degli Stati, dei consigli di amministrazione, delle persone
comuni nei quartieri e nelle strade. Le manovre politiche per
controllare questo movimento non si limitano a sorvegliare i
diseredati. Sebbene buona parte di questo esodo si possa descrivere
come il viaggio dei colonizzati verso la sede dei colonizzatori
(schiavi, per così dire, che lasciano la piantagione per la dimora dei
padroni), e sebbene un’altra parte sia costituita dalla fuga dei
rifugiati di guerra, il trasferimento e l’insediamento della classe
dirigenziale e diplomatica negli avamposti della globalizzazione,
oltre che l’istituzione di basi militari e lo spiegamento di forze
fresche, spiccano tra gli sforzi legislativi per controllare il flusso
costante di persone.
Lo spe acolo del movimento delle masse a ira inevitabilmente
l’a enzione sui confini, i luoghi porosi, i punti vulnerabili in cui il
conce o di patria è percepito come minacciato dagli stranieri. A mio
parere, l’allarme che aleggia ai confini, alle porte, è amplificato
principalmente da due fa ori: 1) la minaccia e insieme la promessa
del globalismo, 2) un rapporto difficile con la nostra stessa estraneità,
il rapido disgregarsi del nostro senso di appartenenza.
p
g g
pp
Perme etemi di cominciare dalla globalizzazione. Nel suo
significato a uale, non è una riedizione dello schema «Rule,
Britannia» dell’Oocento – benché le sollevazioni postcoloniali
rifle ano e ricordino il dominio che, all’epoca, una nazione aveva su
gran parte delle altre. Il termine non contiene in sé lo slogan:
«Lavoratori
di
tu o
il
mondo, unitevi» del vecchio
internazionalismo, anche se è stata proprio questa parola,
«internazionalismo», che il presidente della più grande
confederazione sindacale degli Stati Uniti (l’AFL-CIO) ha usato a un
importante convegno. E il globalismo non somiglia nemmeno alla
tensione postbellica verso «un unico mondo», la retorica che animò e
afflisse gli anni Cinquanta e ge ò le basi delle Nazioni Unite. Non è
neppure l’«universalismo» degli anni Sessanta e Se anta – sia come
invocazione alla pace mondiale sia come insistenza sull’egemonia
culturale. «Impero», «internazionalismo», «un unico mondo»,
«universale»: più che denominazioni di tendenze storiche, paiono
aneliti. Aneliti a costringere la terra a una qualche parvenza di unità
e a una qualche misura di controllo, a concepire il destino umano del
pianeta come determinato dall’ideologia di una particolare
costellazione di nazioni. Il globalismo ha gli stessi desideri e aneliti
dei suoi predecessori. Anch’esso si concepisce come storicamente
progressista, miglioratore, predestinato, unificante, utopistico.
Secondo una definizione rigorosa, si riferisce all’istantanea
circolazione di capitali e alla rapida distribuzione di prodo i e
informazioni all’interno di un ambiente politicamente neutrale,
plasmato secondo le esigenze delle aziende multinazionali. Le sue
connotazioni più ampie, tu avia, sono meno innocenti, poiché
comprendono non solo la demonizzazione degli Stati posti so o
embargo o la disponibilità a minimizzare i crimini dei signori della
guerra pur di stringere accordi con loro, ma anche il collasso degli
Stati nazione so o il peso di economia, capitali e forza lavoro
transnazionali; la preminenza della cultura e dell’economia
occidentali; l’americanizzazione dei Paesi sviluppati e in via di
sviluppo tramite la penetrazione della cultura americana nelle altre,
nonché il marketing delle culture del Terzo mondo in Occidente
nella moda, nelle ambientazioni cinematografiche e nella cucina.
g
Salutata con lo stesso entusiasmo del destino manifesto,
dell’internazionalismo e via dicendo, la globalizzazione ha
conquistato una certa maestà nella nostra immaginazione. Benché si
affermi che promuova la libertà, essa esercita in realtà un potere
assoluto, regale, poiché può concedere molto. In termini di portata
(a raverso le frontiere); in termini di massa (le popolazioni toccate e
coinvolte) e in termini di ricchezza (campi illimitati da cui estrarre
risorse e servizi da offrire). Eppure, se alcuni la adorano
a ribuendole un ruolo quasi messianico, altri la denigrano
considerandola un male che rischia di generare una pericolosa
distopia. La sua noncuranza dei confini, delle infrastru ure
nazionali, delle burocrazie locali, dei controllori di Internet, di
tariffe, leggi e lingue; la sua indifferenza per i margini e le persone
marginali che li abitano; le sue formidabili, fagocitanti proprietà che
accelerano la cancellazione e l’appia imento delle differenze e delle
specificità a fini di marketing. L’avversione per la diversità.
Paventiamo l’indistinguibilità, l’eliminazione di tu e le lingue e
culture minoritarie nella sua scia. Rifle iamo con orrore su come
potrebbero irrevocabilmente alterarsi e indebolirsi le lingue e culture
più importanti so o la sua spinta. Anche se queste temute
conseguenze non si materializzassero del tu o, non di meno
smentiscono le promesse del globalismo di una vita migliore,
agitando fosche minacce di una morte culturale prematura.
Altri pericoli che pone il globalismo sono la distorsione del
pubblico e la distruzione del privato. Apprendiamo ciò che è
pubblico principalmente, ma non esclusivamente, tramite i media. Ci
viene chiesto di cedere molto di ciò che un tempo era privato per
consentire la raccolta di dati determinata da esigenze governative,
politiche, di mercato e ora di sicurezza. Parte dell’ansia riguardo al
confine poroso tra pubblico e privato deriva certamente da
un’applicazione
spregiudicata
dei
termini.
Pensiamo alla
privatizzazione delle prigioni, cioè il controllo privato aziendale di
una stru ura pubblica. Pensiamo alla privatizzazione delle scuole
pubbliche. Pensiamo anche alla vita privata – che si può rinunciare
liberamente a rivendicare nei talk show, o di cui si può discutere in
tribunale nel caso delle celebrità, delle figure «pubbliche» e delle
g
p
cause sul diri o alla riservatezza. Pensiamo agli spazi privati (atri,
giardini eccetera) aperti al pubblico. E agli spazi pubblici (parchi,
aree gioco e spiagge in alcuni quartieri) riservati all’uso privato.
Pensiamo all’effe o-specchio del «rimando» al pubblico nella nostra
vita intima, privata. L’interno delle nostre case somiglia alla merce in
esposizione in un negozio (con tanto di scaffali su scaffali di
«collezioni») e la merce in esposizione nei negozi è disposta come
all’interno di una casa; si dice che il comportamento dei giovani
riecheggi ciò che offre lo schermo; si dice che lo schermo riecheggi e
rappresenti gli interessi e i comportamenti giovanili – non che li crei.
Poiché gli spazi in cui viviamo la nostra vita civile e quella privata
sono diventati così indistinguibili tra dentro e fuori, tra interni ed
esterni, i due ambiti si sono confusi in un’indeterminatezza
onnipresente, che me e in crisi il nostro conce o di «casa».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo