Lettori selvaggi – Dai misteriosi artisti della Preistoria a Saffo a Beethoven a Borges la vita vera è altrove – Giuseppe Montesano
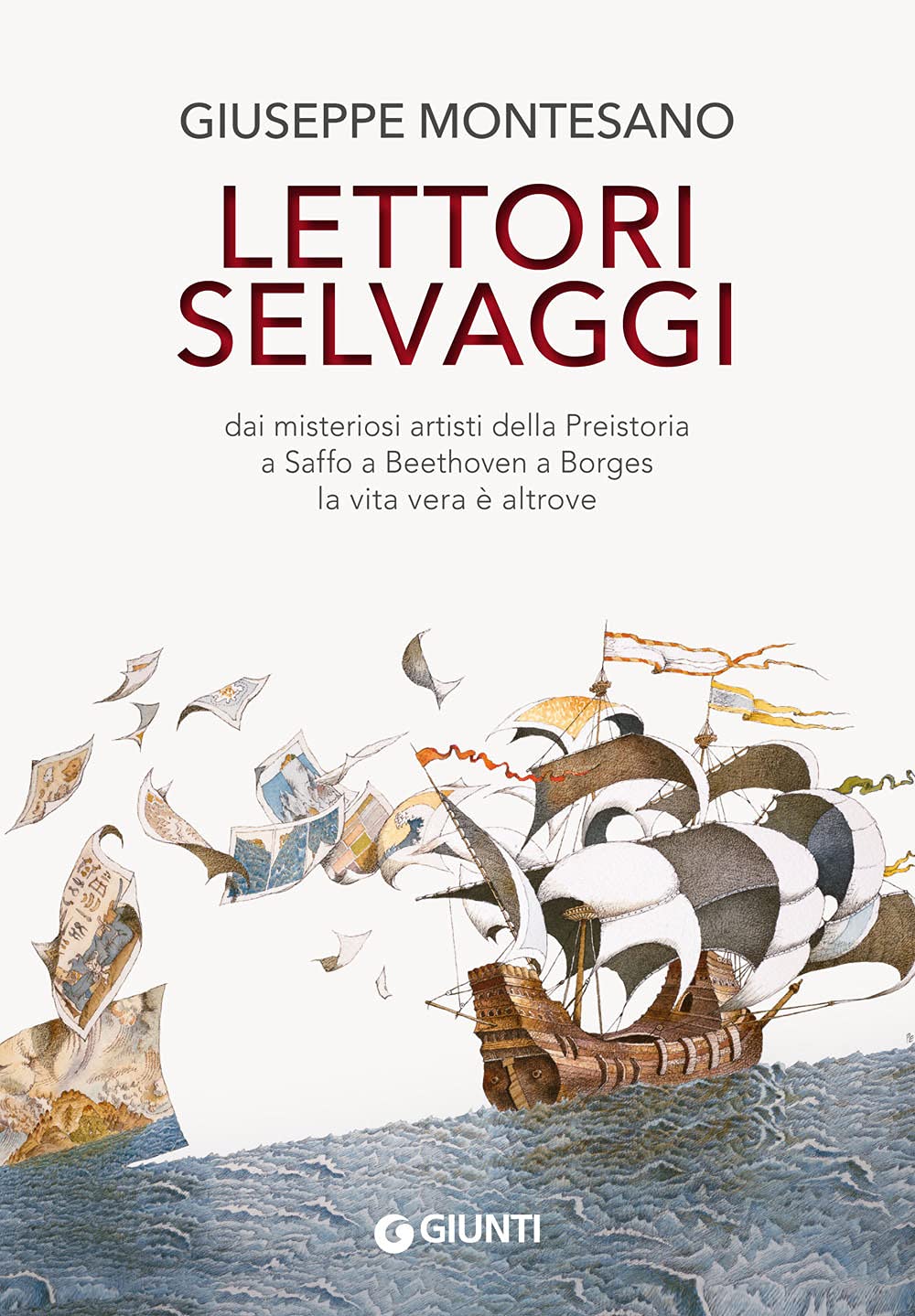
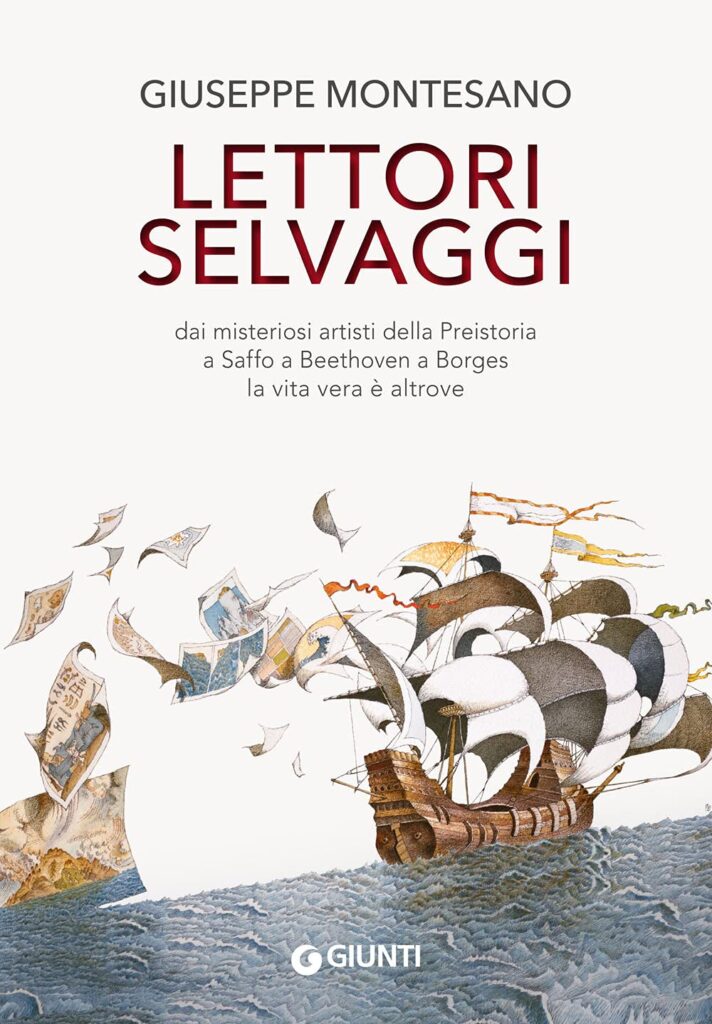
SINTESI DEL LIBRO:
. e i misteriosi artisti della Preistoria, che non potevano perder
tempo a cincischiare, e dovevano afferrare nel buio la forma quando
essa è sull’orlo di svanire: quegli artisti immensi che prima del
20.000 avanti Cristo dipinsero i Cavalli «pointillisti» a Pech-Merle e
crearono la Venere di Lespugue e la Venere di Brassempouy; che
verso il 15.000 dettero forma alla pittura e alle incisioni nelle caverne
di Lascaux e al Bisonte di Altamira, e in Australia dipinsero le
cosiddette Pitture Bradshaw; che nel 13.500 dettero vita al geniale
Bisonte di Tuc d’Audoubert; nell’11.000 alla Scena rituale sul Monte
Pellegrino in Sicilia e verso il 7500 alle Impronte di mani in una
grotta in Argentina; nel 6000 le pitture essenziali in Sudafrica, nel
5000 i maestri iranici del vasellame a Samarra, il possente
Pensatore di Cernavodă della cultura Hamangia in Romania e la
Statuetta accosciata al museo di Volos in Grecia: tutte opere del
tempo lentissimo e immobile, ma con la concentrazione che fa
dell’attimo un’estasi, e fissa l’estasi nella contrazione e
nell’espansione dello spazio,
e la musica che è risuonata nei millenni in cui si dipingeva sulle
pareti delle caverne e sulle rocce del deserto, una musica che è
impossibile conoscere se non attraverso l’immaginazione, se mai
l’immaginazione avesse la forza di far sprigionare dal silenzio dei
millenni i suoni: suoni forse inauditamente lenti, o inauditamente
veloci, o inauditamente cacofonici, e certo niente che somigli a quel
quasi nulla che si è conservato nelle civiltà della scrittura e che è
stato chiamato «modo frigio e lidio»: eppure, per aiutare
l’immaginazione pensante a sprofondare nei sempre misteriosi e
discutibili inizi, esiste un piccolo libro di Marius Schneider: si intitola
La musica primitiva, e in esso si sostiene che i popoli delle epoche
preistoriche riconoscevano già che la sostanza stessa del Mondo è
suono, ma che solo nell’epoca delle civiltà situate all’incirca tra il
4000 e il 3000 avanti Cristo gli uomini cominciarono ad annotare
simboli e segni collegati ai suoni, segni e simboli che sono ormai una
lingua intraducibile: ma allora come riascoltare almeno in un’eco
mentale quei suoni smarriti? Secondo Schneider attraverso le tracce
lasciate dai miti sulla musica dei popoli etnologicamente definiti
«primitivi», le tribù e i nomadi e gli stanziali dei grandi continenti a
esclusione dell’antica Europa i cui suoni arcaici sono del tutto
perduti, tracce che però si possono ricostruire solo indirettamente:
«Potremmo paragonare questo lavoro alla ricostruzione di un dipinto
del quale esistessero ancora diverse riproduzioni mal conservate,
incomplete e ridotte in mille brandelli»; così scrive Schneider,
indicando un metodo rischioso ma che nelle sue mani fa traboccare
poco più di cento pagine in tutte le direzioni, generando un
incredibile numero di connessioni: e scopriamo, in mezzo a una rete
di echi e richiami, molte cose sorprendenti: che in Africa dio è un
flauto, in Asia Minore è un tamburo, in Egitto è un urlatore, ancora in
Egitto e poi in Cina è di nuovo un tamburo, in India è un tamburo e
un sonaglio, in Australia un rombo: e poi che il dio o gli dèi creavano
con il suono, che il suono generava il mondo, e che gli uomini
comunicavano con il mondo e gli dèi attraverso il suono come se
esso fosse un ponte: e poi che in America il dio creava il mondo
cantando tre volte, in Africa con uno schiocco delle dita, in Asia con
una sola sillaba vocale: e sempre e dovunque, a Nord e a Sud come
a Est e a Ovest, tamburi e flauti e voci scandivano la musica degli
inizi: e siamo immersi attraverso la musica nei Veda, nelle Upaniṣad
e nei riti e miti cinesi, ma anche nei miti Zulu, Aranda, Uitoto, Maori,
Dogon, Navajo,Warramunga, Sakai, Hopi, e passiamo dalle Samoa
alle Tonga, al Caucaso, al Giappone, al Niger: ma il suono, questo
suono arcaico, lo ascoltiamo? Forse sì, ma solo nella mente, come
un fantasma: perché ciò che si è conservato negli usi dei musicisti
realmente primitivi è poco, e le trombe tibetane o i tamburi africani
sono solo frammenti, spesso degradati, di un dipinto ormai perduto:
e allora forse da Schneider bisognerebbe passare con un salto
arrischiato all’Immaginazione, e sentirsi «dentro» quegli strumenti
che furono canne e ossa e pelli, e più essenzialmente battiti di mani
e di piedi danzanti, e voci, voci, voci: una musica che forse non si
risolveva mai, ma girava in tondo; o forse si snodava e strisciava,
come un serpente; o si interrompeva a un tratto, quando era stato
ottenuto lo scopo; una musica-religione; una musica-mito; una
musica-trance; una musica-poesia; una musica-lavoro; una musica
società; una musica-ebbrezza: suoni ormai inabissati nel silenzio più
assoluto, a meno che i corpi non procedano a riconoscere ciò che è
rimasto di quelle tracce negli strati della mente e del corpo, saltando
all’indietro nel Tempo attraverso il presente: allora percussioni e fiati
e voci direbbero che dietro lo scatenamento dionisiaco e tutti gli
scatenamenti arcaici c’era il ritmo, ossessivo, percussivo, ubriaco,
che provocava la rottura dell’Io e l’uscita da se stessi per ritrovare
l’Altro che è Me e Tutti: e se fosse così, i più vicini al senso fisico
della musica primitiva non sarebbero i suoni dei reperti etno
fonologici, oh no, ma Free Jazz di Coleman e Ascension di Coltrane,
Pangaea di Davis e The Black Saint and the Sinner Lady di Mingus,
Canti del Capricorno di Scelsi e No comment della Léandre, le
preghiere sgozzate di Evan Parker e l’ebbra droga di Cecil Taylor, e
tutti i fiati e le percussioni dei grandi improvvisatori-compositori
contemporanei, che sono discesi negli strati dei loro corpi fino a
toccare, come in uno specchio infranto e rovesciato, il suono della
preistoria: viscere e astri, animali e dèi, tamburi e sogni, sesso e
madri, magie e highways, defunti e infanti, urla e canti, numeri e
cibo, e battiti: il battere del piede e il battere della lingua, e il battito
dell’immaginazione che dà forma al Mondo nel ritmo primario, il
tempo che dalla materia viva di un corpo genera quella presenza
assenza acustica che è la musica: oh sì, si potrebbe provare a
risalire indietro nel tempo, anche se queste parole sulla musica degli
inizi sono forse solo una fantasia,
e il fuoco della bellezza nelle prime civiltà, un ritmo che accese le
immagini e alternò splendore e potenza in un unico respiro circolare:
nel 4000 avanti Cristo gli artisti del Niger con le grandiose Giraffe di
Dabous, e in Iran il Vaso di Susa; nel 3800 il Pendente maiale
dragone della cultura Hongshan; intorno al 3500 la cultura di Ozieri
in Italia, la straordinaria Figura in lutto in Egitto, gli artisti dell’epoca
Siyalk a Susa, gli artisti magnifici del Sudan, l’arte Yangshao in Cina
e il Vaso Chulmun in Corea; nel 3300 la vertiginosa Elsa di pugnale
in Egitto e nel periodo Uruk il Vaso di Warka in Iraq; nel 3000 il Toro
inginocchiato con vaso e la Leonessa di Guennol in Iran, la
stupefacente Dea madre nella valle dell’Indo e le cosiddette Belle
signore nel Ciad; gli scultori poeti delle Cicladi che nel 2600 avanti
Cristo conoscevano il gesto essenziale e il potere del vuoto nella
loro scultura: e poi il Maestro Goulandris e tutti gli altri; nel 2500 in
Iraq il sublime Ariete nel boschetto, l’Insegna di toro della cultura
Maikop in Russia e il Vaso con tori in Pakistan; nel 2400 la Statuetta
di cervo in Anatolia e la pittura della Caccia all’ippopotamo in Egitto;
verso il 2000 la Faccia di giada e la Coppa a stelo in Cina, i pittori
stupendi in Tanzania e in Namibia precursori di Paul Klee, e i grandi
creatori dell’Ecuador e della civiltà dell’Oxus in Battriana; nell’area
tra Creta, Cipro e Grecia la Brocca Kamàres nel 1700; la pittura
misteriosa a Creta, nel palazzo di Cnosso: la Scena con acrobati e
toro, suprema arte del movimento come musica; intorno al 1500,
nella zona iranica gli Elamiti e gli Accadi, e in Grecia il perfettissimo
Rhyton in forma di testa di toro, il Vaso con mietitura e la traboccante
Coppa Vaphio a Micene; nel 1400 il Sarcofago di Haghia Triada
nell’Egeo, intorno al 1300 l’insondabile Nefertiti del Nuovo Regno in
Egitto, nel 1200 gli iranici dell’epoca Mārlik, nel 1150 le Statuette Psi
in Grecia e l’Uomo e giovane seduti della cultura Xochipala in
Messico, e nel 900 in Grecia il Centauro di Lefkandì: un’immensa
spirale che non conosce luoghi e tempi, si concentra e si distende, e
parla la sua lingua di immagini che riposano in se stesse.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo