Legge e caso – Emanuele Severino
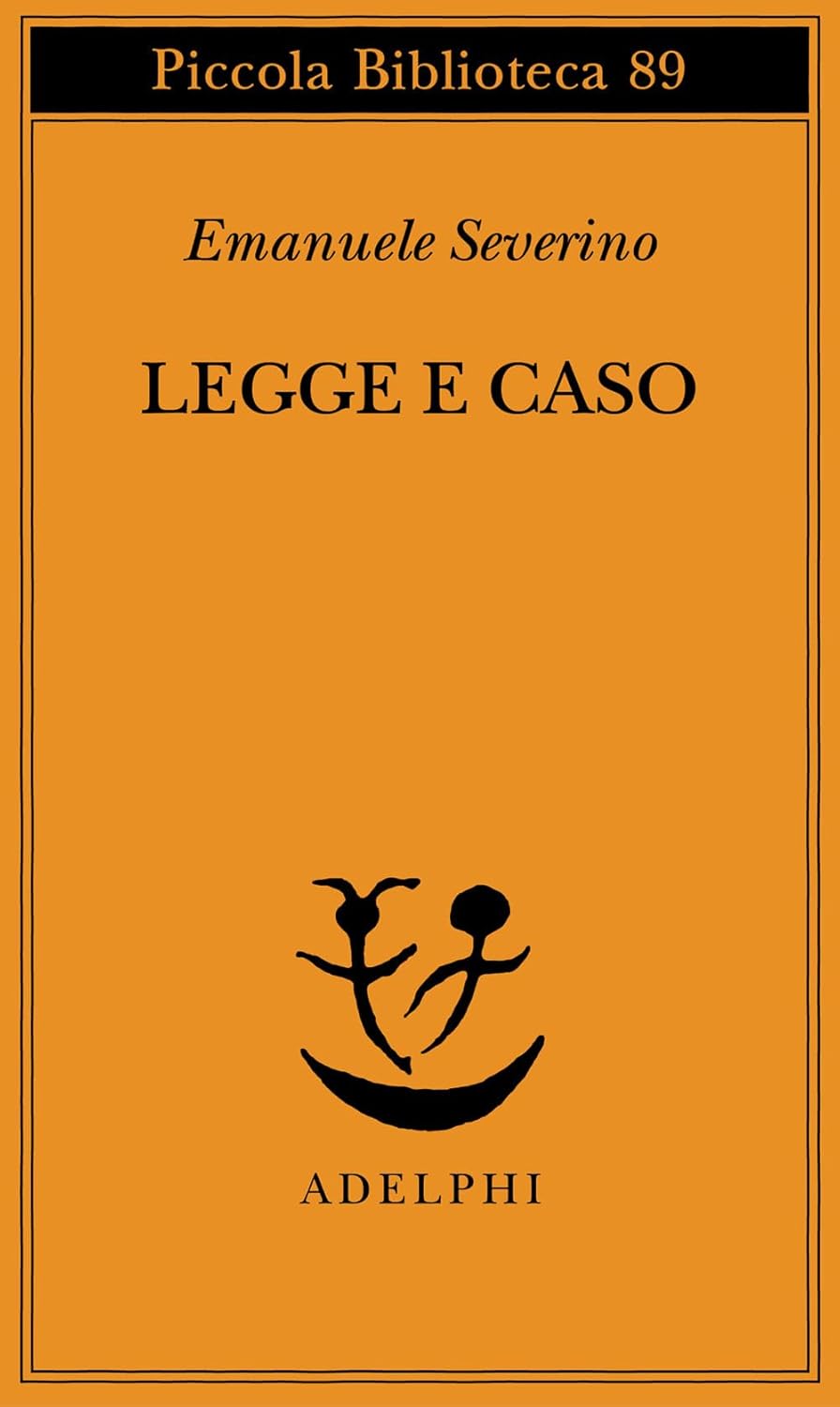
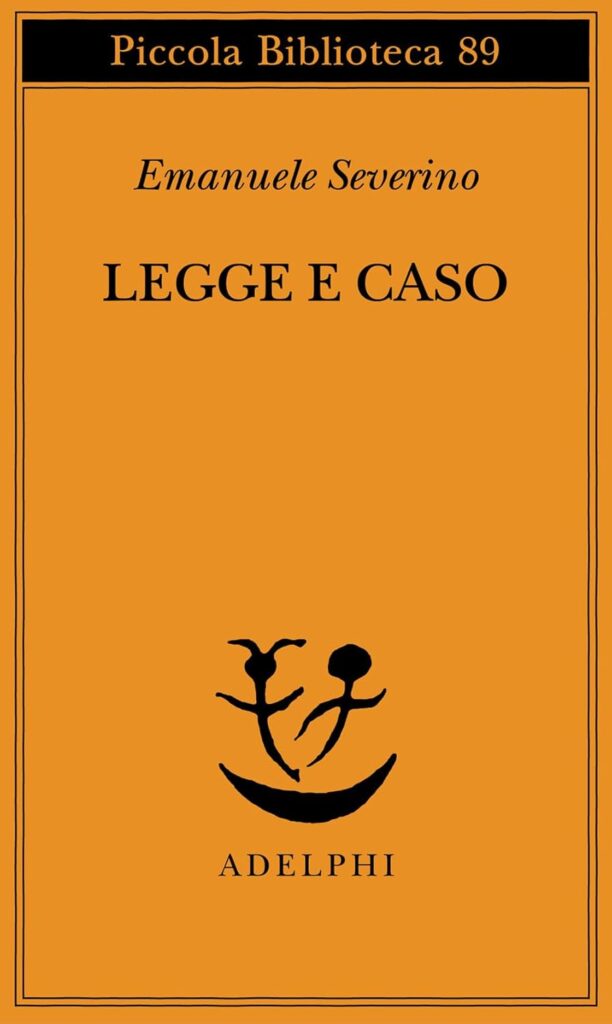
SINTESI DEL LIBRO:
In certi settori della cultura contemporanea è ancora diffusa la
convinzione che, una volta stabilita l’omogeneità e la convergenza di
scienza e dominio, risulti per ciò stesso evidente il carattere negativo
e alienante della scienza. Ma è appunto in relazione al senso del
negativo e dell’alienazione che le difficoltà diventano subito
insormontabili. Perché il dominio non deve essere esercitato? ed
esercitato senza limiti? Forse perché finisce col violare i diritti
dell’uomo? Ma quale conoscenza è ormai in grado di mostrare i veri
diritti e di stabilire il vero limite che divide il diritto dalla stortura
dell’uomo?
Nella storia dell’Occidente, la conoscenza che si è assunta il
compito di mostrare la verità è stata la filosofia, cioè la «scienza»
intesa non in senso moderno, ma come epistéme, ossia – secondo
quanto la stessa parola greca suggerisce – come conoscenza il cui
contenuto riesce a stare, imponendosi, fermo, su tutto ciò che
vorrebbe smuoverlo e metterlo in questione; e che appunto per
questo suo stare è verità.
Ma ormai la filosofia è morta; il sogno della verità definitiva e
incontrovertibile è finito non solo per le forze che promuovono la
costruzione della civiltà della tecnica, ma anche per tutte le forme di
umanesimo che, sebbene alimentate dalla morte della filosofia,
tuttavia si illudono di poter rivendicare i diritti dell’uomo contro la
violenza perpetrata dal sapere scientifico e dalla tecnica. Se il sogno
della verità è finito, allora la parola «verità» non può significare altro
che capacità di dominio, potenza, e la parola «errore» impotenza. La
«verità» di una teoria è decisa dallo scontro pratico con l’avversario.
Questo è anche il significato della seconda tesi su Feuerbach di
Marx. Ma questo significa anche che lo sfruttamento di classe e la
violazione dei diritti dell’uomo non sono sintomi di un’«ingiustizia»
la morte della verità dell’epistéme è insieme morte di ciò che la
giustizia in verità è –, ma sono sintomi dell’impotenza, cioè
dell’«errore» in cui si trovano le classi sfruttate e coloro che
subiscono violenza.
La scienza moderna, come struttura teorico-tecnica, è la forma
suprema di potenza e quindi di «verità» esistente oggi sulla terra. Le
forze della religione e della fede, della morale, dell’inconscio, del
sentimento, del pensiero ideologico e politico sono ormai impotenti di
fronte alla forza della scienza. Ciò non vuol dire che la scienza si
costituisca indipendentemente dalla società; e nemmeno che
l’organizzazione sociale non sia tuttora determinata da forze
religiose, morali, ideologiche, emozionali. Si vuol dire invece che
l’organizzazione della società e quindi della scienza stessa è oggi
tanto più efficace – tanto più potente – quanto più i criteri che
regolano l’organizzazione sociale vengono a coincidere con i criteri
della razionalità scientifica e dunque quanto più l’organizzazione e
l’amministrazione ideologica della scienza diventa organizzazione e
amministrazione scientifica della scienza.
II. La scienza moderna è la forma più potente di dominio perché è
la forma più potente di previsione. La previsione anticipa una
visione, che ancora non esiste perché o non esiste ancora l’oggetto
della visione, oppure perché ancora non esistono le condizioni che
consentono a tale oggetto di diventare visibile. La previsione si
costituisce non solo in rapporto al non esistere ancora della visione,
ma in rapporto a una visione che, nel prevedere, è concepita come
qualcosa che, prima o poi, incomincerà ad esistere. La previsione si
costituisce cioè all’interno dell’esperienza del divenire del mondo,
cioè all’interno del processo in cui incominciano ad esistere gli
oggetti della visione (o le condizioni che li rendono visibili). E la
visione è ciò che il linguaggio scientifico chiama «verificazione» o
«falsificazione» della previsione.
Ma il dominio è appunto dominio del divenire del mondo. Proprio
perché il divenire è l’incominciare ad esistere, il divenire è l’irruzione
dell’inatteso e dell’inaudito, ossia di ciò che per la sua radicale novità
e imprevedibilità minaccia ogni cosa esistente – minaccia l’esistenza
di ogni cosa. La volontà di salvarsi dalla minaccia del divenire è una
delle forme originarie di dominio. Ogni forma di salvezza (come ad
esempio la salvezza cristiana) appartiene alla volontà di salvezza
che coincide col dominio. Per salvarsi è necessario arginare la
minaccia del divenire, cioè controllarla, sottoporla a una legge e
dunque dominarla. E, viceversa, per dominare è innanzitutto
necessario non essere travolti dall’irruzione dell’imprevedibile e
dunque salvarsi da essa.
Ma proprio perché la minaccia è dovuta all’assoluta imprevedibilità
del divenire del mondo, per arginare la minaccia si deve rendere in
qualche modo prevedibile l’imprevedibile. L’argine ha la possibilità di
tenere, solo se le forze che premono su di esso non sono qualcosa
di assolutamente imprevedibile e di ignoto. Anzi, l’argine originario è
la previsione stessa, cioè la volontà di anticipare, ante-capere, pre
catturare gli eventi che sopraggiungono. La previsione implica infatti
che il divenire non sia più la visione terrificante dell’irruzione
dell’assolutamente inatteso, ma la visione di un processo che si
adegua al previsto e che proprio per questa adeguazione è
l’adeguarsi a un ordine, a una legge che non si lascia travolgere
dall’irruzione degli eventi, ma controlla, domina e dà un fondo
all’abisso del divenire.
III. Dire che la scienza è la forma più potente di dominio perché è
la forma più potente di previsione significa che la scienza sta al
termine della storia del dominio.
Già nella preistoria del dominio, presso i popoli che precedono la
storia dell’Occidente, la previsione domina l’irruzione del divenire
anticipando un ordine immutabile nella successione degli eventi.
Questa anticipazione trova la sua espressione fondamentale nel
mito arcaico dell’eterno ritorno. Le determinazioni archetipiche del
circolo cosmogonico sono l’ordine immutabile al quale ogni divenire
deve adeguarsi.
Ma solo all’inizio della civiltà occidentale, nel pensiero greco, vien
reso esplicito il senso di ciò che viene indicato dalle parole
«successione»,
«divenire»,
«ritorno»,
«evento»,
«ordine
immutabile», «eterno». È all’interno del senso greco di queste parole
che cresce l’intera civiltà dell’Occidente. Ed è appunto col pensiero
greco che, con un rigore e un’esplicitezza prima sconosciuti, la
previsione incomincia a dominare il divenire mediante l’evocazione
degli immutabili e degli eterni, ossia delle strutture che non sono
travolte dal divenire del mondo, ma arginano la sua minaccia e fanno
quadrato attorno a ciò che di volta in volta, per gli abitatori
dell’Occidente, vale come l’irrinunciabile. Prevedere significa volere
che il divenire (il tempo, la storia) si adegui all’ordine previsto; ma
questo ordine deve essere immutabile affinché la minaccia del
divenire non torni ad essere una possibilità reale.
A tal fine è necessario che non solo l’ordine previsto sia
immutabile, ma che anche alla previsione sia impossibile fallire e
mutare in una previsione diversa. La previsione dev’essere cioè
incontrovertibile e stare perciò ferma presso di sé. In quanto così
stante, la previsione supera l’instabilità del mito e diventa, appunto,
epistéme, cioè conoscenza che sta ferma, di contro (epí) a tutte le
opinioni contrastanti. Solo se la previsione è epistéme gli immutabili
e gli eterni che essa prevede non sono un’illusione. Ma la
preposizione epí non si riferisce soltanto alle opinioni contrastanti su
(epí) cui l’epistéme domina, ma si riferisce anche a tutti gli eventi che
possono sopraggiungere e sui quali, daccapo, essa domina.
L’epistéme domina su tutti gli eventi; è uno sguardo che anticipa il
tutto: tutto ciò che già esiste e tutto ciò che può esistere e che
ancora non esiste. La minaccia del divenire è vinta e non è
semplicemente differita, solo se la previsione epistemica getta il suo
sguardo sul tutto e non semplicemente su una parte, il cui ordine
potrebbe essere improvvisamente travolto dall’irruzione del non
previsto.
La nascita della filosofia consiste – stando alla ricostruzione
platonico-aristotelica – nella posizione del «principio» di tutte le cose
che nascono e muoiono, ossia nella posizione della unità immutabile
che raccoglie insieme tutte le cose divenienti, dalle più simili e vicine
alle più diverse e lontane – e che in quanto è questo «raccogliere» è
appunto λόγoς, legere, lex. Il «principio» è cioè l’ἀρχή che, come la
stessa parola greca dice chiaramente, domina e spinge il suo
dominio sino a raggiungere tutte le cose, anche quelle già morte e
quelle ancora non nate. L’intenzione originaria della filosofia è
certamente di svelare, manifestare, mostrare il principio di tutte le
cose; certamente, la filosofia vuol essere θεoρία, contemplazione,
visione. Ma proprio perché la θεoρία contempla ed è visione del
principio immutabile di tutte le cose, proprio per questo la θεoρία è la
previsione dell’ordine immutabile al quale devono adeguarsi tutte le
cose che nel divenire sopraggiungono, quindi è proprio per questo
che la pura θεoρία è dominio assoluto; il puro vedere è prassi, anzi
la forma più potente di prassi che nella storia dell’Occidente può
esistere prima dell’avvento della scienza moderna. Questo, anche se
il
carattere essenzialmente pratico della θεoρία rimane nascosto
nell’inconscio della θεoρία.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo